Tra ipnosi e logoramento, capitalismo e schizofrenia.
“Rumore bianco” è un manoscritto letterario del 1985, tradotto in Italia da Pironti 1987 e successivamente Einaudi 1989, dello scrittore americano di origine molisana, Don DeLillo, nato nel 1936 in un quartiere del Bronx da una umile famiglia di immigrati negli Stati Uniti dopo la Grande Guerra.
Perché parlare di DeLillo e di “Rumore bianco”? Forse sarà un pretesto, ma per dire cosa? Semplicemente per allargare l’orizzonte e scrutare la realtà attraverso una visione “libertinista filosofico-romantica”, un realismo metafisico pre-illuminista, tanto per intenderci pre-disciplinare, andando incontro a una mathesis storico-filosofica, tipica degli scienziati del seicento, in chiave armonizzante.
L’interesse per l’autore italo-americano, rimasto in sordina per molto tempo prima di essere tradotto e conosciuto anche nel suo Paese d’origine, come d’altronde è avvenuto per molti giganti della letteratura americana – Barth, Wallace, Pynchon, Auster, Franzen, ecc, ascrivibili al postmodernismo dei primi anni ’60 ‘70, autoreferenziali, relativisti e irriverenti – viene fuori proprio da un fatto di riconoscenza di questi ultimi, i quali sparsamente ammetteranno che lo scrittore che più li ha influenzati nella loro produzione letteraria è stato appunto Don DeLillo.
Ora, facendo un passo indietro, bisognerebbe aprire una finestra sul mondo, leggere e rileggere l’enorme produzione letteraria americana degli anni ’60 e ’70, prendere possesso dei frammenti dei vari autori sopracitati e, come in una sorte di bricolage, proiettarli verso una catabasi, una discesa agli inferi, in un viaggio tanto parossistico quanto reale (quindi postmoderno e, perché no, romantico) che abbracci, con critica feroce e radicale, il sogno (rimasto tale) del nuovo secolo americano.
Come dire: mentre la scuola dei Chicago boys (i terribili monetaristi cileni assunti da Pinochet) muoveva i suoi primi passi, il tubo catodico faceva breccia sulla cultura pop americana degli anni ‘60 ’70, con la sua massima espressione artistica, musicale e letteraria che veniva influenzata radicalmente dalla finzione via cavo, che si faceva carico del pensiero critico americano, imponendone così il modello capitalista feticista ed edonista borghese del trionfo di Van Miert, Burger king e FDA (Food and Drug Administration), diventando un tutt’uno sotto una veste semantico totalitaria.
L’opera letteraria dei vari DeLillo, Wallace, Pynchon, ecc. (l’elenco sarebbe interminabile), rappresenta il tentativo disperato di strappare questo “velo di Iside”(mito e verità), rallentando il moto perpetuo di una società “futura” proiettata al business as usual (amorfismo e ripetitività), prospera di fallimenti e distruzione sociale.
La loro estetica postmoderna, fatta di metanarrazione, decostruzionismo (della migliore specie francese) e realismo magico, che affonda le sue radici nel surrealismo, nel dadaismo e nello strutturalismo, nel post-strutturalismo e nella drammaturgia brechtiana, sembrerebbe essere svanita nel nulla, lasciata nell’oblio da intere generazioni che sono cresciute e pasciute facendosi cullare dal giogo borsistico di Wall Street e dalla gigantesca bolla del dollaro americano.
Passerà ancora del tempo prima di poter ammettere che il recupero del romanticismo, nella sua più squisita iperbole conservatrice di natura umile, valoriale, libertina e ribelle, possa avvenire solo passando o, meglio, attraversando la sterminata produzione postmoderna della letteratura americana.
“Rumore bianco” di Don DeLillo è una riflessione sull’ipnosi collettiva tardocapitalista, che ha come coordinate l’iperconsumismo e il progresso tecnologico. Allo stesso tempo è un compendio delle nevrosi che tratteggiano la normalità di una famiglia americana media, come miniatura di tutta la società: Jack Gladney, titolare di una cattedra di studi hitleriani, Babette, la sua quarta moglie dipendente dai farmaci, i numerosi figli avuti dai precedenti matrimoni.
Spicca tra tutti la figura del più piccolo, Wilder, figlio di Babette. È Wilder la spia del romanzo, occorre guardare lui per capire gli intenti di DeLillo. Si tratta di un personaggio che non ha altro scopo se non quello di incarnare tutto ciò che gli altri personaggi non sono più o non sono mai stati o non possono essere.
Conservo il sospetto che Wilder sia stato inserito da DeLillo in un secondo momento, utile a mostrare una via di uscita dal rumore bianco. La vita dei personaggi viene presentata, non senza ironia, all’interno di una nicchia protettiva, emblematizzata dalla collocazione in provincia e dal campus universitario in cui lavora Jack.
La voce narrante è sempre quella di Jack, sensibile ed acuto osservatore, sguardo introspettivo e analitico al tempo stesso, testimone e protagonista di più microcosmi esistenziali, tutti correlati e interdipendenti: il nucleo familiare, l’ambiente accademico in cui è inserito, il mondo sociale che lo circonda.
Jack e la sua famiglia rimangono il fulcro narrativo costante in un romanzo dall’intreccio insolito, costellato da eventi surreali come l’evacuazione in massa causata dalla fuoriuscita di un veleno tossico chiamato Nyodene D. (raccontata nella seconda parte), e le improbabili sperimentazioni farmacologiche di cui è vittima la moglie Babette, debole e smarrita cavia del farmaco dylar (raccontate nella terza parte), una medicina che dovrebbe eliminare dall’animo umano la paura della morte.
Il romanzo esordisce così, con frase asciutta, dal suono folk psichedelico: “Le station wagon arrivarono a mezzogiorno. Una lunga fila lucente che attraversò il settore occidentale del campus”.
Il protagonista e narratore prof. Jack Gladney osserva da lontano l’arrivo degli studenti al college: “luccicavano al sole come carovane nel deserto”, dirà due pagine dopo Jack a sua moglie Babette. Dalle auto schizzano fuori i ragazzi che cominciano a scaricare oggetti e prodotti, attrezzatura sportiva e personal computer.
Le madri li guardano partecipi e, giustappunto, materne, mentre i padri, leggermente più dietro, distaccati ma soddisfatti, osservano il frutto del loro seme procedere verso il futuro: “I genitori se ne stanno lì, abbagliati dal sole, accanto alle auto, vedendo immagini riflesse di se stessi in tutte le direzioni.”
Questo di DeLillo è l’inizio di un viaggio in un universo di figure e finzioni, di doppi che si uniscono, di simboli, di segni, dove al “rumore”, caratterizzato dall’assenza di periodicità del tempo, si frappone un fugace desiderio di sradicamento, da ogni forma di pensiero unico totalizzante.
La narrazione assume presto i toni di una allucinazione iperrealistica, “ci sono personaggi più grandi della vita. Hitler è più grande della morte. E tu pensavi che ti avrebbe protetto. Lo capisco perfettamente”, nella quale alcuni soggetti semi-morti che cercano ossigeno nei centri commerciali delle grandi città (visti come templi religiosi) si scontrano un po’ per volta con altri zombie, che DeLillo ha voluto vedere nella casta intellettuale dei docenti universitari.
Ma non ne scaturisce certo una lotta di classe. Al contrario, la minaccia del pericolo concreto (una nube di gas forse mortale, forse no, fuoriuscita da un incidente aereo) smonta tutti i personaggi mostrandone l’immensa miseria umana e quasi facendoli sentire di nuovo parzialmente vivi.
Non è certo un caso, se il prof. Gladney è uno studioso dell’ideologia che per eccellenza ha sacralizzato la morte, il nazismo, ma in realtà continua a millantare un credito che non possiede realmente: è anche lui uno zombie che non ha capito di essere morto da molto tempo, come tanti docenti universitari!
Un’idea favolosa che l’autore sa sviluppare con una freddezza e una spietatezza assolute, senza alcuna empatia. E così deve essere.
Decisamente postmoderno, a tratti romantico, apocalittico e geniale. Caustico e feroce nel descrivere le persone e le loro debolezze e paure. Un romanzo sulla vacuità della società moderna, sul consumismo esasperato per nascondere la paura della morte, l’unico vero motore del mondo; le luci della TV e i prodotti colorati del supermarket, moderna arma per coprire il rumore “bianco” di sottofondo, sempre presente.
La stessa realtà della merce su cui si riversa la compulsività umana tradisce un vuoto di significato, motivo per cui gli oggetti vengono investiti di un’aura sacrale, come risulta evidente in questo passaggio che si svolge in un centro commerciale:
“Comperavo con abbandono incurante. Comperavo per bisogni immediati ed eventualità remote. Comperavo per il piacere di farlo, guardando e toccando, esaminando merce che non avevo intenzione di comprare ma che finivo per acquistare. […] Cominciai a crescere in valore e autoconsiderazione. Mi espansi, scoprii nuovi aspetti di me stesso, individuai una persona della cui esistenza mi ero dimenticato. Mi trovai circondato di luce”.
Dal “lo scambio simbolico e la morte” di Baudillard, fino alla “vita liquida” di Bauman, passando per “la condizione postmoderna” di Lyotard, senza dimenticare “benvenuti nel deserto del reale” di Zizek e “capitalismo e schizofrenia” di Deleuze-Guattari, sorvolando “America oggi” di Altman e atterrando su Godard... sono molti i riferimenti bibliografici e cinematografici su cui potersi cimentare.
La morte diventa il tema centrale dell’opera, intesa non tanto come fine della vita o come passaggio meritevole nell’eden dell’oltretomba, ma come svilimento, come metafora di un mondo lobotomizzato che beato e sorridente s’accompagna verso il precipizio.
Così come il tema del nazismo, non distante dal tema della morte e non distante nemmeno dal tema di uno Stato neoliberista che lo ha sostituito dalle sue fondamenta, finendo per incorporarlo.
E non ci sarebbe nemmeno bisogno di scomodare testi storici o filosofici che legano con una certa continuità e insistenza la crisi dello stato liberale, la distruzione dello stato sociale e l’avvento di uno Stato razionalista puro, portato all’eccesso (anni ’20 e ’30), ossia il nazismo come forma di transizione verso la rinascita dello stato liberale, democratico parlamentare, ma basterebbe leggere l’indice di mortalità infantile in Grecia nell’ultimo quinquennio, dove a colpi di memorandum e austerità è stata rasa al suolo la culla dell’occidente, in nome di una suprema razionalità contabile.
È come ammettere, leggendo tra le pieghe di parole del romanzo di Don DeLillo, e dell’esperto prof. Gadney di cui, senza conoscere il tedesco diventa portavoce ufficiale del meif kamp, che il dispositivo mitico del nazismo è decostruito in un percorso che procede storicamente di rappresentazione in rappresentazione, dall’Impero Romano alla società esportata da Napoleone, per far sì che le nostre coscienze di uomini europei siano torturate da un pensiero morale che ci perseguita: la nostra relazione personale con il mistero tremendum et fascinans del potere.
Una posizione che molto ha da condividere con la tragica visione dell’Angelus Novus di Walter Benjamin, un guardarsi indietro per fare un passo che vada oltre il culto della forza. Se nemmeno alle macerie delle distruzioni conquistatrici è, in fondo, concessa una vera testimonianza di sé e vengono sempre rimosse per costruire nuovi monumenti di potere, ci troveremo sempre disarmati, nudi e crudi, di fronte all’ondata degli eventi.
Del tema della morte, sembra dirci DeLillo, ci si sazia a godimento, specie se questo asciutto desiderio (finché rimane tale), mediato da schermi ultrasottili di tv led e a plasma, non invade le nostre coscienze ammansite, la nostra quiete familiare mantenuta irta tra snack in sosta ai centri commerciali e dosi massicci di barbiturici, allora tutto si rimette in gioco, la realtà prende il sopravvento sulla finzione. E la paura è autocoscienza portata a un livello più elevato.
L’unico modo per vincere la paura della morte sta tra i cavi elettrici, le onde radio televisive, gli elettrodomestici, i telefoni, tra il rumore bianco di tutto ciò che attraversa l’etere, lo spazio e i corpi, si spande in sonoro ciò che avvolge tutto e tutti.
La difficoltà di comprensione della verità che riguarda le cose, sembra dirci DeLillo, è legata anche a quella dei disastri: quanto sono reali e quanto nascono dalle nostre paure? Si profila l’ipotesi di una dipendenza dagli eventi tragici che in qualche modo restituisca dimensionalità a una realtà appiattita, dove tutto è “rumore bianco”: “di quanto in quanto abbiamo bisogno di una catastrofe per spezzare l’incessante bombardamento di informazioni”.
Il manoscritto si divide in tre sezioni o temi o frammenti, chiamateli come vi pare: la “salubre” vita tra college e centri commerciali (dal titolo onde e radiazioni); (l’avvento della nube tossica) e il pericolo di morte; il crollo della quiete familiare tra ossessione e depressione (Dylarama).
Ma basta leggere il breve primo capitolo per vedere sfilare più o meno discreti tutti i temi del romanzo, i quali potrebbero essere riassunti con la dicotomia (a limite della banalità) luce-tenebra.
La luce che rassicura, a dire il vero più che rassicurare intontisce; l’isteria della luce e quel che accade quando le luci si spengono, perché Jack, oltre a essere un professore, di notte diventa un’altra persona, una poltiglia fragile e sudata: è ossessionato dalla morte, come, purtroppo, tutti coloro che la propria vita non riescono a vivere.
Gli capita di svegliarsi col cuore che gli scalcia nel torace perché teme di morire; fa di tutto, e tutto ovviamente andrà storto, per trascorrere una vita senza vita. Spera che standosene buono, in una città di provincia, nascosto dalla routine, al riparo di una moglie dal corpo ampio e dai grandi seni materni, la morte non si accorgerà di lui. O, detto altrimenti: spera che la vita, e tutto quel che implica viverla, non vada a stanarlo.
Ma quando è lontano dal college, quando la maschera di professore gli cade, vive un sentimento di confusione e smarrimento, è avvolto da un’atmosfera di costante eclissi. E trova rifugio ricorrendo con avanzo schizofrenico al processo postmoderno per eccellenza di gratificazione e autostima della persona: lo shopping sfrenato.
Jack, umiliato e ferito dopo un incontro con altri accademici, si reca al Mall, tempio consumistico americano per eccellenza, con tutta la famiglia, immancabile contorno costante al personaggio, e compie la sua rigenerazione interiore: “Babette e i ragazzi mi seguirono nell’ascensore, nei negozi disposti lungo le gallerie, negli empori e nei grandi magazzini, perplessi ma eccitati di fronte alla mia voglia di comperare. Se non riuscivo a decidere fra due camicie, mi incitavano a comperarle entrambe. Se dicevo che avevo fame, mi riempivano di pretzel, birra, suvlaki. Le due ragazzine (...) erano le mie guide al benessere senza fine.”
Lo shopping, pertanto, rappresenta per il soggetto postmoderno l’immediata, facile e rassicurante pratica di costruzione del sé, fonte accessibile e veloce di conferme e rassicurazioni consolatorie.
Non esistono più progetti esistenziali da perseguire, valori supremi da realizzare, non ci sono competenze da provare, né rituali d’azione performanti da porre in atto, paradossalmente non esiste più un vero ed univoco nemico da fronteggiare, perché in età postmoderna, come ci insegna DeLillo, tutto ciò che ci indebolisce è sommerso, nascosto, pericolosamente invisibile e latente.
Questo è il modello di cui in Occidente andiamo fieri e che difendiamo, a costo d’imbarcarci in campagne militari. Un modello, di cui il Capitalismo non è sovrastruttura, ma il mostro pantagruelico che ci divora da dentro.
L’eroe è morto, non ha più strumenti, programmi esistenziali e così anche narrativi, ed al suo posto è rimasto solo un individuo indebolito, precario, frammentato dalle mille e più rappresentazioni della realtà circostante, un soggetto la cui ultima abilità è quella di comprare a dismisura, solo così il suo fragile ego può raggiungere un seppur momentaneo, appagamento, un senso ludico ed euforico di piacere.
È forse questa l’evoluzione storica inevitabile dei grandi magazzini raccontati a fine secolo da Zola? Il “paradiso delle signore” si è forse trasformato in un inferno commerciale talmente violento da diventare luogo di morte? È la legge nuda e cruda di Monsieur Capital!
Pubblicità e beni di consumo sono forse le armi sottili di un sistema capitalistico potente e logorante in grado di depauperare e svilire anche l’uomo più forte? La pressione semiotica, la ridondanza segnica, il proliferare incessante di simulacri hanno raggiunto proporzioni tragiche e tutto questo, non è altro che una parte del grande mistero americano, un mistero che DeLillo in "Rumore bianco" racconta a perfezione.
Il postmoderno ha trasformato il televisivo in sacro, la pubblicità in un universo mitico e trascendente, il mondo mediatico in un sistema simil-religioso che detta emozioni, sentimenti, regole di rappresentazione delle cose e degli eventi, un mondo che detta inesorabilmente la realtà e le modalità per percepirla e codificarla.
“Guarda quant’è luminoso. È pieno di dati sovrannaturali. (…) guarda com’è tutto ben illuminato. Questo posto è sigillato, conchiuso in sé. È senza tempo.” E subito dopo DeLillo, attraverso Jack, evidenzia la sottile connessione che lega il consumismo al depauperamento della soggettività, alla frustrazione profonda dell’individuo contemporaneo: “morire in Tibet è un’arte (…) qui non moriamo facciamo acquisti. Ma la differenza è meno marcata di quanto si creda".
Buona lettura.
Fonte

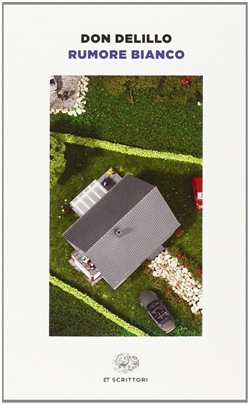
Nessun commento:
Posta un commento