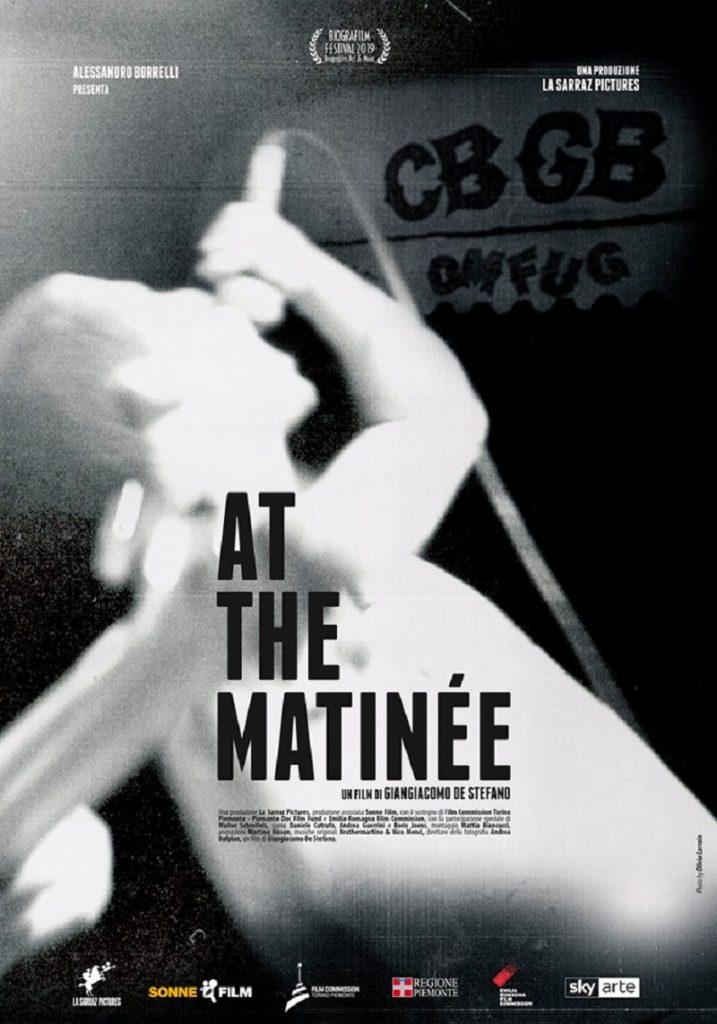Se andate sul sito della Smeg, quella degli elettrodomestici, troverete un’ampia pagina dedicata ad una bella e variopinta collezione di frigoriferi. Sono elettrodomestici “vestiti” come carretti siciliani.
Il sito dice, testualmente, “firmate Dolce & Gabbana”. Che sarebbero quei due stilisti che avete visto in tempi recenti chiedere scusa all’intera Cina per aver offerto un cannolo troppo grande ad una loro concittadina.
In realtà la firma su quelle opere d’arte è quella di Alice Valenti, pittrice catanese che mantiene viva la grande tradizione pittorica-popolare della sua terra, quella dei decoratori di carretti e degli illustratori dei pannelli per i cantastorie. L’ultima sua firma si trova anche in calce ad un’altra opera d’arte: il nuovo album di Giacomo Sferlazzo, il Mangiafuoco di Lampedusa.
Un ulteriore tocco di colore ad una musica che di colori è già piena. Un’identità che si incontra con le identità di altri paesi, in quel porto culturale che è diventata la sua isola. Un’identità guerriera che Sferlazzo mostra più nella vita di tutti i giorni che nella sua vita da poeta musicista.
Un lampedusano che ha dovuto indossare una corazza per proteggere i diritti calpestati di una terra che è diventata terra di conquista, indotto stagionale ed equivoco per lavoratori precari, punta estrema di un’Italia che, se vuole accogliere, molto spesso non sa come gestire l’accoglienza.
Un lampedusano che lotta per riaffermare l’identità della sua isola, riavviare il processo di memoria che sembra arrestarsi per il resto del mondo all’epoca dei primi sbarchi di extracomunitari, come se prima di allora Lampedusa fosse solo uno scoglio sperduto e disabitato nel Mar Mediterraneo.
Il suo lavoro musicale è plurivalente: Sferlazzo non è un semplice cantastorie e le sue non sono semplici canzoni della memoria o di protesta.
Sono canzoni “imbrattate” come i muri delle nostre città.
Sporche come le nostre strade.
Legno e metallo, infinite gallerie di tarli e ruggine corrosiva convivono senza mai abbracciarsi veramente, in un rapporto stridente come quello che viene fuori da pezzi come Ventu o Arrispigghiativi.
Anche nei brani più tradizionali, e qui ce ne sono diversi, Giacomo Sferlazzo ha sempre qualcosa di sgraziato, di poco rassicurante, di disobbediente.
Come a dirci che nessuno è al sicuro, neppure quando celebriamo l’eterno rituale del ricordo. Che bisogna lasciare sempre una porta aperta, una via di fuga, lanciare uno sguardo oltre il muro. Che se dormiamo, è il momento di svegliarsi.
Fonte
30/06/2019
Domenica bestiale
Per Salvini è sempre domenica. Di mestiere fa l’hater sui social. Ingurgita grasso, e sputa veleno. È il suo metabolismo.
È un Omeoleader.
Negli anni ’60, Philip K. Dick anticipò nei suoi romanzi l’idea di Google e affini di compilare e fornire rassegne di contenuti – e pubblicità – calibrate sui gusti del singolo lettore, registrati ed elaborati in base alle ricerche, e alle pagine visitate. PKD lo chiamava l’Omeogiornale, il giornale su misura del lettore.
Matteo Salvini è un Omeoleader. “La Bestia”, l’algoritmo che registra ed elabora le opinioni sui social per estrapolare quella dominante, gli fornisce ogni giorno il copione che deve recitare per piacere alla maggioranza relativa degli italiani.
Salvini ha anche un paio di opinioni personali, le conosciamo: Forza Milan e Mangio Gratis (ha debuttato come concorrente a Il Pranzo è Servito), razzismo da stadio, e fancazzismo, mentre il suo “programma di governo” è in realtà lo stesso che la Lega ha da sempre: togliere ai poveri per dare ai ricchi.
Tutto il resto è deciso dalla Bestia.
E il numero della Bestia è un frattale, grazie al quale Salvini è diventato l’incarnazione del Senso Comune, che assorbe come una spugna, e che lo rende pericoloso molto al di là della sua personale mancanza di umanità.
Quel Senso Comune che dava agli untori la colpa della Peste trasmessa dai topi, che proliferavano indisturbati, mentre i gatti venivano sterminati perché considerati animali diabolici succubi delle streghe.
Quel Senso Comune che oggi dà ai migranti tutta la colpa del degrado di periferie urbane che hanno cominciato a degradare 50 anni fa, perché costruite come quartieri dormitorio per una classe operaia da sfruttare 18 ore al giorno, e poi abbandonati all’incuria e alle mafie locali.
Quel Senso Comune che insulta chi salva i naufraghi, e applaude chi spara alle spalle.
Che preferisce sempre perseguitare il capro espiatorio di turno, che sfidare il potente vero colpevole, preferisce sempre credere alla bugia più comoda, che accettare la scomoda verità.
Quel Senso Comune diffuso adesso dai social come la Peste dai sorci.
Quel Senso Comune che è la vera Bestia, e che oggi s'incarna in Salvini usandolo come vascello. Come taxi del Male.
Fonte
È un Omeoleader.
Negli anni ’60, Philip K. Dick anticipò nei suoi romanzi l’idea di Google e affini di compilare e fornire rassegne di contenuti – e pubblicità – calibrate sui gusti del singolo lettore, registrati ed elaborati in base alle ricerche, e alle pagine visitate. PKD lo chiamava l’Omeogiornale, il giornale su misura del lettore.
Matteo Salvini è un Omeoleader. “La Bestia”, l’algoritmo che registra ed elabora le opinioni sui social per estrapolare quella dominante, gli fornisce ogni giorno il copione che deve recitare per piacere alla maggioranza relativa degli italiani.
Salvini ha anche un paio di opinioni personali, le conosciamo: Forza Milan e Mangio Gratis (ha debuttato come concorrente a Il Pranzo è Servito), razzismo da stadio, e fancazzismo, mentre il suo “programma di governo” è in realtà lo stesso che la Lega ha da sempre: togliere ai poveri per dare ai ricchi.
Tutto il resto è deciso dalla Bestia.
E il numero della Bestia è un frattale, grazie al quale Salvini è diventato l’incarnazione del Senso Comune, che assorbe come una spugna, e che lo rende pericoloso molto al di là della sua personale mancanza di umanità.
Quel Senso Comune che dava agli untori la colpa della Peste trasmessa dai topi, che proliferavano indisturbati, mentre i gatti venivano sterminati perché considerati animali diabolici succubi delle streghe.
Quel Senso Comune che oggi dà ai migranti tutta la colpa del degrado di periferie urbane che hanno cominciato a degradare 50 anni fa, perché costruite come quartieri dormitorio per una classe operaia da sfruttare 18 ore al giorno, e poi abbandonati all’incuria e alle mafie locali.
Quel Senso Comune che insulta chi salva i naufraghi, e applaude chi spara alle spalle.
Che preferisce sempre perseguitare il capro espiatorio di turno, che sfidare il potente vero colpevole, preferisce sempre credere alla bugia più comoda, che accettare la scomoda verità.
Quel Senso Comune diffuso adesso dai social come la Peste dai sorci.
Quel Senso Comune che è la vera Bestia, e che oggi s'incarna in Salvini usandolo come vascello. Come taxi del Male.
Fonte
“Rigenerazione urbana”? Un facilitatore per rendite e capitali
di Sergio Brenna
Il Disegno di Legge n. 113 del 23.03.2018, d’iniziativa del deputato Morassut del PD ed ex assessore all’urbanistica a Roma con Veltroni ora in discussione alla Camera, è l’ennesimo tentativo surrettizio per trasformare il ruolo dei Comuni nel definire un urbanistica pubblica, in regolatori/facilitatori del traffico di rendite e capitali.
Era stato già tentato nel dicembre 2005 dalla “strana coppia” di deputati milanesi Lupi (FI/Pdl) e Mantini (Margherita/PD) con il loro libro “I nuovi principi dell’urbanistica” (ma forse intendevano “I nuovi prìncipi dell’urbanistica”!) e con un loro DDL approvato da un ramo del Parlamento e caduto solo per fine legislatura nel 2006, cui nella legislatura successiva tentarono di dare seguito presentando DDL distinti, ancorché ispirati da forti affinità elettive nei contenuti.
In occasione della presentazione del libro e dei dibattiti parlamentari essi raccolsero con favore alcuni interventi che indicavano il nucleo fondante dei nuovi principi nell’abbandono di un progetto pubblico dell’uso di città e territorio, tipico della visione a loro avviso obsoleta dell’urbanistica e nell’avvento della nuova visione “dell’economistica”.
Non deve quindi sorprendere che in quella legislatura a promuovere l’evoluzione dell’urbanistica in economistica fosse, ancor più che un DDL sul governo del territorio, il Documento Economico Programmatico Finanziario del Ministro dell’Economia Tremonti approvato dal Governo per decreto-legge nel 2008.
Tremonti, del resto, aveva già dato prova del suo modo di considerare subalterno l’uso della risorsa territorio alle contingenti esigenze del bilancio economico quando, nel 2005, in risposta a un quesito dell’Associazione Nazionale delle Tesorerie al Ministero delle Finanze sulla mancata riproposizione nel TU sull’edilizia (DPR n. 380/2001, a seguito della Riforma Bassanini delle procedure amministrative) dell’obbligo imposto dalla L. 10/77 (Bucalossi) di allocare gli oneri di urbanizzazione in apposito capitolo di bilancio vincolato all’esecuzione di opere di urbanizzazione, fece rispondere che se nel TU quel disposto non era stato riportato (anche se illegittimamente !), l’obbligo doveva considerarsi decaduto.
Si aprì per i Comuni la manna della possibilità di far fronte alle ristrettezze contingenti dei bilanci, “vendendo” nuove possibilità edificatorie. Nemmeno il Governo Prodi pose rimedio a questa illegittima stortura, che è proseguita sino allo scorso anno.
Nel marasma dell’attuale innaturale alleanza di governo/contratto tra Lega e M5S non sorprende che tutto ciò si ripresenti di nuovo sotto le false vesti di necessità di innovazione.
Gramsci in una nota scritta in carcere nel 1930 (A. Gramsci, Quaderni dal carcere Q 3, §34, p. 311) osservava: “La crisi consiste appunto nel fatto che il vecchio muore e il nuovo non può nascere: in questo interregno si verificano i fenomeni morbosi più svariati”; una considerazione che è purtroppo ancora oggi particolarmente attuale. Se non saremo in grado di far nascere una più razionale organizzazione della società, sulle rovine dell’attuale, andremo incontro a un’epoca ancora più oscurantista e imbarbarita della presente.
A proposito di Rigenerazione urbane e progetto pubblico di città e territorio, ricordo che De Mico (finanziere milanese dell’era Craxi e della “Milano da bere”, ndr) sull’area della ex stazione delle Varesine a Milano – poi divenuta parte dell’oggi decantato Porta Nuova Project, via via di proprietà di Hines/Catella/Fondo Sovrano Qatar – ottenne a suo tempo dal Consiglio di Stato una sentenza che, in base ad una perizia tecnica molto controversa, gli consentiva una volumetria di circa 240.000 mc.
Che ciò dovesse necessariamente corrispondere a 80.000 mq di GFA/slp (superficie lorda di pavimento) non era per nulla scontato, sapendo che ciò inevitabilmente comportava doverla accatastare in edifici molto alti; ovviamente invece quella era la scelta immobiliarmente più facile e gradita alla proprietà, trattandosi così di spazi alti circa 3 metri, indifferentemente fungibili a uffici o residenza secondo le fluttuazioni di mercato.
Un’Amministrazione comunale non arrendevolmente succube avrebbe potuto imporre scelte tipologiche tali che, a pari volumetria, corrispondessero edifici di minor altezza e minor GFA, come ho dimostrato possibile in alcuni schizzi di studio pubblicati in un mio libro.
Se qualcuno poi mi obiettasse che si tratta di fantasie da accademico vada a vedersi le immagini dei nuovi uffici del Ministero delle Finanze francese a Bercy (prog. Paul Chemetov) e il Markthall di Rotterdam che sono realmente costruiti e perfettamente funzionanti.
Altrettanto si può dire per la proposta Parco Possibile di Jacopo Gardella e Pierfrancesco Sacerdoti, che sul resto dell’area proponeva di riarticolare le medesime volumetrie previstevi in edifici bassi lungo gli assi del cardo-decumano milanese, concentrando gli edifici alti in posizioni appartate. Anche questa totalmente ignorata dall’Amministrazione comunale dell’epoca Moratti-Masseroli, che lasciò mano completamente libera alle “fantasie immobiliaristiche” di Hines-Catella coi vari Diamantoni, Solaria, Siringa, Bosco Verticale, Nido falloforico e via vaneggiando.
Fonte
Autostrade, l’unica gallina dalle uova d’oro dei Benetton
A volte viene da ringraziare il “giornale dei padroni” per antonomasia – IlSole24Ore, organo di Confindustria – per il solo fatto di esistere. Perché fare informazione utile per le imprese significa, al contrario di quel che avviene per altri media, molto più “ideologici”, dare notizie vere, numeri, percentuali. Dati, insomma.
L’articolo pubblicato oggi sulla galassia dei Benetton, che sotto vi riproponiamo, dà un quadro preciso sia della struttura dei bilanci delle varie società, sia della natura reale di quelli che un tempo erano degli industriali del “golfino” trendy. Al di fuori del chiacchiericcio tra Di Maio (“azienda decotta, non si può occupare di Alitalia”) e il suo trasudante sodale di governo.
Dal quadro emerge che Atlantia – la società che gestisce in concessione Autostrade per l’Italia – pesa per più del 50% del fatturato della holding di famiglia. Ma soprattutto rappresenta tutti gli utili (profitti) dei soci di Edizione (il gruppo ristretto degli azionisti “familiari"). La citazione è meritata:
Idem anche per le altre attività rilevanti (aeroporti di Roma, Costa Azzurra e Saint Tropez), nonché per la partecipazione in Getlink (il tunnel sotto la Manica).
In pratica, ci dice Antonella Olivieri, se viene ritirata dallo Stato la concessione di Autostrade per l’Italia, per Atlantia è notte fonda. I Benetton, infatti, fanno i soldi soltanto così ormai: gestendo al risparmio infrastrutture a pedaggio (in Germania le autostrade sono gratuite o con abbonamento annuo inferiore alla tariffa di una sola corsa Roma-Milano), costruite con i soldi degli Stati e poi “privatizzate”.
In omaggio, ricordiamo, a quell’adagio assolutamente ideologico che recita: “i privati lo fanno meglio”.
Come abbiamo visto con il ponte Morandi a Genova.
La concessione è datata 1999, ma i Benetton si sono ben guardati dall’intervenire su una struttura che già allora mostrava seri segni di usura. “Meglio” incassare i soldi al casello, finché sta in piedi, vero?
Fuori da ogni “logica di mercato”, al riparo da ogni “concorrenza” (nessuno costruirà mai un’autostrada su un percorso dove già ne esiste una), con la garanzia di aumenti annuali delle tariffe ben al di sopra del tasso di inflazione, ecc.
Atlantia (e i Benetton) sono il paradigma di cosa è diventata la “grande imprenditoria italiana”: capitalismo “bollettaro” (che fa i soldi con bollette e pedaggi) in stile Ghino di Tacco, parassitario, socialmente irresponsabile, ma abilissimo a sfruttare gli “agganci” con le cordate politiche momentaneamente al potere.
*****
Perché il business di Autostrade è cruciale per i Benetton
di Antonella Olivieri
La minaccia per il gruppo Benetton è seria. Il bilancio consolidato di Edizione – i dati del 2018 sono stati elaborati con l’ausilio di R&S-Mediobanca – dipende infatti ancora in larga misura da Atlantia, tanto che, rispetto a un giro d’affari complessivo di 12.587 milioni, l’utile netto della holding della famiglia di Ponzano Veneto – 1.083 milioni – è spiegato interamente dalla società infrastrutturale che fattura 6.384 milioni al netto del canone di concessione di 532 milioni.
Tolte le quote di competenza terzi, Atlantia produce per i suoi azionisti profitti netti per 818 milioni, ai soci di Edizione – che detiene il 30,25% del capitale della società infrastrutturale – ne spettano 197.
In altre parole, senza Atlantia gli utili sparirebbero, perchè gli 86 milioni di competenza dei soci di Autogrill non basterebbero nemmeno a compensare le perdite dell’attività storica, con Benetton e la sua costola Olimpias che hanno chiuso in perdita rispettivamente per 115 e 11 milioni (il gruppo dei maglioncini è in rosso costante dal 2013).
Per contro sparirebbe anche il 98,5% del debito finanziario che assomma per Edizione a 47,99 miliardi.
Atlantia non può certo dirsi un’attività decotta, con un margine operativo lordo di 4.149 milioni, che sfiora il 65% dei ricavi netti. A sua volta, in Atlantia è preponderante il peso di Autostrade per l’Italia (Aspi) che, con 3.489 milioni, contribuisce al 54,7% delle entrate, e, con 1.765 milioni, al 64,2% del margine operativo netto.
A livello di risultato netto, dei 1.083 milioni di Atlantia, 622 (il 57,4%) vengono dai pedaggi italiani.
I conti del 2018 consolidano solo per due mesi la neo acquisita Abertis (50% più un’azione) che, a partire dal prossimo anno, avrà l’effetto di diluire il peso dell’Italia. Pro-forma – se cioè il gruppo spagnolo fosse stato consolidato dall’inizio del 2018 – il fatturato netto di Atlantia quasi raddoppierebbe, passando da 6.384 a 11.344 milioni e il margine operativo lordo salirebbe da 4.149 a 7.307 milioni.
Le attività aereoportuali – il 99,38% di Aeroporti di Roma (Fiumicino e Ciampino), il 64% di Costa Azzurra e il 99,94% dell’Aeroporto di Saint Tropez – pesano ancora relativamente poco: appena il 12% dell’intero fatturato consolidato di Atlantia, con un apporto di 834 milioni al netto delle rettifiche infragruppo.
Un altro pizzico di estero nel portafoglio di Atlantia è il 15,49% di Getlink (che esprime però il 26,64% dei diritti di voto), società che gestisce il collegamento sottomarino della Manica, per un valore a patrimonio netto di 1.041 milioni. Ma complessivamente, tra autostrade e aeroporti, oltre il 70% del giro d’affari di Atlantia – nei conti 2018 – ha origine ancora nella Penisola.
Al piano superiore, quello di Edizione, la diversificazione al momento è poco più che un accenno. Dall’operazione Abertis il gruppo ha ereditato anche il 29,9% di Cellnex (detenuto tramite Connect), un ritorno alle tlc, ma nel business meno volatile delle torri per la telefonia mobile (la società catalana ha rilevato in Italia buona parte della rete di Wind). Cellnex, che nel bilancio di Edizione è consolidata a patrimonio netto, è comunque ancora una realtà relativamente piccola con 867 milioni di fatturato netto, un margine operativo lordo di 516 milioni, un margine operativo netto di 113, un risultato netto di 18 milioni e utile di competenza dei soci di 15 milioni.
Gli unici investimenti finanziari – oltre al neo acquisto di poco meno del 3% di Prysmian – sono quelli della filiera Mediobanca-Generali. Il 2,1% di Piazzetta Cuccia (in carico a 181 milioni, ma contabilizzato al fair value di 141 milioni) e il 3,33% di Generali (valore di carico 811 milioni, fair value di 757 milioni) contribuiscono per poco meno di 900 milioni al capitale netto della holding che è di 21,8 miliardi.
In conclusione, il gruppo Benetton è ancora fortemente italocentrico e Atlantia-dipendente. Destabilizzare Atlantia significa colpire anche il 70% degli investitori di mercato e i 13.388 dipendenti del gruppo in Italia, dei quali 6.846 lavorano per Autostrade. Può sembrare un ricatto morale, ma occorre rifletterci.
Fonte
L’articolo pubblicato oggi sulla galassia dei Benetton, che sotto vi riproponiamo, dà un quadro preciso sia della struttura dei bilanci delle varie società, sia della natura reale di quelli che un tempo erano degli industriali del “golfino” trendy. Al di fuori del chiacchiericcio tra Di Maio (“azienda decotta, non si può occupare di Alitalia”) e il suo trasudante sodale di governo.
Dal quadro emerge che Atlantia – la società che gestisce in concessione Autostrade per l’Italia – pesa per più del 50% del fatturato della holding di famiglia. Ma soprattutto rappresenta tutti gli utili (profitti) dei soci di Edizione (il gruppo ristretto degli azionisti “familiari"). La citazione è meritata:
“Atlantia produce per i suoi azionisti profitti netti per 818 milioni, ai soci di Edizione – che detiene il 30,25% del capitale della società infrastrutturale – ne spettano 197. In altre parole, senza Atlantia gli utili sparirebbero, perché gli 86 milioni di competenza dei soci di Autogrill non basterebbero nemmeno a compensare le perdite dell’attività storica, con Benetton e la sua costola Olimpias che hanno chiuso in perdita rispettivamente per 115 e 11 milioni (il gruppo dei maglioncini è in rosso costante dal 2013).”Anche l’attività da pochissimo acquisita (la spagnola Abertis, gruppo multinazionale spagnolo che si occupa di gestione e sfruttamento delle infrastrutture di trasporto e di telecomunicazioni, facente capo anche alla spagnola Acs) non è industriale, ma pura gestione di infrastrutture costruite dalla mano pubblica e poi ceduta ai privati.
Idem anche per le altre attività rilevanti (aeroporti di Roma, Costa Azzurra e Saint Tropez), nonché per la partecipazione in Getlink (il tunnel sotto la Manica).
In pratica, ci dice Antonella Olivieri, se viene ritirata dallo Stato la concessione di Autostrade per l’Italia, per Atlantia è notte fonda. I Benetton, infatti, fanno i soldi soltanto così ormai: gestendo al risparmio infrastrutture a pedaggio (in Germania le autostrade sono gratuite o con abbonamento annuo inferiore alla tariffa di una sola corsa Roma-Milano), costruite con i soldi degli Stati e poi “privatizzate”.
In omaggio, ricordiamo, a quell’adagio assolutamente ideologico che recita: “i privati lo fanno meglio”.
Come abbiamo visto con il ponte Morandi a Genova.
La concessione è datata 1999, ma i Benetton si sono ben guardati dall’intervenire su una struttura che già allora mostrava seri segni di usura. “Meglio” incassare i soldi al casello, finché sta in piedi, vero?
Fuori da ogni “logica di mercato”, al riparo da ogni “concorrenza” (nessuno costruirà mai un’autostrada su un percorso dove già ne esiste una), con la garanzia di aumenti annuali delle tariffe ben al di sopra del tasso di inflazione, ecc.
Atlantia (e i Benetton) sono il paradigma di cosa è diventata la “grande imprenditoria italiana”: capitalismo “bollettaro” (che fa i soldi con bollette e pedaggi) in stile Ghino di Tacco, parassitario, socialmente irresponsabile, ma abilissimo a sfruttare gli “agganci” con le cordate politiche momentaneamente al potere.
*****
Perché il business di Autostrade è cruciale per i Benetton
di Antonella Olivieri
La minaccia per il gruppo Benetton è seria. Il bilancio consolidato di Edizione – i dati del 2018 sono stati elaborati con l’ausilio di R&S-Mediobanca – dipende infatti ancora in larga misura da Atlantia, tanto che, rispetto a un giro d’affari complessivo di 12.587 milioni, l’utile netto della holding della famiglia di Ponzano Veneto – 1.083 milioni – è spiegato interamente dalla società infrastrutturale che fattura 6.384 milioni al netto del canone di concessione di 532 milioni.
Tolte le quote di competenza terzi, Atlantia produce per i suoi azionisti profitti netti per 818 milioni, ai soci di Edizione – che detiene il 30,25% del capitale della società infrastrutturale – ne spettano 197.
In altre parole, senza Atlantia gli utili sparirebbero, perchè gli 86 milioni di competenza dei soci di Autogrill non basterebbero nemmeno a compensare le perdite dell’attività storica, con Benetton e la sua costola Olimpias che hanno chiuso in perdita rispettivamente per 115 e 11 milioni (il gruppo dei maglioncini è in rosso costante dal 2013).
Per contro sparirebbe anche il 98,5% del debito finanziario che assomma per Edizione a 47,99 miliardi.
Atlantia non può certo dirsi un’attività decotta, con un margine operativo lordo di 4.149 milioni, che sfiora il 65% dei ricavi netti. A sua volta, in Atlantia è preponderante il peso di Autostrade per l’Italia (Aspi) che, con 3.489 milioni, contribuisce al 54,7% delle entrate, e, con 1.765 milioni, al 64,2% del margine operativo netto.
A livello di risultato netto, dei 1.083 milioni di Atlantia, 622 (il 57,4%) vengono dai pedaggi italiani.
I conti del 2018 consolidano solo per due mesi la neo acquisita Abertis (50% più un’azione) che, a partire dal prossimo anno, avrà l’effetto di diluire il peso dell’Italia. Pro-forma – se cioè il gruppo spagnolo fosse stato consolidato dall’inizio del 2018 – il fatturato netto di Atlantia quasi raddoppierebbe, passando da 6.384 a 11.344 milioni e il margine operativo lordo salirebbe da 4.149 a 7.307 milioni.
Le attività aereoportuali – il 99,38% di Aeroporti di Roma (Fiumicino e Ciampino), il 64% di Costa Azzurra e il 99,94% dell’Aeroporto di Saint Tropez – pesano ancora relativamente poco: appena il 12% dell’intero fatturato consolidato di Atlantia, con un apporto di 834 milioni al netto delle rettifiche infragruppo.
Un altro pizzico di estero nel portafoglio di Atlantia è il 15,49% di Getlink (che esprime però il 26,64% dei diritti di voto), società che gestisce il collegamento sottomarino della Manica, per un valore a patrimonio netto di 1.041 milioni. Ma complessivamente, tra autostrade e aeroporti, oltre il 70% del giro d’affari di Atlantia – nei conti 2018 – ha origine ancora nella Penisola.
Al piano superiore, quello di Edizione, la diversificazione al momento è poco più che un accenno. Dall’operazione Abertis il gruppo ha ereditato anche il 29,9% di Cellnex (detenuto tramite Connect), un ritorno alle tlc, ma nel business meno volatile delle torri per la telefonia mobile (la società catalana ha rilevato in Italia buona parte della rete di Wind). Cellnex, che nel bilancio di Edizione è consolidata a patrimonio netto, è comunque ancora una realtà relativamente piccola con 867 milioni di fatturato netto, un margine operativo lordo di 516 milioni, un margine operativo netto di 113, un risultato netto di 18 milioni e utile di competenza dei soci di 15 milioni.
Gli unici investimenti finanziari – oltre al neo acquisto di poco meno del 3% di Prysmian – sono quelli della filiera Mediobanca-Generali. Il 2,1% di Piazzetta Cuccia (in carico a 181 milioni, ma contabilizzato al fair value di 141 milioni) e il 3,33% di Generali (valore di carico 811 milioni, fair value di 757 milioni) contribuiscono per poco meno di 900 milioni al capitale netto della holding che è di 21,8 miliardi.
In conclusione, il gruppo Benetton è ancora fortemente italocentrico e Atlantia-dipendente. Destabilizzare Atlantia significa colpire anche il 70% degli investitori di mercato e i 13.388 dipendenti del gruppo in Italia, dei quali 6.846 lavorano per Autostrade. Può sembrare un ricatto morale, ma occorre rifletterci.
Fonte
Consigli per gli acquisti. Attraverso questo mare di cemento. Immaginario, rudimenti pop e casi di forza maggiore
“Da più di tre lustri, lo Jacob agisce a casaccio. Seguendo un rigido piano quinquennale”
L’abbiamo letto e riletto questo libro. E’ un testo che si presenta al limite dell’ambiguo, pericoloso, pieno di stonature. Ci sono forzature, approssimazioni, letture di pancia e istintive, ma più si legge e più ci si rende conto che è frutto di un’urgenza e di una necessità assolutamente positive: la sinistra di classe, i compagni, devono fare i conti con la loro storia, con la storia delle loro scelte, con l’egemonia di pensiero dominante in cui loro stessi si sono fatti coinvolgere, che hanno tollerato o che non sono stati in grado di decostruire. E per essere decostruita, le belle e sagge parole non bastano, forse bisogna andarci giù di machete, bisogna farsi dire ma cosa diavolo state dicendo!, bisogna affondare nell’eresia e costringere tutti quelli che lottano per cambiare lo stato di cose presenti a fare i conti con le macerie sotto cui (ci) siamo sotterrati. Macerie e cemento sono, e così non potrebbe essere altrimenti, il campo in cui si deve muovere la sinistra di classe per ricominciare ad esistere. Lo cerca di fare il laboratorio politico Jacob di Foggia, nato nel 2003, che firma questo lavoro nel quale si ripercorrono gli anni della sua esistenza fino ad oggi, intrecciando vicende locali con appuntamenti nazionali, saltando dalle vicende del Foggia calcio alla nascita del Csoa Scuria nel 2014, tra citazioni intellettuali, botte con i fascisti e tradizioni popolari.
La lama del machete dello Jacob, viene rivendicata con orgoglio, non è composta di lavoro accademico ma di militanza politica, di botte allo stadio e per strada con fascisti e polizia, di confronti/scontri con il proletariato di Foggia e le sue contraddizioni, senza inutili romanticismi ma con la consapevolezza che nasce dal fatto di essere parte di quel proletariato, di esserci nati e di viverci quotidianamente. E allora nel libro si comincia ad analizzare/attaccare in maniera dissacrante quello che è il nostro intorno politico e il nostro immaginario militante, o meglio quello che dovrebbe essere il nostro immaginario e quello che invece è diventato.
Le provocazioni sono spiazzanti, fatte volontariamente per suscitare indignazione in una sinistra ormai incapace di immaginare se stessa fuori del recinto democratico e istituzionale, chiusa nei suoi stereotipi e nelle sue vuote ritualità, che non riesce a comunicare più a nessuno, che non riesce a comprendere più la realtà che la circonda.
Si potrebbe dire che il problema principale che viene affrontato sia quello dell’egemonia culturale, ma non è solo questo. C’è qualcosa di più profondo, che ha a che fare con la nostra stessa materialità di militanti politici, con i nostri gesti, con la nostra stessa forma. E allora sotto con il primo attacco diretto: aboliamo la festa del 25 aprile, smontiamo il mito della Resistenza e del buon partigiano costruito ad arte dal sistema di potere e dalla sinistra riformista, basta con questa narrazione tossica della Resistenza unitaria, Resistenza che è, così, estremamente depotenziata nelle sue radicali intenzioni ed appiattita sull’adagio della liberazione nazionale, i cui valori, ridotti ai minimi termini, diventano patrimonio comune e condiviso di tutti i cittadini italiani in quanto tali (a meno che non si appartenga ad una trascurabile minoranza di fascisti irriducibili), a prescindere dalle loro differenze reciproche.
Ed è qui che il terreno può diventare pericoloso, poiché si rischia, pur nella giusta rivendicazione di alterità, di rendere ancora più difficile il lavoro di immaginario e di memoria, tematiche che sono sempre state care al collettivo Militant. Perché se può essere vero che i nostri modelli artefatti sono la causa dei cedimenti. Perché basta un Pansa, una foiba, un eccidio, uno stupro, per far vacillare le convinzioni. E spingere alla dissociazione. A rivendicare un patrimonio parziale, quasi sempre inventato di sana pianta. I partigiani reali, in questa corsa all’esempio edificante, sono diventati quasi un peso. E il cavallo di battaglia di ogni revisionismo politicamente orientato, sostenere che esecuzioni sommarie di prigionieri, espropri arbitrari di beni ai civili, stupri di donne, esiguità del numero dei renitenti rispetto a quello degli arruolati nella Guardia Nazionale Repubblicana, odio viscerale per i repubblichini (dopo tutto “fratelli d’Italia” anche loro) e vilipendio dei loro cadaveri, refrattarietà alla disciplina, rivalità e scontri tra bande di diversa estrazione politica e tra i membri della stessa banda, difesa esclusiva della propria “roba” (intesa, a seconda dei casi, come merce, terreno, famiglia o comunità di appartenenza) a dispetto di ogni ideale più elevato e di qualsiasi obiettivo comune, rancori personali e vendette individuali, ostentazione della violenza e paura della morte, delazioni, fughe, tradimenti, imboscamenti, sono, componenti essenziali (della Resistenza), senza le quali non sarebbe stata vincente e, forse, mai esistita, rischia forse di spostare il problema che si voleva affrontare senza risolverlo, quello cioè di tracciare una linea netta tra “noi” e “loro”.
Tra ilari momenti, come quando si ricorda la nascita della Giornata del ricordo nel 2004, dove un compagno del Prc, in uno dei futili dibattiti di mezza sera con cui si ammazzava il tempo ai tempi del “Movimento dei movimenti”, una volta ebbe modo di dirci: “La differenza tra noi è che per voi le foibe sono mezze vuote, per noi sono mezze piene”. Non era l’unica differenza, a voler essere pignoli. Ma si voglia prendere come emblematica l’argomentazione: che la penitente sinistra istituzionale fosse sul tema rossa di vergogna in viso già al volgere del Millennio, e più amare riflessioni sulla permeabilità della sinistra di classe a linguaggi e, di conseguenza, a riflessioni che non gli appartengono, come del resto, pensiamoci: quante volte abbiamo parlato di “rivoluzione ungherese” o usato la locuzione “primavera di Praga”? E quante volte abbiamo rilanciato la formula “conflitto israelo-palestinese”? Quante volte abbiamo detto “guerra del Kosovo”? E quante altre abbiamo parlato di “disordini religiosi” nell’Irlanda del Nord? Non ammettiamo che quella di Budapest del ‘56 fu una “controrivoluzione”, che quella dei palestinesi è una lotta di liberazione, che in Kosovo non c’è stata una guerra ma una aggressione della Nato ad uno stato sovrano e che la religione non c’entra niente con le cause della guerra civile irlandese. Perché ammetterlo significherebbe rompere la pace lessicale e mostrarsi schierati ed isolati al contempo, le provocazioni si susseguono, spiazzanti, e continua anche l’analisi del lavoro politico e delle lotte dello Jacob durante gli anni, in un intreccio di territorialità e di feroce sarcasmo, di battute al limite del volgare e di riferimenti dotti per arrivare alla chiusa finale, che ben racchiude il sincretismo pop comunista che i compagni dello Jacob fanno proprio: Da più di tre lustri, lo Jacob agisce a casaccio. Seguendo un rigido piano quinquennale.
Da prendere con le molle ma da leggere con attenzione.
Fonte
L’abbiamo letto e riletto questo libro. E’ un testo che si presenta al limite dell’ambiguo, pericoloso, pieno di stonature. Ci sono forzature, approssimazioni, letture di pancia e istintive, ma più si legge e più ci si rende conto che è frutto di un’urgenza e di una necessità assolutamente positive: la sinistra di classe, i compagni, devono fare i conti con la loro storia, con la storia delle loro scelte, con l’egemonia di pensiero dominante in cui loro stessi si sono fatti coinvolgere, che hanno tollerato o che non sono stati in grado di decostruire. E per essere decostruita, le belle e sagge parole non bastano, forse bisogna andarci giù di machete, bisogna farsi dire ma cosa diavolo state dicendo!, bisogna affondare nell’eresia e costringere tutti quelli che lottano per cambiare lo stato di cose presenti a fare i conti con le macerie sotto cui (ci) siamo sotterrati. Macerie e cemento sono, e così non potrebbe essere altrimenti, il campo in cui si deve muovere la sinistra di classe per ricominciare ad esistere. Lo cerca di fare il laboratorio politico Jacob di Foggia, nato nel 2003, che firma questo lavoro nel quale si ripercorrono gli anni della sua esistenza fino ad oggi, intrecciando vicende locali con appuntamenti nazionali, saltando dalle vicende del Foggia calcio alla nascita del Csoa Scuria nel 2014, tra citazioni intellettuali, botte con i fascisti e tradizioni popolari.
La lama del machete dello Jacob, viene rivendicata con orgoglio, non è composta di lavoro accademico ma di militanza politica, di botte allo stadio e per strada con fascisti e polizia, di confronti/scontri con il proletariato di Foggia e le sue contraddizioni, senza inutili romanticismi ma con la consapevolezza che nasce dal fatto di essere parte di quel proletariato, di esserci nati e di viverci quotidianamente. E allora nel libro si comincia ad analizzare/attaccare in maniera dissacrante quello che è il nostro intorno politico e il nostro immaginario militante, o meglio quello che dovrebbe essere il nostro immaginario e quello che invece è diventato.
Le provocazioni sono spiazzanti, fatte volontariamente per suscitare indignazione in una sinistra ormai incapace di immaginare se stessa fuori del recinto democratico e istituzionale, chiusa nei suoi stereotipi e nelle sue vuote ritualità, che non riesce a comunicare più a nessuno, che non riesce a comprendere più la realtà che la circonda.
Si potrebbe dire che il problema principale che viene affrontato sia quello dell’egemonia culturale, ma non è solo questo. C’è qualcosa di più profondo, che ha a che fare con la nostra stessa materialità di militanti politici, con i nostri gesti, con la nostra stessa forma. E allora sotto con il primo attacco diretto: aboliamo la festa del 25 aprile, smontiamo il mito della Resistenza e del buon partigiano costruito ad arte dal sistema di potere e dalla sinistra riformista, basta con questa narrazione tossica della Resistenza unitaria, Resistenza che è, così, estremamente depotenziata nelle sue radicali intenzioni ed appiattita sull’adagio della liberazione nazionale, i cui valori, ridotti ai minimi termini, diventano patrimonio comune e condiviso di tutti i cittadini italiani in quanto tali (a meno che non si appartenga ad una trascurabile minoranza di fascisti irriducibili), a prescindere dalle loro differenze reciproche.
Ed è qui che il terreno può diventare pericoloso, poiché si rischia, pur nella giusta rivendicazione di alterità, di rendere ancora più difficile il lavoro di immaginario e di memoria, tematiche che sono sempre state care al collettivo Militant. Perché se può essere vero che i nostri modelli artefatti sono la causa dei cedimenti. Perché basta un Pansa, una foiba, un eccidio, uno stupro, per far vacillare le convinzioni. E spingere alla dissociazione. A rivendicare un patrimonio parziale, quasi sempre inventato di sana pianta. I partigiani reali, in questa corsa all’esempio edificante, sono diventati quasi un peso. E il cavallo di battaglia di ogni revisionismo politicamente orientato, sostenere che esecuzioni sommarie di prigionieri, espropri arbitrari di beni ai civili, stupri di donne, esiguità del numero dei renitenti rispetto a quello degli arruolati nella Guardia Nazionale Repubblicana, odio viscerale per i repubblichini (dopo tutto “fratelli d’Italia” anche loro) e vilipendio dei loro cadaveri, refrattarietà alla disciplina, rivalità e scontri tra bande di diversa estrazione politica e tra i membri della stessa banda, difesa esclusiva della propria “roba” (intesa, a seconda dei casi, come merce, terreno, famiglia o comunità di appartenenza) a dispetto di ogni ideale più elevato e di qualsiasi obiettivo comune, rancori personali e vendette individuali, ostentazione della violenza e paura della morte, delazioni, fughe, tradimenti, imboscamenti, sono, componenti essenziali (della Resistenza), senza le quali non sarebbe stata vincente e, forse, mai esistita, rischia forse di spostare il problema che si voleva affrontare senza risolverlo, quello cioè di tracciare una linea netta tra “noi” e “loro”.
Tra ilari momenti, come quando si ricorda la nascita della Giornata del ricordo nel 2004, dove un compagno del Prc, in uno dei futili dibattiti di mezza sera con cui si ammazzava il tempo ai tempi del “Movimento dei movimenti”, una volta ebbe modo di dirci: “La differenza tra noi è che per voi le foibe sono mezze vuote, per noi sono mezze piene”. Non era l’unica differenza, a voler essere pignoli. Ma si voglia prendere come emblematica l’argomentazione: che la penitente sinistra istituzionale fosse sul tema rossa di vergogna in viso già al volgere del Millennio, e più amare riflessioni sulla permeabilità della sinistra di classe a linguaggi e, di conseguenza, a riflessioni che non gli appartengono, come del resto, pensiamoci: quante volte abbiamo parlato di “rivoluzione ungherese” o usato la locuzione “primavera di Praga”? E quante volte abbiamo rilanciato la formula “conflitto israelo-palestinese”? Quante volte abbiamo detto “guerra del Kosovo”? E quante altre abbiamo parlato di “disordini religiosi” nell’Irlanda del Nord? Non ammettiamo che quella di Budapest del ‘56 fu una “controrivoluzione”, che quella dei palestinesi è una lotta di liberazione, che in Kosovo non c’è stata una guerra ma una aggressione della Nato ad uno stato sovrano e che la religione non c’entra niente con le cause della guerra civile irlandese. Perché ammetterlo significherebbe rompere la pace lessicale e mostrarsi schierati ed isolati al contempo, le provocazioni si susseguono, spiazzanti, e continua anche l’analisi del lavoro politico e delle lotte dello Jacob durante gli anni, in un intreccio di territorialità e di feroce sarcasmo, di battute al limite del volgare e di riferimenti dotti per arrivare alla chiusa finale, che ben racchiude il sincretismo pop comunista che i compagni dello Jacob fanno proprio: Da più di tre lustri, lo Jacob agisce a casaccio. Seguendo un rigido piano quinquennale.
Da prendere con le molle ma da leggere con attenzione.
Fonte
29/06/2019
Hardcore punk a New York
di Mauro Baldrati
È stato presentato al Biografilm di Bologna l’atteso documentario At the matinée, di Giangiacomo De Stefano, che inizierà un tour di distribuzione diretta in alcune sale italiane (difficilmente entrerà nella programmazione mainstream). È una ricostruzione, con interviste e alcuni filmati dell’epoca, dell’ambiente hardcore punk newyorkese degli anni ’80, che nacque e ruotò intorno a un famoso locale underground nel Lower East Side di Manhattan, il CBGB (acronimo di Country Blue Grass Blues). Negli anni '70 era stato un punto di riferimento per le nuove tendenze internazionali: ci suonavano abitualmente Patti Smith, Ramones, Television, Talking Heads, Blondie, Clash. Poi era caduto in disuso, anche per la tremenda involuzione della città, avvitata sulla crisi economica, il degrado urbano, la violenza. Poi, forse con la modalità casuale con cui nascono le grandi idee, così, tanto per fare, al proprietario Hilly Kristal venne in mente di riconvertirlo. Diventò un locale diurno, la domenica, per attirare un pubblico giovane, con la sua musica, il post punk più estremo che prenderà il nome di hardcore.
Siamo nei primi anni '80. I ragazzini vanno a scuola il lunedì, ma la domenica pomeriggio sono liberi. Lì per lì si formano nuovi gruppi, che scalpitano e ruggiscono intorno ai maestri, i Warzone, i Quicksand, gli Youth Of Today, un ambiente sulfureo e variegato che darà la luce a gruppi simbolo come i Cro-Mags di Harley Flanagan.
Un navigatore d’eccezione, Walter Schreifels, chitarrista e compositore dei Gorilla Biscuits, torna sul posto, di fronte alla nuova vetrina del negozio che un tempo fu il CBGB. Come dice il Bob Dylan di oggi sul Rolling Thunder tour, non resta nulla. Solo polvere. Forse non eravamo neppure nati. Neanche i rumori, i suoni furiosi, le urla “tirate in faccia”, gli odori pregnanti di sudore adolescenziale, i corpi scaraventati tra il pubblico, i muri anneriti ammuffiti rivestiti di collages e graffiti, i bagni lerci di un seminterrato gremito fino all’inverosimile con 40-45 gradi di temperatura interna, nessuna uscita di sicurezza e un angelo custode, anzi, una task force di angeli che l’hanno protetto da un piccolo, insignificante incidente: una sigaretta accesa, una scintilla degli impianti elettrici che avrebbero provocato una strage di ragazzini, imprigionati in una bara mortale come un sommergibile che affonda, un carro armato che va a fuoco.
Schreifels racconta, ricorda, intervista i sopravvissuti, tutti sani e presenti mentalmente: ex chitarristi o cantanti dei gruppi hardcore, che cercano di restituire la furia del periodo, la rabbia entusiasta dei dodicenni, dei quattordicenni che si agitavano sul palco e in platea. Bambini ipercresciuti che spesso, come ha raccontato proprio Harley Flanagan nel libro autobiografico La mia vita Hardcore, già suonavano (dopo avere ottenuto il permesso dalle mamme), fumavano droga e avevano pure dei rudimentali rapporti sessuali con ragazze più grandi. Anche se, precisa giustamente qualcuno degli intervistati, bisogna superare il luogo comune dello sballo ad ogni costo. Non tutti volevano drogarsi, da bravi hardcore punk. Molti credevano nell’amicizia, nella solidarietà, nell’accoglienza, non bevevano e non si drogavano affatto.
Le interviste si alternano con filmati dell’epoca, tutti di pessima qualità naturalmente, girati da spettatori, immagini sgranate, traballanti per i continui urti, il corpo di qualcuno scaraventato sulla platea, con un audio inascoltabile, distorto, che forniscono un effetto presenza formidabile, privo di qualunque filtro o rielaborazione. Sembra di esserci, anzi, ci siamo, travolti dall’adrenalina e dal testosterone adolescenziale in totale libertà, come un branco di cuccioli predatori che lottano, giocano, ruggiscono.
Era un ambiente soprattutto maschile, per cui le ragazze, dicono un paio di signore oggi distinte e sorridenti che parteciparono a quegli anni frenetici, erano rare, e dovevano essere “toste”.
L’esperienza, l’epica, come una nuova frontiera dell’ansia di vivere e di esserci e di urlare la propria libertà, durerà per tutto il decennio, finché la città, desiderosa di “riqualificare”, genererà la svolta: demolizioni, chiusure di locali, nuovi negozi, appartamenti, uffici. Via il vecchio mondo post beat, post hippy, post punk; via tutto e avanti i soldi, la speculazione e il crimine organizzato (il lato B del nuovo capitalismo rampante). Ci saranno scontri tra punk e polizia, guerriglia, con l’esito scontato che tutti conosciamo.
At the matinée è un film interessante, divertente, per certi aspetti strabiliante; resta, forse per la qualità delle interviste, così intense, così rievocative, un senso di vuoto, la rarefazione onirica di un periodo che forse non fu solo artistico, ma soprattutto esistenziale, improvvisato nella sua ansia di agire, di abbattere le barriere, tutte, con la violenza di un ariete da sfondamento.
È nato, è cresciuto con la velocità di una scarica elettrica, è passato con le sue architetture e le sue iconografie rase al suolo dalla “modernità”, e non restano che i ricordi.
Nessun Tempo Ritrovato.
Non resta che polvere.
Fonte
È stato presentato al Biografilm di Bologna l’atteso documentario At the matinée, di Giangiacomo De Stefano, che inizierà un tour di distribuzione diretta in alcune sale italiane (difficilmente entrerà nella programmazione mainstream). È una ricostruzione, con interviste e alcuni filmati dell’epoca, dell’ambiente hardcore punk newyorkese degli anni ’80, che nacque e ruotò intorno a un famoso locale underground nel Lower East Side di Manhattan, il CBGB (acronimo di Country Blue Grass Blues). Negli anni '70 era stato un punto di riferimento per le nuove tendenze internazionali: ci suonavano abitualmente Patti Smith, Ramones, Television, Talking Heads, Blondie, Clash. Poi era caduto in disuso, anche per la tremenda involuzione della città, avvitata sulla crisi economica, il degrado urbano, la violenza. Poi, forse con la modalità casuale con cui nascono le grandi idee, così, tanto per fare, al proprietario Hilly Kristal venne in mente di riconvertirlo. Diventò un locale diurno, la domenica, per attirare un pubblico giovane, con la sua musica, il post punk più estremo che prenderà il nome di hardcore.
Siamo nei primi anni '80. I ragazzini vanno a scuola il lunedì, ma la domenica pomeriggio sono liberi. Lì per lì si formano nuovi gruppi, che scalpitano e ruggiscono intorno ai maestri, i Warzone, i Quicksand, gli Youth Of Today, un ambiente sulfureo e variegato che darà la luce a gruppi simbolo come i Cro-Mags di Harley Flanagan.
Un navigatore d’eccezione, Walter Schreifels, chitarrista e compositore dei Gorilla Biscuits, torna sul posto, di fronte alla nuova vetrina del negozio che un tempo fu il CBGB. Come dice il Bob Dylan di oggi sul Rolling Thunder tour, non resta nulla. Solo polvere. Forse non eravamo neppure nati. Neanche i rumori, i suoni furiosi, le urla “tirate in faccia”, gli odori pregnanti di sudore adolescenziale, i corpi scaraventati tra il pubblico, i muri anneriti ammuffiti rivestiti di collages e graffiti, i bagni lerci di un seminterrato gremito fino all’inverosimile con 40-45 gradi di temperatura interna, nessuna uscita di sicurezza e un angelo custode, anzi, una task force di angeli che l’hanno protetto da un piccolo, insignificante incidente: una sigaretta accesa, una scintilla degli impianti elettrici che avrebbero provocato una strage di ragazzini, imprigionati in una bara mortale come un sommergibile che affonda, un carro armato che va a fuoco.
Schreifels racconta, ricorda, intervista i sopravvissuti, tutti sani e presenti mentalmente: ex chitarristi o cantanti dei gruppi hardcore, che cercano di restituire la furia del periodo, la rabbia entusiasta dei dodicenni, dei quattordicenni che si agitavano sul palco e in platea. Bambini ipercresciuti che spesso, come ha raccontato proprio Harley Flanagan nel libro autobiografico La mia vita Hardcore, già suonavano (dopo avere ottenuto il permesso dalle mamme), fumavano droga e avevano pure dei rudimentali rapporti sessuali con ragazze più grandi. Anche se, precisa giustamente qualcuno degli intervistati, bisogna superare il luogo comune dello sballo ad ogni costo. Non tutti volevano drogarsi, da bravi hardcore punk. Molti credevano nell’amicizia, nella solidarietà, nell’accoglienza, non bevevano e non si drogavano affatto.
Le interviste si alternano con filmati dell’epoca, tutti di pessima qualità naturalmente, girati da spettatori, immagini sgranate, traballanti per i continui urti, il corpo di qualcuno scaraventato sulla platea, con un audio inascoltabile, distorto, che forniscono un effetto presenza formidabile, privo di qualunque filtro o rielaborazione. Sembra di esserci, anzi, ci siamo, travolti dall’adrenalina e dal testosterone adolescenziale in totale libertà, come un branco di cuccioli predatori che lottano, giocano, ruggiscono.
Era un ambiente soprattutto maschile, per cui le ragazze, dicono un paio di signore oggi distinte e sorridenti che parteciparono a quegli anni frenetici, erano rare, e dovevano essere “toste”.
L’esperienza, l’epica, come una nuova frontiera dell’ansia di vivere e di esserci e di urlare la propria libertà, durerà per tutto il decennio, finché la città, desiderosa di “riqualificare”, genererà la svolta: demolizioni, chiusure di locali, nuovi negozi, appartamenti, uffici. Via il vecchio mondo post beat, post hippy, post punk; via tutto e avanti i soldi, la speculazione e il crimine organizzato (il lato B del nuovo capitalismo rampante). Ci saranno scontri tra punk e polizia, guerriglia, con l’esito scontato che tutti conosciamo.
At the matinée è un film interessante, divertente, per certi aspetti strabiliante; resta, forse per la qualità delle interviste, così intense, così rievocative, un senso di vuoto, la rarefazione onirica di un periodo che forse non fu solo artistico, ma soprattutto esistenziale, improvvisato nella sua ansia di agire, di abbattere le barriere, tutte, con la violenza di un ariete da sfondamento.
È nato, è cresciuto con la velocità di una scarica elettrica, è passato con le sue architetture e le sue iconografie rase al suolo dalla “modernità”, e non restano che i ricordi.
Nessun Tempo Ritrovato.
Non resta che polvere.
Fonte
Sudan - La terza fase della rivoluzione
La rivoluzione sudanese sta conoscendo la sua “terza fase”, dopo il movimento d’opposizione iniziato a dicembre che ha portato al defenestramento dell’ex presidente Omar Al-Bashir, l’11 aprile di quest’anno, e la fase interlocutoria tra l’autorità militare transitoria (TMC) che di fatto governa il paese e la coalizione delle forze dell’opposizione, la Dichiarazione per la Libertà e l’Indipendenza (DFC) interrotta bruscamente dalla feroce repressione del 3 giugno del sit-in di fronte al quartiere generale dell’esercito a Khartoum iniziato e mai interrotto – nonostante le numerose aggressioni e provocazioni – il 6 aprile.
La risposta al massacro – più di 100 morti – e allo stato d’assedio di fatto della milizia che fa capo al “numero 2” della giunta militare (le RSF, ex janjaweed) è stata in un primo momento lo sciopero e le azioni di “disobbedienza civile totale”, nel fine settimana successivo allo sgombero, che hanno di fatto paralizzato il paese e rese deserte le strade, pattugliate dagli ex “diavoli a cavallo” responsabili delle atrocità nella guerra del Darfur, poi divenuti elemento essenziale nella strategia della UE di gestione dei flussi migratori (con il cosiddetto “Processo di Khartoum”) e del contingente schierato sul campo in Yemen della coalizione a guida saudita.
Per il 30 giugno è stata lanciata la “Million-strong march”, dopo che la giunta militare ha rifiutato la proposta scaturita dalla mediazione etiope, che articolava l’anello mancante dell’architettura della transizione su cui si era raggiunto un accordo tra la TMC e la DFC. Questo prima del viaggio dei militari in Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti ed Egitto e del riuscito sciopero di due giorni precedente al massacro.
Le strade sudanesi sono tornate da giorni ad essere il teatro d’azione di questo popolo indomito, in particolare della sua componente giovanile. Come è avvenuto il 27 giugno ad Arbaji, nello stato di Jezira, dove gli studenti delle “primary school” hanno manifestato, anche in ricordo di Osman Gasm Elseed (di cui è la città natale), uno dei martiri del massacro del 3 giugno. E a Jabra, un quartiere della capitale, oppure a Omdurman il 25 giugno, oppure a Wad Madany – capitale dello stato di Madany, sempre il 25, dove a scendere in piazza sono stati gli studenti delle medie superiori, chiedendo di posticipare l’apertura della scuola al grido di “nessuna educazione, in una situazione di malessere”.
Il 29 e il 30 giugno, la diaspora sudanese manifesterà in tutto il mondo in sostegno alla protesta nel proprio paese natale, come ha fatto durante tutti questi mesi, pressoché ignorata dai media ufficiali.
Bisogna ricordare che il blackout informatico imposto dal 3 giugno dalla giunta militare che in vario modo il popolo sudanese sta cercando di aggirare, rende difficile la diffusione di ciò che avviene nel paese e ha ridato centralità ai “comitati di quartiere”, che erano stati i propulsori della rivoluzione dal dicembre in poi, fondamentali per una prima risposta dopo il massacro del 3 giugno; dopo il quale la giunta ha dichiarato “cessati” i colloqui e indicato la strada di elezioni presidenziali entro 9 mesi, con un interregno di gestione militare.
Il rifiuto della proposta etiope da parte della giunta, attraverso il suo portavoce, il Generale Shams al-Din Kabbashi, è stato denunciato dall’opposizione come il classico escamotage tattico per “prendere tempo” e cercare di contrapporre l’Unione Africana – altro soggetto mediatore nel conflitto – e l’Etiopia: “domandiamo ai mediatori di unire i loro sforzi e sottoporci una proposta comune il più presto possibile per il ritorno delle parti ad una negoziazione”.
È chiaro che l’isolamento internazionale di cui soffre la giunta – a parte il suo sostegno da parte dell’“asse del male” (Usa, Israele, Arabia Saudita) – e il nuovo protagonismo statunitense teso a determinare direttamente (non attraverso i suoi alleati) un processo politico in una area strategica per i suoi interessi (ha minacciato sanzioni contro i membri della giunta), mette in difficoltà la TMC che non ha visto esaurirsi la propulsione della risposta popolare.
La Sudan Professionals Association – punta di lancia della protesta che raggruppa tutti i settori sociali dell’opposizione e che è organica alla DFC – sta tuttora “dettando” l’agenda delle mobilitazioni con un programma dettagliato delle proteste che, dopo lo sciopero generale e la disobbedienza civile totale dei giorni successivi al massacro, si è concretizzata in azioni quotidiane dal 17 giugno fino ad oggi; insistendo sul ruolo dei “comitati di quartiere” nel promuovere il dibattito e con le mobilitazioni serali che avevano caratterizzato la protesta anche durante l’opposizione a Bashir, riappropriandosi dello “spazio pubblico” che le milizie della giunta vorrebbero azzerare.
Intanto il 26 giugno A. El Burhan, capo della TMC, si è incontrato con la “Troika” (USA, UK e Norvegia) nel palazzo presidenziale della capitale; presente anche “Hemeti”, il numero due della giunta militare, dopo che l’inviato speciale degli USA Donald Booth si è espresso per un trasferimento dei poteri ad una autorità civile e ha detto di sostenere la protesta, mentre il rappresentante norvegese ha supportato lo sforzo di mediazione congiunto dell’Unione Africana e dell’Etiopia.
Come abbiamo più volte sottolineato, il Sudan ed il suo popolo si trovano al centro di un complesso scontro e “ricompattamento” tra diversi attori regionali, mentre il processo rivoluzionario è seguito con grande attenzione – e preoccupazione – in tutto il continente africano.
Il 30 giugno è una data storica per il Paese, perché è il giorno in cui nel 1989 Bashir prese il potere con un colpo di stato appoggiato dalla parte più retriva dell’islam politico, che è stato poi l’architrave ideologico del regime nel corso degli anni successivi.
La rivoluzione sudanese è entrata nella sua “terza fase”, e si alimenta della sua storia indomita che le ha fatto conquistare l’indipendenza, annullare due colpi di stato ed ora le può far regolare definitivamente i conti con il “vecchio regime”, riuscendo in ciò che non è riuscita a fare proprio a fine anni ’80, trenta anni dopo.
La storia, si sa, procede per “salti di qualità” e “rotture” e sconfigge innanzitutto i fantasmi delle sconfitte del passato...
Fonte
La risposta al massacro – più di 100 morti – e allo stato d’assedio di fatto della milizia che fa capo al “numero 2” della giunta militare (le RSF, ex janjaweed) è stata in un primo momento lo sciopero e le azioni di “disobbedienza civile totale”, nel fine settimana successivo allo sgombero, che hanno di fatto paralizzato il paese e rese deserte le strade, pattugliate dagli ex “diavoli a cavallo” responsabili delle atrocità nella guerra del Darfur, poi divenuti elemento essenziale nella strategia della UE di gestione dei flussi migratori (con il cosiddetto “Processo di Khartoum”) e del contingente schierato sul campo in Yemen della coalizione a guida saudita.
Per il 30 giugno è stata lanciata la “Million-strong march”, dopo che la giunta militare ha rifiutato la proposta scaturita dalla mediazione etiope, che articolava l’anello mancante dell’architettura della transizione su cui si era raggiunto un accordo tra la TMC e la DFC. Questo prima del viaggio dei militari in Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti ed Egitto e del riuscito sciopero di due giorni precedente al massacro.
Le strade sudanesi sono tornate da giorni ad essere il teatro d’azione di questo popolo indomito, in particolare della sua componente giovanile. Come è avvenuto il 27 giugno ad Arbaji, nello stato di Jezira, dove gli studenti delle “primary school” hanno manifestato, anche in ricordo di Osman Gasm Elseed (di cui è la città natale), uno dei martiri del massacro del 3 giugno. E a Jabra, un quartiere della capitale, oppure a Omdurman il 25 giugno, oppure a Wad Madany – capitale dello stato di Madany, sempre il 25, dove a scendere in piazza sono stati gli studenti delle medie superiori, chiedendo di posticipare l’apertura della scuola al grido di “nessuna educazione, in una situazione di malessere”.
Il 29 e il 30 giugno, la diaspora sudanese manifesterà in tutto il mondo in sostegno alla protesta nel proprio paese natale, come ha fatto durante tutti questi mesi, pressoché ignorata dai media ufficiali.
Bisogna ricordare che il blackout informatico imposto dal 3 giugno dalla giunta militare che in vario modo il popolo sudanese sta cercando di aggirare, rende difficile la diffusione di ciò che avviene nel paese e ha ridato centralità ai “comitati di quartiere”, che erano stati i propulsori della rivoluzione dal dicembre in poi, fondamentali per una prima risposta dopo il massacro del 3 giugno; dopo il quale la giunta ha dichiarato “cessati” i colloqui e indicato la strada di elezioni presidenziali entro 9 mesi, con un interregno di gestione militare.
Il rifiuto della proposta etiope da parte della giunta, attraverso il suo portavoce, il Generale Shams al-Din Kabbashi, è stato denunciato dall’opposizione come il classico escamotage tattico per “prendere tempo” e cercare di contrapporre l’Unione Africana – altro soggetto mediatore nel conflitto – e l’Etiopia: “domandiamo ai mediatori di unire i loro sforzi e sottoporci una proposta comune il più presto possibile per il ritorno delle parti ad una negoziazione”.
È chiaro che l’isolamento internazionale di cui soffre la giunta – a parte il suo sostegno da parte dell’“asse del male” (Usa, Israele, Arabia Saudita) – e il nuovo protagonismo statunitense teso a determinare direttamente (non attraverso i suoi alleati) un processo politico in una area strategica per i suoi interessi (ha minacciato sanzioni contro i membri della giunta), mette in difficoltà la TMC che non ha visto esaurirsi la propulsione della risposta popolare.
La Sudan Professionals Association – punta di lancia della protesta che raggruppa tutti i settori sociali dell’opposizione e che è organica alla DFC – sta tuttora “dettando” l’agenda delle mobilitazioni con un programma dettagliato delle proteste che, dopo lo sciopero generale e la disobbedienza civile totale dei giorni successivi al massacro, si è concretizzata in azioni quotidiane dal 17 giugno fino ad oggi; insistendo sul ruolo dei “comitati di quartiere” nel promuovere il dibattito e con le mobilitazioni serali che avevano caratterizzato la protesta anche durante l’opposizione a Bashir, riappropriandosi dello “spazio pubblico” che le milizie della giunta vorrebbero azzerare.
Intanto il 26 giugno A. El Burhan, capo della TMC, si è incontrato con la “Troika” (USA, UK e Norvegia) nel palazzo presidenziale della capitale; presente anche “Hemeti”, il numero due della giunta militare, dopo che l’inviato speciale degli USA Donald Booth si è espresso per un trasferimento dei poteri ad una autorità civile e ha detto di sostenere la protesta, mentre il rappresentante norvegese ha supportato lo sforzo di mediazione congiunto dell’Unione Africana e dell’Etiopia.
Come abbiamo più volte sottolineato, il Sudan ed il suo popolo si trovano al centro di un complesso scontro e “ricompattamento” tra diversi attori regionali, mentre il processo rivoluzionario è seguito con grande attenzione – e preoccupazione – in tutto il continente africano.
Il 30 giugno è una data storica per il Paese, perché è il giorno in cui nel 1989 Bashir prese il potere con un colpo di stato appoggiato dalla parte più retriva dell’islam politico, che è stato poi l’architrave ideologico del regime nel corso degli anni successivi.
La rivoluzione sudanese è entrata nella sua “terza fase”, e si alimenta della sua storia indomita che le ha fatto conquistare l’indipendenza, annullare due colpi di stato ed ora le può far regolare definitivamente i conti con il “vecchio regime”, riuscendo in ciò che non è riuscita a fare proprio a fine anni ’80, trenta anni dopo.
La storia, si sa, procede per “salti di qualità” e “rotture” e sconfigge innanzitutto i fantasmi delle sconfitte del passato...
Fonte
Il sorprendente sciopero delle infermiere irlandesi
In un Irlanda dove molti lavoratori non hanno ancora riscontrato alcun beneficio dalla ripresa economica successiva alla crisi, sono le infermiere a essersi messe in prima linea nella lotta contro l’austerità. Nelle ultime due settimane, i sindacati delle infermiere sono gradualmente riusciti a costruire degli scioperi partecipati che hanno messo pressione al governo rivendicando nuove assunzioni e aumenti salariali. I sondaggi indicano che la lotta delle infermiere è vista favorevolmente dal 74% della popolazione, un numero straordinario.
Lo sciopero ha certamente avuto un effetto importante. Nei tre giorni di forte protesta, 30 gennaio, 5 febbraio e 7 febbraio 2019, tutti i servizi ospedalieri non emergenziali sono stati cancellati, e ciò ha toccato più di 80 mila pazienti. La lotta sembrava destinata a intensificarsi, visto che l’Irish Nurses and Midwives Organization (Inmo) e lo Psychiatric Nurses Association (Pna) avevano minacciato tre giorni consecutivi di azioni di lotta. Uno sciopero di questa portata avrebbe ridotto in ginocchio un sistema sanitario già in sofferenza.
Seppur il conflitto si stesse intensificando, l’opinione pubblica è rimasta saldamente dalla parte delle infermiere. Il 9 febbraio, come segno di questo travolgente supporto, decine di migliaia di persone hanno marciato insieme alle infermiere nel centro di Dublino. Due giorni dopo, i sindacati hanno sospeso le loro azioni, non appena la corte del lavoro ha avanzato una proposta con nuove fasce salariali e opportunità di promozione, che sarà votata dai membri del sindacato a marzo.
Per molti aspetti, è stata una lotta lavorativa tradizionale: ha riguardato stipendi, condizioni di lavoro e si è sviluppata nella consueta escalation di tensione, sospesa solo dopo l’intervento della Corte del Lavoro. Gli strumenti utilizzati dalle scioperanti sono noti a chiunque abbia una qualche familiarità con la lotta sindacale: picchetti intorno alle strutture ospedaliere, canti di slogan, bandiere del sindacato e cartelloni rivendicativi.
Tuttavia che le infermiere siano riuscite in un’azione di questa portata – il più grande sciopero in Irlanda negli ultimi anni – è sorprendente in sé. In un passato non così distante, i professionisti del settore pubblico si sono trattenuti dalla partecipazione alle lotte sul lavoro a causa della combinazione delle leggi sulle limitazioni dello sciopero nei servizi pubblici e di una certa concezione della propria etica professionale. Citando Harry Eckstein, i professionisti medici hanno una «profonda inibizione nei confronti di tutto ciò che sa di sindacalismo», e le associazioni di infermieri solitamente hanno un atteggiamento simile.
Oggi vediamo quanto questo sia cambiato. Nelle economie avanzate, una crescente porzione delle proteste lavorative viene da chi meno ci si aspetta. Insegnanti, infermieri e addirittura i consulenti medici sono entrati in conflitto con il proprio datore di lavoro, che solitamente è lo Stato. Nel portare avanti gli scioperi, lavoratori spesso poco propensi a utilizzare il repertorio delle strategie del movimento operaio, stanno rigenerando la lotta contro l’austerità nel suo complesso.
Professionisti proletarizzati
Che un’azione di lotta di questa portata venga dalle infermiere è particolarmente sorprendente se consideriamo nel lungo periodo la storia del loro associazionismo professionale. Sebbene l’Inmo sia nato nel 1919, si è tenuto distante dal movimento sindacale fino alla fine degli anni '80, indicendo il primo sciopero solo nel 1999. Da allora, tuttavia, ha giocato un ruolo di primo piano nelle lotte per il salario ed è divenuto uno degli avversari più ferventi dell’austerità.
Per decenni l’associazionismo delle infermiere ha mantenuto una posizione subordinata a quella dei gruppi di interesse politici Irlandesi, tra cui è influente anche la pressione conservatrice della Chiesa Cattolica. Ciò si è sposato con una visione sessista dell’assistenza infermieristica come attività caritatevole di stampo femminile, in cui l’accettazione di una paga bassa andava di pari passo con la subordinazione e il senso di devozione che le lavoratrici dovevano mantenere. Eppure il loro associazionismo si è tenuto a lungo lontano dalla lotta per i diritti sul lavoro.
Oggi, visioni di questo tipo sembrano antiquate, soprattutto perché le lavoratrici e i lavoratori sono soggetti alla contraddittoria pressione della professionalizzazione e della proletarizzazione. Ai dipendenti dell’istruzione, dell’assistenza sanitaria e dei servizi sociali è richiesto di svolgere compiti sempre più complessi e di prendere ora per ora decisioni ad alta responsabilità. Nel caso delle infermiere, questo processo ha gradualmente liberato la professione dalla sua subordinazione ai medici: per esempio, le infermiere irlandesi sono state recentemente autorizzate a prescrivere medicinali.
Tuttavia, questi avanzamenti non sono stati seguiti da un aumento del reddito o dall’indipendenza professionale. Al contrario, queste nuove (semi)professioni si ritrovano spesso costrette tra strutture burocratiche con rigide gerarchie e non sono premiate remunerativamente. Negli anni recenti poi sono divenuti uno dei target principali dell’austerità. I servizi pubblici sono attività altamente dipendenti dal lavoro, gli stipendi infatti possono pesare tra il 60 e l’85% delle spese operative, il taglio dei salari offre perciò l’opportunità maggiore per risparmiare.
L’enfasi sulla necessità di ridurre il più possibile gli stipendi nel settore pubblico si fonde con il discorso neoliberista sulla “competitività”, così caro alle piccole economie aperte come l’Irlanda. In questa narrazione, il settore pubblico è quello «riparato, protetto» che si mantiene isolato dalle pressioni del mercato globale e rappresenta quindi una minaccia per i settori economici «esposti», in quanto offre ai dipendenti delle retribuzioni eccessivamente alte. Più specificatamente, si sostiene che gli stipendi del settore pubblico non siano in linea con la sua produttività.
Questa affermazione è doppiamente problematica. I rilevamenti sulla produttività hanno poco senso in settori dove il rendimento dell’attività non è venduto sul mercato. E la produttività è per definizione più bassa in attività costruite attorno all’interazione umana diretta e in tempo reale, come ad esempio l’istruzione o l’assistenza sanitaria. Spesso, la bassa produttività (una bassa percentuale di studenti per facoltà o di pazienti per infermiere) può essere considerata un segnale di qualità.
Infatti, nel suo recente libro, Il valore di tutto, Mariana Mazzucato sostiene in maniera convincente che le statistiche nazionali sottostimano sistematicamente il valore delle attività del servizio pubblico, per esempio attraverso il non riconoscimento del ruolo cruciale che la salute e l’educazione svolgono nel sostenere il settore privato. Nonostante ciò, la nozione di improduttività del settore pubblico da forma alle più importanti decisioni dei governi e alle raccomandazioni legislative dell’Unione europea, ed è divenuta ancora più forte sulla scia della crisi finanziaria globale.
Le élite irlandesi insistono che la ripresa economica del paese successiva alla crisi sia dovuta a politiche fiscali responsabili, e non alle straordinarie entrate di cui l’Irlanda gode come base finanziaria e di servizi per le multinazionali. Il mantra ufficiale è che l’austerità ha funzionato, e nel caso irlandese l’austerità ha significato ridurre fortemente i salari del settore pubblico. Gli stipendi degli impiegati nel settore pubblico sono stati ridotti ogni anno tranne uno tra il 2008 e il 2014 (e solo nel 2009 la riduzione è stata del 7%).
Alcuni di questi tagli si sono basati su accordi collettivi sottoscritti a malincuore anche dai sindacati, i quali venivano minacciati con misure unilaterali addirittura più severe. Gli accordi prevedevano anche la promessa di tornare indietro sui tagli previsti una volta stabilizzate le finanze pubbliche. Negli ultimi anni, la discussione è perciò virata sul ripristino dei livelli salariali del settore pubblico. Tuttavia, la versione corrente dell’Accordo sulla Stabilità del Servizio Pubblico dà ancora priorità alla disciplina fiscale non occupandosi delle gravi ingiustizie nella gestione dei dipendenti pubblici.
Su chi grava il peso
Riguardando l’intero servizio pubblico (dal lavoro d’ufficio, fino all’applicazione della legge sui servizi sanitari e l’educazione) questo accordo gode del supporto dei sindacati generali del settore pubblico (come il Siptu e l’Impact), i quali di regola evitano il confronto con il governo su vasta scala. Visto che i sindacati professionali del servizio pubblico (incluse le infermiere) avrebbero rischiato di non ottenere nulla andando da soli, hanno sottoscritto l’accordo.
Ma la maggior parte delle infermiere sono rimaste insoddisfatte dal ritmo e dai metodi di ripristino delle retribuzioni. Analogamente a molti altri paesi, il servizio sanitario irlandese sta affrontando una crisi di assunzioni e mantenimento del personale.
Molte delle infermiere irlandesi più qualificate continuano la tradizione di emigrare alla ricerca di salari più alti e migliori condizioni di lavoro in Australia, Canada, Usa o anche nel Regno Unito. Altri se ne vanno per approdare al settore privato. Sommato tutto, la carenza di personale significa una vita lavorativa estenuante e un grosso rischio di crisi da stress per quelli che non sono usciti dal sistema sanitario. È in questo contesto che le infermiere hanno deciso di lanciare la campagna di quest’anno sulla retribuzione.
Il dibattito pubblico tra il governo e i sindacati delle infermiere è ruotato intorno al tema di cosa costituisca un comportamento responsabile in un tale contesto. Il governo insiste sulla presunta necessità di sostenere la responsabilità fiscale.
Il primo ministro (Taoiseach) Leo Varadkar, si è persino spinto a sostenere che lo stato irlandese non può permettersi aumenti salariali del settore pubblico perché deve risparmiare fondi in preparazione di una dura Brexit. «Devo essere Taoiseach per l’intero paese», ha detto Varadkar durante un dibattito nel parlamento irlandese.
La sua dichiarazione è un promemoria di come agisca il governo quando si trova in dispute con i sindacati del settore pubblico: prova a dare un’immagine di sé come guardiano dell’interesse pubblico contro gli irresponsabili gruppi di interesse particolare. La credibilità del governo nello spendere responsabilmente le proprie risorse tuttavia è stata screditata dalle rivelazioni sul costo di un nuovo ospedale per bambini (ancora in costruzione) che ha superato i 400 milioni di euro, un episodio che il ministro della salute ha tentato di insabbiare. In confronto, l’accordo attualmente sul tavolo per risolvere le tensioni con le infermiere costerà al massimo 35 milioni di euro l’anno.
A parte la questione della responsabilità fiscale, i sindacati del servizio pubblico per vincere dispute di questo genere devono essere in grado di convincere i cittadini che non stanno solo lottando per stipendi più alti, ma anche per servizi pubblici di maggiore qualità. Il supporto pubblico è l’arma più potente in mano ai sindacati. L’interruzione del servizio non può fare molti danni finanziari a un governo, in quanto le tasse continuano a essere raccolte mentre il pagamento degli stipendi è sospeso; parallelamente, ci si aspetta che i sindacati coprano le remunerazioni perse dagli scioperanti attraverso i loro fondi per lo sciopero.
Gli organizzatori delle lotte devono anche guardarsi da chi li indica come pericolosi per le vite dei pazienti. Infatti, anche se i servizi di emergenza e soccorso fossero pienamente funzionanti durante lo sciopero delle infermiere, i media irlandesi hanno fatto circolare notizie allarmistiche.Tuttavia, i sindacati sono vivi in questa battaglia mediatica.
L’Irisih Nurses and Midwives’ Organization ha la fama di prendere seriamente le preoccupazioni dei pazienti, già prima dell’attuale sciopero. Dal 2004, l’Inmo ha raccolto dati sul numero di pazienti che giacevano sulle barelle nei reparti e nei pronto soccorso degli ospedali. A questa semplice misurazione è stato anche conferito valore dal Hearth Service Executive; l’Inmo in un secondo momento l’ha poi utilizzata per evidenziare un aspetto del sottofinanziamento degli ospedali tra i più drammatici e che può quindi mobilitare più facilmente la sensibilità dell’opinione pubblica rispetto alle sole cifre della lista d’attesa.
Durante lo sciopero, le leader delle infermiere si sono anche appellate al concetto di sicurezza del paziente, sostenendo che gli attuali livelli di personale sono pericolosi. È stata resa esplicita la catena causale iniziata dai bassi salari, i quali hanno portato all’emigrazione e alla carenza di manodopera, per arrivare infine a orari di lavoro eccessivi che hanno sfiancato il personale residuo.
Seppur i gruppi di difesa dei pazienti si siano astenuti dal prendere posizione nella disputa, il livello del supporto che le infermiere hanno ricevuto durante il loro corteo a Dublino e la copertura mediatica favorevole suggeriscono che le strategie dei sindacati hanno avuto successo. Un sondaggio condotto un giorno prima dello sciopero su un campione di 1.000 persone ha mostrato che il 74% supportava la protesta. Oltretutto, a partire dal 7 febbraio 2019, più di 68 mila persone hanno espresso il proprio sostegno firmando una petizione online che «invita il governo a prendere provvedimenti e ad aumentare le retribuzioni di infermieri e ostetrici per garantire personale adeguato».
Per decenni, i sindacati nel Nord del mondo hanno dovuto sopportare l’accusa di irresponsabilità economica. Le élite politiche ed economiche incolpavano i militanti sindacali per la crisi di stagnazione degli anni '70, anche se il collegamento causale non è stato mai provato. Sulla scia dell’assalto neoconservatore degli anni '80, i leader sindacali hanno interiorizzato questa responsabilità e, ovunque hanno potuto, hanno preso parte a patti sociali che hanno preservato il loro status istituzionale, ma che non hanno portato grande apporto materiale ai propri aderenti.
La crisi del 2008 ha trovato un movimento sindacale i cui membri erano decimati e il cui centro di gravità si era spostato verso il settore pubblico. Le élite politiche ed economiche hanno usato l’austerità post-2008 anche come un’opportunità per lanciare un altro duro colpo al movimento. Tuttavia, hanno anche provocato una nuova radicalità dei sindacati del settore pubblico che può essere uno dei primi segnali di rinnovamento del movimento dei lavoratori e delle lavoratrici.
Molti osservatori (anche quelli di sinistra) pensano che lo spostamento delle proteste del lavoro verso il settore pubblico peggiori l’immagine dei sindacati come gruppi irresponsabili di interessi particolari. Il messaggio principale dello sciopero delle infermiere irlandesi è che non è necessariamente così. I sindacati possono mostrare la propria responsabilità sociale senza rinunciare ad azioni radicali in difesa dei salari e dei servizi pubblici.
di Imre G. Szabó detentrice di ricerca post-dottorato all’University College di Dublino, si occupa di sindacati e della governance economica dell’Unione europea.
Fonte
Lo sciopero ha certamente avuto un effetto importante. Nei tre giorni di forte protesta, 30 gennaio, 5 febbraio e 7 febbraio 2019, tutti i servizi ospedalieri non emergenziali sono stati cancellati, e ciò ha toccato più di 80 mila pazienti. La lotta sembrava destinata a intensificarsi, visto che l’Irish Nurses and Midwives Organization (Inmo) e lo Psychiatric Nurses Association (Pna) avevano minacciato tre giorni consecutivi di azioni di lotta. Uno sciopero di questa portata avrebbe ridotto in ginocchio un sistema sanitario già in sofferenza.
Seppur il conflitto si stesse intensificando, l’opinione pubblica è rimasta saldamente dalla parte delle infermiere. Il 9 febbraio, come segno di questo travolgente supporto, decine di migliaia di persone hanno marciato insieme alle infermiere nel centro di Dublino. Due giorni dopo, i sindacati hanno sospeso le loro azioni, non appena la corte del lavoro ha avanzato una proposta con nuove fasce salariali e opportunità di promozione, che sarà votata dai membri del sindacato a marzo.
Per molti aspetti, è stata una lotta lavorativa tradizionale: ha riguardato stipendi, condizioni di lavoro e si è sviluppata nella consueta escalation di tensione, sospesa solo dopo l’intervento della Corte del Lavoro. Gli strumenti utilizzati dalle scioperanti sono noti a chiunque abbia una qualche familiarità con la lotta sindacale: picchetti intorno alle strutture ospedaliere, canti di slogan, bandiere del sindacato e cartelloni rivendicativi.
Tuttavia che le infermiere siano riuscite in un’azione di questa portata – il più grande sciopero in Irlanda negli ultimi anni – è sorprendente in sé. In un passato non così distante, i professionisti del settore pubblico si sono trattenuti dalla partecipazione alle lotte sul lavoro a causa della combinazione delle leggi sulle limitazioni dello sciopero nei servizi pubblici e di una certa concezione della propria etica professionale. Citando Harry Eckstein, i professionisti medici hanno una «profonda inibizione nei confronti di tutto ciò che sa di sindacalismo», e le associazioni di infermieri solitamente hanno un atteggiamento simile.
Oggi vediamo quanto questo sia cambiato. Nelle economie avanzate, una crescente porzione delle proteste lavorative viene da chi meno ci si aspetta. Insegnanti, infermieri e addirittura i consulenti medici sono entrati in conflitto con il proprio datore di lavoro, che solitamente è lo Stato. Nel portare avanti gli scioperi, lavoratori spesso poco propensi a utilizzare il repertorio delle strategie del movimento operaio, stanno rigenerando la lotta contro l’austerità nel suo complesso.
Professionisti proletarizzati
Che un’azione di lotta di questa portata venga dalle infermiere è particolarmente sorprendente se consideriamo nel lungo periodo la storia del loro associazionismo professionale. Sebbene l’Inmo sia nato nel 1919, si è tenuto distante dal movimento sindacale fino alla fine degli anni '80, indicendo il primo sciopero solo nel 1999. Da allora, tuttavia, ha giocato un ruolo di primo piano nelle lotte per il salario ed è divenuto uno degli avversari più ferventi dell’austerità.
Per decenni l’associazionismo delle infermiere ha mantenuto una posizione subordinata a quella dei gruppi di interesse politici Irlandesi, tra cui è influente anche la pressione conservatrice della Chiesa Cattolica. Ciò si è sposato con una visione sessista dell’assistenza infermieristica come attività caritatevole di stampo femminile, in cui l’accettazione di una paga bassa andava di pari passo con la subordinazione e il senso di devozione che le lavoratrici dovevano mantenere. Eppure il loro associazionismo si è tenuto a lungo lontano dalla lotta per i diritti sul lavoro.
Oggi, visioni di questo tipo sembrano antiquate, soprattutto perché le lavoratrici e i lavoratori sono soggetti alla contraddittoria pressione della professionalizzazione e della proletarizzazione. Ai dipendenti dell’istruzione, dell’assistenza sanitaria e dei servizi sociali è richiesto di svolgere compiti sempre più complessi e di prendere ora per ora decisioni ad alta responsabilità. Nel caso delle infermiere, questo processo ha gradualmente liberato la professione dalla sua subordinazione ai medici: per esempio, le infermiere irlandesi sono state recentemente autorizzate a prescrivere medicinali.
Tuttavia, questi avanzamenti non sono stati seguiti da un aumento del reddito o dall’indipendenza professionale. Al contrario, queste nuove (semi)professioni si ritrovano spesso costrette tra strutture burocratiche con rigide gerarchie e non sono premiate remunerativamente. Negli anni recenti poi sono divenuti uno dei target principali dell’austerità. I servizi pubblici sono attività altamente dipendenti dal lavoro, gli stipendi infatti possono pesare tra il 60 e l’85% delle spese operative, il taglio dei salari offre perciò l’opportunità maggiore per risparmiare.
L’enfasi sulla necessità di ridurre il più possibile gli stipendi nel settore pubblico si fonde con il discorso neoliberista sulla “competitività”, così caro alle piccole economie aperte come l’Irlanda. In questa narrazione, il settore pubblico è quello «riparato, protetto» che si mantiene isolato dalle pressioni del mercato globale e rappresenta quindi una minaccia per i settori economici «esposti», in quanto offre ai dipendenti delle retribuzioni eccessivamente alte. Più specificatamente, si sostiene che gli stipendi del settore pubblico non siano in linea con la sua produttività.
Questa affermazione è doppiamente problematica. I rilevamenti sulla produttività hanno poco senso in settori dove il rendimento dell’attività non è venduto sul mercato. E la produttività è per definizione più bassa in attività costruite attorno all’interazione umana diretta e in tempo reale, come ad esempio l’istruzione o l’assistenza sanitaria. Spesso, la bassa produttività (una bassa percentuale di studenti per facoltà o di pazienti per infermiere) può essere considerata un segnale di qualità.
Infatti, nel suo recente libro, Il valore di tutto, Mariana Mazzucato sostiene in maniera convincente che le statistiche nazionali sottostimano sistematicamente il valore delle attività del servizio pubblico, per esempio attraverso il non riconoscimento del ruolo cruciale che la salute e l’educazione svolgono nel sostenere il settore privato. Nonostante ciò, la nozione di improduttività del settore pubblico da forma alle più importanti decisioni dei governi e alle raccomandazioni legislative dell’Unione europea, ed è divenuta ancora più forte sulla scia della crisi finanziaria globale.
Le élite irlandesi insistono che la ripresa economica del paese successiva alla crisi sia dovuta a politiche fiscali responsabili, e non alle straordinarie entrate di cui l’Irlanda gode come base finanziaria e di servizi per le multinazionali. Il mantra ufficiale è che l’austerità ha funzionato, e nel caso irlandese l’austerità ha significato ridurre fortemente i salari del settore pubblico. Gli stipendi degli impiegati nel settore pubblico sono stati ridotti ogni anno tranne uno tra il 2008 e il 2014 (e solo nel 2009 la riduzione è stata del 7%).
Alcuni di questi tagli si sono basati su accordi collettivi sottoscritti a malincuore anche dai sindacati, i quali venivano minacciati con misure unilaterali addirittura più severe. Gli accordi prevedevano anche la promessa di tornare indietro sui tagli previsti una volta stabilizzate le finanze pubbliche. Negli ultimi anni, la discussione è perciò virata sul ripristino dei livelli salariali del settore pubblico. Tuttavia, la versione corrente dell’Accordo sulla Stabilità del Servizio Pubblico dà ancora priorità alla disciplina fiscale non occupandosi delle gravi ingiustizie nella gestione dei dipendenti pubblici.
Su chi grava il peso
Riguardando l’intero servizio pubblico (dal lavoro d’ufficio, fino all’applicazione della legge sui servizi sanitari e l’educazione) questo accordo gode del supporto dei sindacati generali del settore pubblico (come il Siptu e l’Impact), i quali di regola evitano il confronto con il governo su vasta scala. Visto che i sindacati professionali del servizio pubblico (incluse le infermiere) avrebbero rischiato di non ottenere nulla andando da soli, hanno sottoscritto l’accordo.
Ma la maggior parte delle infermiere sono rimaste insoddisfatte dal ritmo e dai metodi di ripristino delle retribuzioni. Analogamente a molti altri paesi, il servizio sanitario irlandese sta affrontando una crisi di assunzioni e mantenimento del personale.
Molte delle infermiere irlandesi più qualificate continuano la tradizione di emigrare alla ricerca di salari più alti e migliori condizioni di lavoro in Australia, Canada, Usa o anche nel Regno Unito. Altri se ne vanno per approdare al settore privato. Sommato tutto, la carenza di personale significa una vita lavorativa estenuante e un grosso rischio di crisi da stress per quelli che non sono usciti dal sistema sanitario. È in questo contesto che le infermiere hanno deciso di lanciare la campagna di quest’anno sulla retribuzione.
Il dibattito pubblico tra il governo e i sindacati delle infermiere è ruotato intorno al tema di cosa costituisca un comportamento responsabile in un tale contesto. Il governo insiste sulla presunta necessità di sostenere la responsabilità fiscale.
Il primo ministro (Taoiseach) Leo Varadkar, si è persino spinto a sostenere che lo stato irlandese non può permettersi aumenti salariali del settore pubblico perché deve risparmiare fondi in preparazione di una dura Brexit. «Devo essere Taoiseach per l’intero paese», ha detto Varadkar durante un dibattito nel parlamento irlandese.
La sua dichiarazione è un promemoria di come agisca il governo quando si trova in dispute con i sindacati del settore pubblico: prova a dare un’immagine di sé come guardiano dell’interesse pubblico contro gli irresponsabili gruppi di interesse particolare. La credibilità del governo nello spendere responsabilmente le proprie risorse tuttavia è stata screditata dalle rivelazioni sul costo di un nuovo ospedale per bambini (ancora in costruzione) che ha superato i 400 milioni di euro, un episodio che il ministro della salute ha tentato di insabbiare. In confronto, l’accordo attualmente sul tavolo per risolvere le tensioni con le infermiere costerà al massimo 35 milioni di euro l’anno.
A parte la questione della responsabilità fiscale, i sindacati del servizio pubblico per vincere dispute di questo genere devono essere in grado di convincere i cittadini che non stanno solo lottando per stipendi più alti, ma anche per servizi pubblici di maggiore qualità. Il supporto pubblico è l’arma più potente in mano ai sindacati. L’interruzione del servizio non può fare molti danni finanziari a un governo, in quanto le tasse continuano a essere raccolte mentre il pagamento degli stipendi è sospeso; parallelamente, ci si aspetta che i sindacati coprano le remunerazioni perse dagli scioperanti attraverso i loro fondi per lo sciopero.
Gli organizzatori delle lotte devono anche guardarsi da chi li indica come pericolosi per le vite dei pazienti. Infatti, anche se i servizi di emergenza e soccorso fossero pienamente funzionanti durante lo sciopero delle infermiere, i media irlandesi hanno fatto circolare notizie allarmistiche.Tuttavia, i sindacati sono vivi in questa battaglia mediatica.
L’Irisih Nurses and Midwives’ Organization ha la fama di prendere seriamente le preoccupazioni dei pazienti, già prima dell’attuale sciopero. Dal 2004, l’Inmo ha raccolto dati sul numero di pazienti che giacevano sulle barelle nei reparti e nei pronto soccorso degli ospedali. A questa semplice misurazione è stato anche conferito valore dal Hearth Service Executive; l’Inmo in un secondo momento l’ha poi utilizzata per evidenziare un aspetto del sottofinanziamento degli ospedali tra i più drammatici e che può quindi mobilitare più facilmente la sensibilità dell’opinione pubblica rispetto alle sole cifre della lista d’attesa.
Durante lo sciopero, le leader delle infermiere si sono anche appellate al concetto di sicurezza del paziente, sostenendo che gli attuali livelli di personale sono pericolosi. È stata resa esplicita la catena causale iniziata dai bassi salari, i quali hanno portato all’emigrazione e alla carenza di manodopera, per arrivare infine a orari di lavoro eccessivi che hanno sfiancato il personale residuo.
Seppur i gruppi di difesa dei pazienti si siano astenuti dal prendere posizione nella disputa, il livello del supporto che le infermiere hanno ricevuto durante il loro corteo a Dublino e la copertura mediatica favorevole suggeriscono che le strategie dei sindacati hanno avuto successo. Un sondaggio condotto un giorno prima dello sciopero su un campione di 1.000 persone ha mostrato che il 74% supportava la protesta. Oltretutto, a partire dal 7 febbraio 2019, più di 68 mila persone hanno espresso il proprio sostegno firmando una petizione online che «invita il governo a prendere provvedimenti e ad aumentare le retribuzioni di infermieri e ostetrici per garantire personale adeguato».
Per decenni, i sindacati nel Nord del mondo hanno dovuto sopportare l’accusa di irresponsabilità economica. Le élite politiche ed economiche incolpavano i militanti sindacali per la crisi di stagnazione degli anni '70, anche se il collegamento causale non è stato mai provato. Sulla scia dell’assalto neoconservatore degli anni '80, i leader sindacali hanno interiorizzato questa responsabilità e, ovunque hanno potuto, hanno preso parte a patti sociali che hanno preservato il loro status istituzionale, ma che non hanno portato grande apporto materiale ai propri aderenti.
La crisi del 2008 ha trovato un movimento sindacale i cui membri erano decimati e il cui centro di gravità si era spostato verso il settore pubblico. Le élite politiche ed economiche hanno usato l’austerità post-2008 anche come un’opportunità per lanciare un altro duro colpo al movimento. Tuttavia, hanno anche provocato una nuova radicalità dei sindacati del settore pubblico che può essere uno dei primi segnali di rinnovamento del movimento dei lavoratori e delle lavoratrici.
Molti osservatori (anche quelli di sinistra) pensano che lo spostamento delle proteste del lavoro verso il settore pubblico peggiori l’immagine dei sindacati come gruppi irresponsabili di interessi particolari. Il messaggio principale dello sciopero delle infermiere irlandesi è che non è necessariamente così. I sindacati possono mostrare la propria responsabilità sociale senza rinunciare ad azioni radicali in difesa dei salari e dei servizi pubblici.
di Imre G. Szabó detentrice di ricerca post-dottorato all’University College di Dublino, si occupa di sindacati e della governance economica dell’Unione europea.
Fonte
Manganelli quattro stagioni. Capitolo II – Il Mostro di Modena
di Giovanni Iozzoli
In un’escalation micidiale, preoccupante ed esaltante, la lotta ai cancelli dell’Italpizza sta continuando giorno dopo giorno – sotto le piogge dispettose di maggio come sotto il caldo torrido e spossante di questo fine giugno. Ormai da mesi, i bravi cittadini modenesi – almeno quelli non abituati a girare sempre la testa dall’altra parte – stanno assistendo a un crescendo di cariche poliziesche, pestaggi e lanci di lacrimogeni, sparati addosso – principalmente – a donne armate solo della loro tenacia, che cercano di strappare a questa azienda perla dell’agroalimentare italiano, condizioni un minimo dignitose di vita e di lavoro: perché in questi tempi cupi, la divisione sindacalese tra contrattazione “acquisitiva” e “difensiva” non esiste più – nelle aziende spesso si lotta per sopravvivere, per strappare al padrone qualche centesimo in più di paga oraria, il diritto alle pause, ai bagni, al non essere considerata merce disponibile 24 ore su 24. E la sproporzione drammatica tra la quantità di lotte necessarie e la qualità modesta delle rivendicazioni, dà la cifra dello sprofondamento di questo paese di merda nel suo passato più regressivo.
Il sindaco – appena rieletto – tifa per l’azienda, così come la stragrande maggioranza del quadro politico e dei mezzi di informazione. La Cgil si è impantanata in un tavolo che le porterà solo ulteriore discredito e perdita di iscritti dentro quel sito. Ogni giorno un reparto di energumeni in divisa, bardati come se andassero in missione all’estero, attacca questi presidi sostanzialmente indifesi: ad animarli sono cobas, sono stranieri, sono donne – la loro incolumità e la loro fedina penale vale poco, sul mercato della cittadinanza in cui tutti noi, oggi, siamo pesati per censo e potere sociale – nella modernità “castale” che caratterizza le nostre società. Associazioni come Non una di meno, Case del Popolo, comitati per il boicottaggio di Italpizza, realtà di base, delegati sindacali del territorio – chi può sta cercando di esprimere solidarietà a questa cruciale battaglia popolare: il resto di quel che residua della famosa “società civile” (di cui fino a qualche anno fa si favoleggiava ampiamente, insieme all’altra chimera: il ceto medio riflessivo...), tace e acconsente, dando ormai per scontato che il mercato del lavoro debba essere strutturato a gironi – come l’inferno dantesco – e che sia necessaria e fisiologica per il funzionamento del sistema, una massa – crescente – di neoschiavi “multiservizi” (com’è denominato il loro contratto prevalente).
La tensione sta salendo, dicevamo. Il caldo torrido, la disperazione, gli scioperi che falcidiano stipendi già miserabili. Ormai è in gioco la dignità: le persone hanno fatto quel famoso “scatto” che trasforma i mesi in anni e fa crescere la coscienza di sé oltre la miseria della propria condizione di merce. L’atmosfera è quella che è, pesante, acida. Ci si butta davanti alle ruote dei camion. Si è storditi dai fetentissimi gas CS, si ruzzola sul tappeto di lacrimogeni che ormai nessuno raccoglie più, come fossero un arredo stradale. Basta poco. Forse il 14 settembre del 2016, davanti alla GLS di Piacenza, il clima era anche migliore di quello che si registra oggi all’Italpizza; probabilmente nessuno si aspettava quello che successe quella mattina piena di luce padana. Ahmed Abdel Salam, nel corso di un presidio davanti a quell’obbrobrio di capannone grigiastro, fini sotto le ruote di un Tir che stava cercando di bypassare i manifestanti schierati davanti ai cancelli, per portare fuori il suo preziosissimo carico di cianfrusaglie e salvarlo da quell’embargo dei poveri che è il picchetto operaio. E quando ci scappa il morto, tutti – dopo – corrono a prendere posizioni responsabili e pacificatrici: inni al dialogo, recriminazioni, associazioni datoriali costernate, solenni denunce sindacali, ispezioni ministeriali. Ecco, sulla vicenda Italpizza oggi – chi vuole, chi se la sente, chi ha ancora un po’ di sangue nelle vene o di coraggio civile o di consapevolezza del suo ruolo se fa il sindacalista, o anche se è un semplice cittadino che non si rassegna al ruolo assegnatogli di pubblico televisivo e platea elettorale – ebbene, sulla vicenda Italpizza, dicevamo, facciamo in tempo a parlare prima che il sangue operaio bagni l’asfalto come successe a Piacenza tre anni fa.
Non è scontato lo schieramento. Il nemico è solido. L’azienda è agguerrita, attrezzata, unge molte ruote, cura i rapporti con la stampa, gestisce finte informatissime pagine Facebook che incitano al crumiraggio e all’ostilità antioperaia. E la Questura è criminalmente determinata a fornire la sua manovalanza al servizio del padrone – e queste cose, si sa, sono decise a Roma, perché quando Salvini parla di sicurezza è precisamente della sicurezza delle tante Italpizza d’Italia, che si preoccupa, altro che i barconi. Quindi, la partita a San Donnino è cruciale, di sicuro spessore nazionale, di valore esemplare – sui temi degli appalti interni e dell’assetto del mercato del lavoro italiano. Si può provare a farlo diventare davvero un terreno ricompositivo, generale, per tutti quelli che in questo lungo anno di governo hanno arrancato nel tentativo di capire qual è il “punto d’attacco” con cui contrastare l’esecutivo gialloverde: Salvini è lì, dietro le inferriate di Italpizza, ci sta sfidando, ci fa ciao con la manina, ci invita a giocarcela fino in fondo. Sa che fino a quando le operaie e gli operai di Italpizza restano soli, il suo Governo non deve temere nulla – perché vuol dire che il paese è ancora in stato neurovegetativo, che nessuno potrà scuotere il laido consenso di cui gode.
Qualche giorno fa, un docufilm realizzato e trasmesso da Sky – Il Mostro di Modena – ha rilanciato in città la memoria di un presunto serial killer che agì sul territorio negli anni ’80 e poi sparì nel nulla, ignoto e impunito. Il prodotto è risultato di grande qualità e ha coinvolto molto l’opinione pubblica, che aveva rimosso quelle antiche storie. Chi ci pensava più, al Mostro di Modena? Suggestionato da questa visione televisiva, il nuovo Capo della Procura Giovagnoli, ha chiesto alla sua polizia giudiziaria di tirare fuori i vecchi faldoni delle inchieste di 35 anni fa, per verificare se sussistano oggi elementi utili per riaprire le indagini sul Mostro.
Certo, con la folla di mariti e fidanzatini assassini che continuano a “mostrificare” gli ambienti familiari, seminando morte e violenza, l’idea di questo vecchio serial killer in circolazione non spaventa più nessuno. Anche su quel terreno, ne abbiamo fatta di strada. Però viene da chiedersi: se basta un programma televisivo a riattizzare gli interessi della Procura su vecchie tragedie, perché non proviamo a spedire a Giovagnoli almeno una parte delle molte inchieste giornalistiche (anche televisive) che hanno raccontato in questi anni il distretto carni, la filiera agroalimentare e altre velenosissime specialità in salsa emiliana? Perché non gli mostriamo il racconto drammatico e rabbioso delle vite piegate e spremute di migliaia e migliaia di operai e di operaie che lavorano nella vetrina dell’eccellenza emiliana, ricavandone meno del minimo vitale? Se basta la visibilità televisiva, per occuparsi dei crimini, i “mostri” dell’imprenditoria modenese – quelli che stanno forgiando un nuovo perverso “modello emiliano” – hanno già accumulato un bel po’ di meriti e celebrità. Già, mentre cerchiamo di scovare i fantasmi dei vecchi killer della nostra memoria, cerchiamo di chiederci: chi sono oggi i nuovi Mostri di Modena? Chi ci sta uccidendo, lentamente, ogni giorno, corrompendoci e assuefacendoci alle sue brutture e alle ragioni dei suoi profitti?
Manganelli quattro stagioni – Cap. I
Fonte
In un’escalation micidiale, preoccupante ed esaltante, la lotta ai cancelli dell’Italpizza sta continuando giorno dopo giorno – sotto le piogge dispettose di maggio come sotto il caldo torrido e spossante di questo fine giugno. Ormai da mesi, i bravi cittadini modenesi – almeno quelli non abituati a girare sempre la testa dall’altra parte – stanno assistendo a un crescendo di cariche poliziesche, pestaggi e lanci di lacrimogeni, sparati addosso – principalmente – a donne armate solo della loro tenacia, che cercano di strappare a questa azienda perla dell’agroalimentare italiano, condizioni un minimo dignitose di vita e di lavoro: perché in questi tempi cupi, la divisione sindacalese tra contrattazione “acquisitiva” e “difensiva” non esiste più – nelle aziende spesso si lotta per sopravvivere, per strappare al padrone qualche centesimo in più di paga oraria, il diritto alle pause, ai bagni, al non essere considerata merce disponibile 24 ore su 24. E la sproporzione drammatica tra la quantità di lotte necessarie e la qualità modesta delle rivendicazioni, dà la cifra dello sprofondamento di questo paese di merda nel suo passato più regressivo.
Il sindaco – appena rieletto – tifa per l’azienda, così come la stragrande maggioranza del quadro politico e dei mezzi di informazione. La Cgil si è impantanata in un tavolo che le porterà solo ulteriore discredito e perdita di iscritti dentro quel sito. Ogni giorno un reparto di energumeni in divisa, bardati come se andassero in missione all’estero, attacca questi presidi sostanzialmente indifesi: ad animarli sono cobas, sono stranieri, sono donne – la loro incolumità e la loro fedina penale vale poco, sul mercato della cittadinanza in cui tutti noi, oggi, siamo pesati per censo e potere sociale – nella modernità “castale” che caratterizza le nostre società. Associazioni come Non una di meno, Case del Popolo, comitati per il boicottaggio di Italpizza, realtà di base, delegati sindacali del territorio – chi può sta cercando di esprimere solidarietà a questa cruciale battaglia popolare: il resto di quel che residua della famosa “società civile” (di cui fino a qualche anno fa si favoleggiava ampiamente, insieme all’altra chimera: il ceto medio riflessivo...), tace e acconsente, dando ormai per scontato che il mercato del lavoro debba essere strutturato a gironi – come l’inferno dantesco – e che sia necessaria e fisiologica per il funzionamento del sistema, una massa – crescente – di neoschiavi “multiservizi” (com’è denominato il loro contratto prevalente).
La tensione sta salendo, dicevamo. Il caldo torrido, la disperazione, gli scioperi che falcidiano stipendi già miserabili. Ormai è in gioco la dignità: le persone hanno fatto quel famoso “scatto” che trasforma i mesi in anni e fa crescere la coscienza di sé oltre la miseria della propria condizione di merce. L’atmosfera è quella che è, pesante, acida. Ci si butta davanti alle ruote dei camion. Si è storditi dai fetentissimi gas CS, si ruzzola sul tappeto di lacrimogeni che ormai nessuno raccoglie più, come fossero un arredo stradale. Basta poco. Forse il 14 settembre del 2016, davanti alla GLS di Piacenza, il clima era anche migliore di quello che si registra oggi all’Italpizza; probabilmente nessuno si aspettava quello che successe quella mattina piena di luce padana. Ahmed Abdel Salam, nel corso di un presidio davanti a quell’obbrobrio di capannone grigiastro, fini sotto le ruote di un Tir che stava cercando di bypassare i manifestanti schierati davanti ai cancelli, per portare fuori il suo preziosissimo carico di cianfrusaglie e salvarlo da quell’embargo dei poveri che è il picchetto operaio. E quando ci scappa il morto, tutti – dopo – corrono a prendere posizioni responsabili e pacificatrici: inni al dialogo, recriminazioni, associazioni datoriali costernate, solenni denunce sindacali, ispezioni ministeriali. Ecco, sulla vicenda Italpizza oggi – chi vuole, chi se la sente, chi ha ancora un po’ di sangue nelle vene o di coraggio civile o di consapevolezza del suo ruolo se fa il sindacalista, o anche se è un semplice cittadino che non si rassegna al ruolo assegnatogli di pubblico televisivo e platea elettorale – ebbene, sulla vicenda Italpizza, dicevamo, facciamo in tempo a parlare prima che il sangue operaio bagni l’asfalto come successe a Piacenza tre anni fa.
Non è scontato lo schieramento. Il nemico è solido. L’azienda è agguerrita, attrezzata, unge molte ruote, cura i rapporti con la stampa, gestisce finte informatissime pagine Facebook che incitano al crumiraggio e all’ostilità antioperaia. E la Questura è criminalmente determinata a fornire la sua manovalanza al servizio del padrone – e queste cose, si sa, sono decise a Roma, perché quando Salvini parla di sicurezza è precisamente della sicurezza delle tante Italpizza d’Italia, che si preoccupa, altro che i barconi. Quindi, la partita a San Donnino è cruciale, di sicuro spessore nazionale, di valore esemplare – sui temi degli appalti interni e dell’assetto del mercato del lavoro italiano. Si può provare a farlo diventare davvero un terreno ricompositivo, generale, per tutti quelli che in questo lungo anno di governo hanno arrancato nel tentativo di capire qual è il “punto d’attacco” con cui contrastare l’esecutivo gialloverde: Salvini è lì, dietro le inferriate di Italpizza, ci sta sfidando, ci fa ciao con la manina, ci invita a giocarcela fino in fondo. Sa che fino a quando le operaie e gli operai di Italpizza restano soli, il suo Governo non deve temere nulla – perché vuol dire che il paese è ancora in stato neurovegetativo, che nessuno potrà scuotere il laido consenso di cui gode.
Qualche giorno fa, un docufilm realizzato e trasmesso da Sky – Il Mostro di Modena – ha rilanciato in città la memoria di un presunto serial killer che agì sul territorio negli anni ’80 e poi sparì nel nulla, ignoto e impunito. Il prodotto è risultato di grande qualità e ha coinvolto molto l’opinione pubblica, che aveva rimosso quelle antiche storie. Chi ci pensava più, al Mostro di Modena? Suggestionato da questa visione televisiva, il nuovo Capo della Procura Giovagnoli, ha chiesto alla sua polizia giudiziaria di tirare fuori i vecchi faldoni delle inchieste di 35 anni fa, per verificare se sussistano oggi elementi utili per riaprire le indagini sul Mostro.
Certo, con la folla di mariti e fidanzatini assassini che continuano a “mostrificare” gli ambienti familiari, seminando morte e violenza, l’idea di questo vecchio serial killer in circolazione non spaventa più nessuno. Anche su quel terreno, ne abbiamo fatta di strada. Però viene da chiedersi: se basta un programma televisivo a riattizzare gli interessi della Procura su vecchie tragedie, perché non proviamo a spedire a Giovagnoli almeno una parte delle molte inchieste giornalistiche (anche televisive) che hanno raccontato in questi anni il distretto carni, la filiera agroalimentare e altre velenosissime specialità in salsa emiliana? Perché non gli mostriamo il racconto drammatico e rabbioso delle vite piegate e spremute di migliaia e migliaia di operai e di operaie che lavorano nella vetrina dell’eccellenza emiliana, ricavandone meno del minimo vitale? Se basta la visibilità televisiva, per occuparsi dei crimini, i “mostri” dell’imprenditoria modenese – quelli che stanno forgiando un nuovo perverso “modello emiliano” – hanno già accumulato un bel po’ di meriti e celebrità. Già, mentre cerchiamo di scovare i fantasmi dei vecchi killer della nostra memoria, cerchiamo di chiederci: chi sono oggi i nuovi Mostri di Modena? Chi ci sta uccidendo, lentamente, ogni giorno, corrompendoci e assuefacendoci alle sue brutture e alle ragioni dei suoi profitti?
Manganelli quattro stagioni – Cap. I
Fonte
Luglio 1960
La necessità di rinnovare con costanza la memoria storica del nostra Paese si colloca ben oltre alla discussione sul neofascismo rampante nella difficile situazione dell’Italia di oggi.
Per questo motivo è più che mai valida la ricostruzione storica (pur eseguita in maniera assolutamente sommaria) di ciò che accadde tra la fine di giugno e il luglio del 1960: cinquantanove anni fa.
Era l’Italia del 1960. Ci si trovava in pieno miracolo economico, ma il benessere nascondeva profonde lacerazioni politiche e sociali.
Si stava provando, con fatica, a uscire dagli anni’50 e a far nascere il centrosinistra.
Un giovane democristiano, Fernando Tambroni esponente della corrente del presidente della Repubblica Gronchi, assumeva la Presidenza del Consiglio sostenuto da una maggioranza comprendente il partito neofascista, l’MSI.
Quell’MSI che stava tornando alla ribalta con la sua ideologia e la sua iniziativa, quell’MSI che decise, alla fine del mese di Giugno, di tenere il suo congresso a Genova, Città medaglia d’oro della Resistenza.
L’antifascismo, vecchio e nuovo, disse di no.
Comparvero sulle piazze i giovani dalle magliette a strisce, i portuali, i partigiani.
La Resistenza riuscì a sconfiggere il rigurgito fascista.
Ma si trattò di una vittoria amara, a Reggio Emilia e in altre città la polizia sparò sulla folla causando numerose vittime.
Questi i fatti, accaduti in quell’intenso e drammatico inizio estate di cinquantanove anni fa: è necessario, però, tornarvi sopra per riflettere, partendo da un dato.
Non si trattò semplicemente di un moto di piazza, di opposizione alla scelta provocatoria di una forza politica come quella compiuta dall’MSI di convocare il proprio congresso a Genova e di annunciare anche come quell’assise sarebbe stata presieduta da Basile, soltanto quindici anni prima, protagonista nella stessa Città di torture e massacri verso i partigiani e la popolazione.
Si trattò, invece, di un punto di vero e proprio snodo della storia sociale e politica d’Italia.
Erano ancora vivi e attivi quasi tutti i protagonisti della vicenda che era parsa chiudersi nel 1945, ed è sempre necessario considerare come quei fatti si inserissero dentro una crisi gravissima degli equilibri politici.
Una crisi inserita anche in un mutamento profondo dello scenario internazionale, nel quale si muovevano i primi passi del processo di distensione ed era in atto il fenomeno della “decolonizzazione”, in particolare, in Africa, con la nascita del movimento dei “non allineati”.
Prima ancora, però, dovrebbe essere valutato un elemento di fondamentale importanza: si è già accennato all’entrata in scena di quella che fu definita la generazione “dalle magliette a strisce”, i giovani che per motivi d’età non avevano fatto la Resistenza, ma ne avevano respirato l’aria entrando in fabbrica o studiando all’Università accanto ai fratelli maggiori; giovani che avevano vissuto il passaggio dall’Italia arretrata degli anni’40-’50 all’Italia del boom, della modernizzazione, del consumismo, delle migrazioni bibliche dal Sud al Nord, di una difficile integrazione sociale e culturale.
In questo senso i moti del Luglio ’60 non possono essere considerati semplicemente un punto di saldatura tra le generazioni, anzi rappresentavano un momento di conflitto, di richiesta di cambiamento profondo, non limitato agli equilibri politici.
In quel Luglio ’60, da non considerare – ripetiamo – soltanto per i fatti accaduti in quei giorni, ma nel complesso di una fase di cambiamento della società e della politica, si aprì, ancora, a sinistra, una discussione sulla natura della DC, fino a quel momento perno fondamentale del sistema politico italiano.
Molti si chiesero, a quel momento, se dentro la DC covasse il “vero fascismo” italiano: non quello rumoroso e un poco patetico del MSI, ma quello vero; quello che poteva considerarsi il vero referente dei ceti dominanti, capace di portare al blocco sociale di potere l’apporto della piccola e media borghesia.
Il partito democristiano appariva, dunque, a una parte della sinistra, soprattutto nei giorni infuocati della repressione, come il partito che avrebbe potuto in qualunque momento rimettere in moto in Italia (ricordiamolo ancora una volta: eravamo a soli quindici anni dalla Liberazione) un meccanismo politico–sociale repressivo e autoritario tale da dar vita a nuove esperienze di tipo fascista.
L’analisi sviluppata dal PCI togliattiano fu diversa.
Nonostante le asprezze della polemica quotidiana, il PCI aveva assunto come stella polare di tutta la sua strategia l’intesa con le masse cattoliche, da sottrarre al predominio moderato prevalente dal ’47 in poi (grazie alla “guerra fredda”) al vertice della DC.
Ma la prospettiva non era così ingenua: essa comportava il proposito di far emergere le forze presenti all’interno della DC, anche al vertice del partito.
In quel Luglio ’60 il PCI cercò di operare in quella direzione, e il successo dello sciopero generale, pur macchiato di sangue, si rivelò efficace e significativo anche perché dall’interno della DC si aprì finalmente un varco a quella parte del gruppo dirigente che, sulle rovine dell’esperimento Tambroni, poté riproporre con maggiore efficacia e speranza di esito positivo una soluzione diversa: quella che abbiamo già richiamato delle “convergenze parallele” e, successivamente, del centrosinistra “organico”.
Oggi, a cinquantanove anni di distanza, possiamo meglio valutare l’esito di quei fatti: le contraddizioni che ne seguirono, il rattrappirsi progressivo della realtà riformatrice (a partire dal “tintinnar di sciabole” dell’estate 1964, fino alla disgraziata stagione del terrorismo, aperta nel 1969 dalle bombe di Piazza della Fontana), l’assunzione, in particolare da parte del PSI, via, via, di una vocazione “governista” sfociata nel decisionismo craxiano, i limiti di puro politicismo insiti nella strategia berlingueriana del “compromesso storico”, nello sviluppo abnorme di quella che già dagli anni’50 Maranini aveva definito come partitocrazia (con il contributo di un complessivo “consociativismo” allargato all’intero arco parlamentare) e, infine, nella “questione morale” che segnò, all’inizio degli anni’90, lo sconquasso definitivo del quadro di governo in coincidenza con la caduta del muro di Berlino (sulla quale furono commessi errori di valutazione enormi) e l’avvio, con il trattato di Maastricht, della logica monetarista anti-democratica di gestione dell’Unione Europea sul modello reaganian-tachteriano della crescita delle diseguaglianze economiche e sociali fino alla drammatica attualità che stiamo vivendo in un quadro esaltato da un insieme di valori negativi.
Forse luglio ’60 rappresentò uno degli ultimi passaggi utili per contrastare radicalmente questo processo di involuzione e riproporre alcune radici di fondo della prospettiva resistenziale ma è necessario ammettere, anche in un momento di rievocazione importante come l’attuale, che quel messaggio non fu completamente colto.
Fonte
Etichette:
30 giugno 1960,
Antifascismo,
Compromesso storico,
DC,
Degenero,
Franco Astengo,
Genova,
Governo Tambroni,
Italia,
Memoria storica,
MSI,
Normalizzazione,
PCI,
Resistenza
Da Lampedusa spiegazioni semplici sulla vicenda Sea Watch
Spieghiamo perché ha ragione la Sea Watch, rispondendo alle domande che si stanno ponendo in tanti.
1) Perché le ONG vengono in Italia?
Perché le leggi internazionali chiedono di portare i migranti nel PRIMO porto SICURO.
Ma Malta? E poi siamo sicuri che l’Italia è un porto sicuro? Ma siamo coscienti della vita che fanno molte delle persone migranti costrette a rimanere in Italia dal trattato di Dublino? Io l’anno scorso a Lampedusa ho visto il cadavere di un tunisino che si era impiccato per le condizioni dell'hotspot e perché era trattenuto da tempo sull’isola e altri ragazzi tunisini che per lo stesso motivo tentarono il suicidio... ma queste notizie forse non vi arrivano perché il centro di Lampedusa viene descritto come un modello... dove eroi e ministri passeggiano con bimbe africane in braccio in favore di telecamera... per quel suicidio ricordo poca indignazione, giornalisti e politici...
2) Perché non li riportano in Libia?
Perché la Libia non è un porto sicuro: c’è la guerra e ci sono i campi di concentramento.
“La Libia”... è bene specificare che la guerra in atto è un’aggressione imperialista (e no come si legge da qualche parte “una guerra civile”) e che i campi di concentramento sono gestiti dal governo fantoccio messo dalla NATO a cui l’UE fa riferimento. Gli addestriamo anche la Guardia Costiera... capite bene che poi quando si fa riferimento a normative e istituzioni UE come giustificazioni o anche attestazioni di giustizia e civiltà qualcosa non torna...
3) Perché non li portano in Tunisia?
Perché la Tunisia non ha firmato la Convenzione di Ginevra e perché in passato ha riportato i migranti in Libia.
Veramente di migranti in Libia ne ha riportati molti di più l’UE.
4) Perché non li portano a Malta?
Li portano eccome a Malta! Malta ha accolto in proporzione molti più immigrati di noi e continua ad accoglierli. Però Malta non è sempre il porto più vicino, dipende dove viene effettuato il salvataggio (e bisogna guardare anche le condizioni del mare).
In questo caso il porto sicuro più vicino era Lampedusa (ci piaccia o no).
Non so se Lampedusa fosse da subito il porto più vicino ma se ti negano l’attracco penso si debba provare da un’altra parte e se tutti negano l’attracco allora non è l’Italia ad essere un paese di merda ma tutta l’UE a cominciare dall’Italia.
5) Perché l’Olanda e la Germania non se ne prendono un po’?
Ci sono 10 città tedesche che in realtà si sono dichiarate disponibili a farlo. Il problema è che mancano gli accordi internazionali. Salvini in questo anno di governo avrebbe dovuto fare questo tipo di accordi, ma è stato assente 6 volte su 7 alle riunioni. Se è sempre assente è difficile che riesca a fare accordi.
Salvini vuole arrivare ad una rottura con l’UE stimolato dagli USA. Ma il problema sono gli accordi di Dublino che l’UE non ha nessuna intenzione di modificare. Salvini rimane uno che usa la disperazione altrui per fare politica, come la maggior parte dei politici attualmente in “campo”.
6) E quindi dobbiamo accoglierli tutti?
No, noi dobbiamo salvarli, perché i diritti umani vengono prima di ogni altra cosa. Il salvataggio si conclude quando le persone a bordo sbarcano in un porto sicuro. Il fatto dell’accoglienza poi dipende dagli accordi che i Paesi riescono a fare.
I diritti umani? No, non vengono prima di tutto, forse prima di tutto viene la vita (anche se pure questa certezza comincia a vacillare)... “il fatto dell’accoglienza” è vincolato dagli accordi di Dublino ne sono una prova i ricollocamenti che sono stati effettuati in percentuali irrisorie.
7) Ma la Sea Watch ha violato le leggi italiane?
La Sea Watch ha violato il decreto di Salvini, ma ha agito secondo il diritto del mare e l’articolo 10 della nostra Costituzione.
Io non ne faccio una questione di legalità ma se vogliamo scendere in questi meandri dovremmo prima, almeno io (forse l’autore del post è un esperto di leggi), studiare seriamente le leggi in materia... è possibile anche che la Sea Watch non violi nessuna legge.
Fonte
Emigrazione. Soluzioni complessive e scelte concrete
Circa 7,5 miliardi di persone vivono oggi nel pianeta. Negli anni ’50 eravamo 3 volte di meno. Nel 2050 potremmo raggiungere i 10 miliardi (fonte: Nazioni Unite – World Population Prospects 2019).
È chiaro che i flussi migratori, in particolare se continua a mantenersi questo abnorme dislivello tra Paesi del Nord e Sud del mondo, continueranno ed aumenteranno.
È ovvio. Dalla stessa Sicilia migriamo in tanti, non pieni di gioia, verso luoghi in cui si trovano più opportunità. Immaginatevi quindi chi vive in Africa, in luoghi come il Kenya o il Ghana, dove ci sono slum (baraccopoli), difficoltà di ogni tipo nei villaggi rurali, tra malattie, siccità, alluvioni, carestie.
Non è un’esagerazione. Dati alla mano, nel 2017 circa il 9% dei lavoratori del mondo viveva mantenendo la propria famiglia con meno di 2 dollari al giorno (fonte: Nazioni Unite – SDG 1, qui: https://sustainabledevelopment.un.org/sdg1).
Nel 2015 circa 890 milioni di persone nel mondo non avevano un bagno (neppure una latrina) in cui andare, praticando quindi la defecazione all’aperto, con gli annessi rischi igienico-sanitari (fonte: Nazioni Unite, SDG 6, qui: https://sustainabledevelopment.un.org/sdg6).
Vanno anche ricordate le guerre che affliggono Paesi a noi vicini, dalla Libia, alla Siria, all’Iraq, allo Yemen; luoghi in cui i nostri governi sono stati direttamente responsabili di quel caos (in particolare Libia e Iraq), oppure indirettamente (le armi con cui è bombardato lo Yemen le vende anche l’Itala, e per quanto riguarda la Siria beh noi siamo alleati nella NATO con la Turchia e gli Stati Uniti...).
Finché si mantiene tutto questo, anche “solo” concentrandoci su Paesi senza guerra ma con aree fortemente povere, come possiamo pretendere di voler “bloccare” i flussi migratori?!? Quando noi stessi siamo i primi a volerli e poterli fare. (Io dalla Sicilia alla Lombardia ad esempio per ora, così come altri miei amici, emigrati in Lombardia, Piemonte, Francia, Inghilterra, Germania...).
Siamo gli stessi odiati ieri da Salvini, che adesso ci fa le coccole perché vuole i nostri voti senza risolvere nulla. Sfruttando solo la paura verso il “diverso”.
I flussi migratori hanno cercato di bloccarli e ridurli già pochi anni fa. Lo ha fatto il PD durante il governo precedente (ha ridotto davvero i flussi, facendo restare molta gente bloccata in Libia, creando centri di detenzione in quell’inferno). Ma questa non è civiltà. È orrore. È malattia umana.
I flussi migratori devono semmai ricordarci che c’è uno squilibrio nel mondo, tra Nord e Sud, anche in Italia. E non saranno i muri o nuove leggi barbare a bloccare le persone. Va semmai abolita questa disuguaglianza. È un sistema ad essere marcio.
Che soluzione propongo nel breve periodo? Non ho bacchette magiche. Ma di certo muri e leggi ingiuste non fermeranno nulla. Rallenteranno qualcosa che sta già avvenendo. Presto saremo quasi 10 miliardi. Un terzo in più di oggi nel pianeta. E la disperazione, quando inascoltata, alimenta la rabbia. (Penso a Maria Antonietta e alla Rivoluzione Francese, ma più in grande... prima o poi non saremo più in grado di contenere questo ingiusto squilibrio).
Quindi opponiamoci a questo sistema, non accettiamo il gioco delle parti di Salvini-5 Stelle contro il PD. Chi ci governa oggi è più viscido di chi ci ha governato ieri, ma fanno schifo tutti questi giocatori.
Nel frattempo... apriamo i porti alle persone e chiudiamoli alle armi!
Fonte
È chiaro che i flussi migratori, in particolare se continua a mantenersi questo abnorme dislivello tra Paesi del Nord e Sud del mondo, continueranno ed aumenteranno.
È ovvio. Dalla stessa Sicilia migriamo in tanti, non pieni di gioia, verso luoghi in cui si trovano più opportunità. Immaginatevi quindi chi vive in Africa, in luoghi come il Kenya o il Ghana, dove ci sono slum (baraccopoli), difficoltà di ogni tipo nei villaggi rurali, tra malattie, siccità, alluvioni, carestie.
Non è un’esagerazione. Dati alla mano, nel 2017 circa il 9% dei lavoratori del mondo viveva mantenendo la propria famiglia con meno di 2 dollari al giorno (fonte: Nazioni Unite – SDG 1, qui: https://sustainabledevelopment.un.org/sdg1).
Nel 2015 circa 890 milioni di persone nel mondo non avevano un bagno (neppure una latrina) in cui andare, praticando quindi la defecazione all’aperto, con gli annessi rischi igienico-sanitari (fonte: Nazioni Unite, SDG 6, qui: https://sustainabledevelopment.un.org/sdg6).
Vanno anche ricordate le guerre che affliggono Paesi a noi vicini, dalla Libia, alla Siria, all’Iraq, allo Yemen; luoghi in cui i nostri governi sono stati direttamente responsabili di quel caos (in particolare Libia e Iraq), oppure indirettamente (le armi con cui è bombardato lo Yemen le vende anche l’Itala, e per quanto riguarda la Siria beh noi siamo alleati nella NATO con la Turchia e gli Stati Uniti...).
Finché si mantiene tutto questo, anche “solo” concentrandoci su Paesi senza guerra ma con aree fortemente povere, come possiamo pretendere di voler “bloccare” i flussi migratori?!? Quando noi stessi siamo i primi a volerli e poterli fare. (Io dalla Sicilia alla Lombardia ad esempio per ora, così come altri miei amici, emigrati in Lombardia, Piemonte, Francia, Inghilterra, Germania...).
Siamo gli stessi odiati ieri da Salvini, che adesso ci fa le coccole perché vuole i nostri voti senza risolvere nulla. Sfruttando solo la paura verso il “diverso”.
I flussi migratori hanno cercato di bloccarli e ridurli già pochi anni fa. Lo ha fatto il PD durante il governo precedente (ha ridotto davvero i flussi, facendo restare molta gente bloccata in Libia, creando centri di detenzione in quell’inferno). Ma questa non è civiltà. È orrore. È malattia umana.
I flussi migratori devono semmai ricordarci che c’è uno squilibrio nel mondo, tra Nord e Sud, anche in Italia. E non saranno i muri o nuove leggi barbare a bloccare le persone. Va semmai abolita questa disuguaglianza. È un sistema ad essere marcio.
Che soluzione propongo nel breve periodo? Non ho bacchette magiche. Ma di certo muri e leggi ingiuste non fermeranno nulla. Rallenteranno qualcosa che sta già avvenendo. Presto saremo quasi 10 miliardi. Un terzo in più di oggi nel pianeta. E la disperazione, quando inascoltata, alimenta la rabbia. (Penso a Maria Antonietta e alla Rivoluzione Francese, ma più in grande... prima o poi non saremo più in grado di contenere questo ingiusto squilibrio).
Quindi opponiamoci a questo sistema, non accettiamo il gioco delle parti di Salvini-5 Stelle contro il PD. Chi ci governa oggi è più viscido di chi ci ha governato ieri, ma fanno schifo tutti questi giocatori.
Nel frattempo... apriamo i porti alle persone e chiudiamoli alle armi!
Fonte
Gerusalemme - Torna l'Intifada
di Michele Giorgio – il Manifesto
Ore di sangue e scontri a Issawiya, un sobborgo-ghetto di Gerusalemme, dove la notte di giovedì e ieri, decine di giovani palestinesi hanno affrontato la polizia israeliana. Mohamed Obeid, un giovane di 20 anni è stato ucciso. I poliziotti gli hanno sparato contro centrandolo in pieno petto. È morto poco dopo, nell’ambulanza che lo portava all’ospedale. La rabbia per questa uccisione ha innescato nuovi scontri. Il fuoco della polizia e i candelotti lacrimogeni hanno fatto una ventina di feriti. Almeno due palestinesi sono stati arrestati. La tensione si è subito estesa ad altri quartieri della zona araba, Est, di Gerusalemme, occupata nel 1967 ed annessa unilateralmente a Israele. In particolare a Sur Baher e Silwan, dove le autorità israeliane di recente hanno consegnato nuovi ordini di demolizione di case palestinesi giudicate “abusive”.
A Issawiya si sono rivissute, dopo lungo tempo, scene dell’Intifada palestinese contro l’occupazione. Il quartiere, povero, quasi privo di servizi e sovraffollato, è situato ai piedi di quella parte di Gerusalemme che guarda verso Gerico e la valle del Giordano. La sua miseria contrasta con l’ordine e il decoro della vicina Collina Francese, costruita da Israele dopo il 1967 nelle terre appena occupate, e dell’Università ebraica. Degrado, frustrazione e la consapevolezza di vivere ai margini di una vita dignitosa hanno creato una miscela esplosiva a Issawiya. Per le autorità israeliane il quartiere è solo una fonte di problemi, una base per le attività illegali e un rifugio per i ricercati politici. L’altra notte Issawiya è stato circondato. Con i reparti antisommossa della polizia lanciati a caccia di un militante del Fronte popolare per la Liberazione della Palestina. Perquisite dozzine di case mentre in strada si vedevano giovani lanciare sassi verso gli agenti e urlare slogan. Testimoni dicono che i poliziotti hanno sparato tre colpi contro Mohammed Obeid. Altri negano che il giovane avesse lanciato petardi. Obeid era stato rilasciato un anno fa dopo aver passato venti mesi dietro le sbarre per motivi politici.
Ieri almeno 7mila palestinesi hanno partecipato, a ridosso della linee con Israele, alle proteste del venerdì della Grande Marcia del Ritorno contro il blocco di Gaza. I feriti sono stati una cinquantina di cui una dozzina dai colpi sparati dai cecchini dell’esercito israeliano. Le manifestazioni si sono svolte ugualmente nonostante l’accordo raggiunto giovedì notte da Israele e il movimento islamico Hamas, con la mediazione dell’Egitto e dell’Onu, che dovrebbe vedere il governo Netanyahu tornare ad estendere fino a 15 miglia l’area di pesca per i pescatori di Gaza e permettere le forniture per la centrale elettrica bloccate giorni fa. Da parte sua Hamas si sarebbe impegnato a fermare i lanci di palloni incendiari verso il Neghev. Lanci che sono proseguiti almeno fino a ieri pomeriggio provocando diversi incendi di coltivazioni e vegetazione secca nel sud di Israele.
Fonte
Ore di sangue e scontri a Issawiya, un sobborgo-ghetto di Gerusalemme, dove la notte di giovedì e ieri, decine di giovani palestinesi hanno affrontato la polizia israeliana. Mohamed Obeid, un giovane di 20 anni è stato ucciso. I poliziotti gli hanno sparato contro centrandolo in pieno petto. È morto poco dopo, nell’ambulanza che lo portava all’ospedale. La rabbia per questa uccisione ha innescato nuovi scontri. Il fuoco della polizia e i candelotti lacrimogeni hanno fatto una ventina di feriti. Almeno due palestinesi sono stati arrestati. La tensione si è subito estesa ad altri quartieri della zona araba, Est, di Gerusalemme, occupata nel 1967 ed annessa unilateralmente a Israele. In particolare a Sur Baher e Silwan, dove le autorità israeliane di recente hanno consegnato nuovi ordini di demolizione di case palestinesi giudicate “abusive”.
A Issawiya si sono rivissute, dopo lungo tempo, scene dell’Intifada palestinese contro l’occupazione. Il quartiere, povero, quasi privo di servizi e sovraffollato, è situato ai piedi di quella parte di Gerusalemme che guarda verso Gerico e la valle del Giordano. La sua miseria contrasta con l’ordine e il decoro della vicina Collina Francese, costruita da Israele dopo il 1967 nelle terre appena occupate, e dell’Università ebraica. Degrado, frustrazione e la consapevolezza di vivere ai margini di una vita dignitosa hanno creato una miscela esplosiva a Issawiya. Per le autorità israeliane il quartiere è solo una fonte di problemi, una base per le attività illegali e un rifugio per i ricercati politici. L’altra notte Issawiya è stato circondato. Con i reparti antisommossa della polizia lanciati a caccia di un militante del Fronte popolare per la Liberazione della Palestina. Perquisite dozzine di case mentre in strada si vedevano giovani lanciare sassi verso gli agenti e urlare slogan. Testimoni dicono che i poliziotti hanno sparato tre colpi contro Mohammed Obeid. Altri negano che il giovane avesse lanciato petardi. Obeid era stato rilasciato un anno fa dopo aver passato venti mesi dietro le sbarre per motivi politici.
Ieri almeno 7mila palestinesi hanno partecipato, a ridosso della linee con Israele, alle proteste del venerdì della Grande Marcia del Ritorno contro il blocco di Gaza. I feriti sono stati una cinquantina di cui una dozzina dai colpi sparati dai cecchini dell’esercito israeliano. Le manifestazioni si sono svolte ugualmente nonostante l’accordo raggiunto giovedì notte da Israele e il movimento islamico Hamas, con la mediazione dell’Egitto e dell’Onu, che dovrebbe vedere il governo Netanyahu tornare ad estendere fino a 15 miglia l’area di pesca per i pescatori di Gaza e permettere le forniture per la centrale elettrica bloccate giorni fa. Da parte sua Hamas si sarebbe impegnato a fermare i lanci di palloni incendiari verso il Neghev. Lanci che sono proseguiti almeno fino a ieri pomeriggio provocando diversi incendi di coltivazioni e vegetazione secca nel sud di Israele.
Fonte
Iraq - Assaltata l'albasciata del Bahrain per protesta contro il vertice USA a Manama
Ha avuto immediate conseguenze politiche l’assalto all’ambasciata del Bahrain avvenuto ieri sera a Baghdad in
segno di protesta contro il vertice di due giorni sulla questione
israelo-palestinese che ha avuto luogo questa settimana a Manama.
Il piccolo arcipelago del Golfo ha infatti subito richiamato il suo rappresentante diplomatico in Iraq. “Il ministro degli Affari esteri del Regno del Bahrain – si legge sul sito del ministero degli esteri bahrenita – condanna l’attacco all’ambasciata compiuto dai dimostranti e ha deciso di richiamare il suo ambasciatore per consultazioni”. Ma il dito è puntato contro Baghdad che, afferma Manama, è responsabile per la sicurezza dell’ambasciata. Chiamato in ballo, l’esecutivo iracheno ha espresso il suo “profondo rammarico” per quanto accaduto. “Il governo – si legge in una nota – ribadisce il suo assoluto rifiuto per qualunque atto che minacci la sicurezza delle missioni diplomatiche e quella del loro personale”.
Ieri ad attaccare l’edificio diplomatico erano state circa 200 persone. Prima di esseri dispersi dalle forze di sicurezza irachene, i manifestanti, che hanno bruciato bandiere israeliane e americane sventolando quelle della Palestina e dell’Iraq, sono riuscite ad entrare fino al giardino dell’edificio, a rimuovere la bandiera del Bahrain e a sostituirla con quella della Palestina. Secondo il ministro degli interni iracheno Yassin al-Yassiry, 54 dimostranti sono stati arrestati dalla polizia.
A indispettire i manifestanti erano state le parole del ministro degli esteri Khalid bin Ahmed al-Khalifa che aveva esortato mercoledì alla pacifica coesistenza con Israele. Condannando il cosiddetto “Accordo del Secolo” del presidente statunitense Trump, il presidio di ieri ha criticato aspramente gli Stati del Golfo in quanto “arabi sionisti che hanno venduto la loro identità araba per un accordo fallimentare”.
Spente le sfarzose luci di Manama sulla due giorni sul conflitto israelo-palestinese – aria fritta per i palestinesi, ma occasione d’oro per Israele per normalizzare ancora di più i propri rapporti con il mondo arabo – sono ritornati subito ieri sera a fare notizia gli effetti dell’occupazione coloniale israeliana della Palestina che il vertice aveva abilmente nascosto. Le forze di polizia, infatti, hanno sparato e ucciso un palestinese nella parte orientale di Gerusalemme. Secondo la versione della polizia, gli agenti avrebbero soltanto risposto ai petardi che la vittima stava lanciando contro di loro durante una manifestazione. Avrebbero dunque agito secondo le regole d’ingaggio visto che erano “minacciati” dalla vittima e da altri manifestanti che scagliavano contro di loro pietre. “Un sospetto mascherato si è avvicinato alla polizia da un vicolo laterale e ha sparato i petardi sugli ufficiali che erano in una situazione che minacciava la loro vita – ha spiegato il portavoce della polizia Micky Rosenfeld – Un ufficiale ha quindi sparato all’immediato pericolo prevenendo così un’ulteriore situazione minacciosa per la vita (dei poliziotti)”.
Nella notte, intanto, Israele e il movimento islamico Hamas hanno rinnovato un accordo di tregua dopo che da Gaza nella giornata di ieri erano piovuti verso il territorio israeliano alcuni “strumenti incendiari” (così li chiama Tel Aviv) che avevano provocato incendi in più località. Secondo quanto riferisce l’agenzia Sawa di stanza a Gaza, l’intesa tra le due parti prevede: l’invio da parte dello stato ebraico di carburante per la centrale elettrica di Gaza; Tel Aviv permetterà ai pescatori gazawi di pescare fino a 15 miglia nautiche e restituirà 60 imbarcazioni che l’esercito aveva confiscato. Da parte sua, invece, Hamas ha garantito che terminerà il lancio dei palloni incendiari e limiterà le “Proteste del ritorno” che hanno luogo ogni venerdì dal 30 marzo del 2018. Il cessate-il-fuoco, mediato da Egitto e Onu, avrà effetto a partire da stamattina. Al momento nessuno delle due parti ha commentato la notizia.
Fonte
Il piccolo arcipelago del Golfo ha infatti subito richiamato il suo rappresentante diplomatico in Iraq. “Il ministro degli Affari esteri del Regno del Bahrain – si legge sul sito del ministero degli esteri bahrenita – condanna l’attacco all’ambasciata compiuto dai dimostranti e ha deciso di richiamare il suo ambasciatore per consultazioni”. Ma il dito è puntato contro Baghdad che, afferma Manama, è responsabile per la sicurezza dell’ambasciata. Chiamato in ballo, l’esecutivo iracheno ha espresso il suo “profondo rammarico” per quanto accaduto. “Il governo – si legge in una nota – ribadisce il suo assoluto rifiuto per qualunque atto che minacci la sicurezza delle missioni diplomatiche e quella del loro personale”.
Ieri ad attaccare l’edificio diplomatico erano state circa 200 persone. Prima di esseri dispersi dalle forze di sicurezza irachene, i manifestanti, che hanno bruciato bandiere israeliane e americane sventolando quelle della Palestina e dell’Iraq, sono riuscite ad entrare fino al giardino dell’edificio, a rimuovere la bandiera del Bahrain e a sostituirla con quella della Palestina. Secondo il ministro degli interni iracheno Yassin al-Yassiry, 54 dimostranti sono stati arrestati dalla polizia.
A indispettire i manifestanti erano state le parole del ministro degli esteri Khalid bin Ahmed al-Khalifa che aveva esortato mercoledì alla pacifica coesistenza con Israele. Condannando il cosiddetto “Accordo del Secolo” del presidente statunitense Trump, il presidio di ieri ha criticato aspramente gli Stati del Golfo in quanto “arabi sionisti che hanno venduto la loro identità araba per un accordo fallimentare”.
Spente le sfarzose luci di Manama sulla due giorni sul conflitto israelo-palestinese – aria fritta per i palestinesi, ma occasione d’oro per Israele per normalizzare ancora di più i propri rapporti con il mondo arabo – sono ritornati subito ieri sera a fare notizia gli effetti dell’occupazione coloniale israeliana della Palestina che il vertice aveva abilmente nascosto. Le forze di polizia, infatti, hanno sparato e ucciso un palestinese nella parte orientale di Gerusalemme. Secondo la versione della polizia, gli agenti avrebbero soltanto risposto ai petardi che la vittima stava lanciando contro di loro durante una manifestazione. Avrebbero dunque agito secondo le regole d’ingaggio visto che erano “minacciati” dalla vittima e da altri manifestanti che scagliavano contro di loro pietre. “Un sospetto mascherato si è avvicinato alla polizia da un vicolo laterale e ha sparato i petardi sugli ufficiali che erano in una situazione che minacciava la loro vita – ha spiegato il portavoce della polizia Micky Rosenfeld – Un ufficiale ha quindi sparato all’immediato pericolo prevenendo così un’ulteriore situazione minacciosa per la vita (dei poliziotti)”.
Nella notte, intanto, Israele e il movimento islamico Hamas hanno rinnovato un accordo di tregua dopo che da Gaza nella giornata di ieri erano piovuti verso il territorio israeliano alcuni “strumenti incendiari” (così li chiama Tel Aviv) che avevano provocato incendi in più località. Secondo quanto riferisce l’agenzia Sawa di stanza a Gaza, l’intesa tra le due parti prevede: l’invio da parte dello stato ebraico di carburante per la centrale elettrica di Gaza; Tel Aviv permetterà ai pescatori gazawi di pescare fino a 15 miglia nautiche e restituirà 60 imbarcazioni che l’esercito aveva confiscato. Da parte sua, invece, Hamas ha garantito che terminerà il lancio dei palloni incendiari e limiterà le “Proteste del ritorno” che hanno luogo ogni venerdì dal 30 marzo del 2018. Il cessate-il-fuoco, mediato da Egitto e Onu, avrà effetto a partire da stamattina. Al momento nessuno delle due parti ha commentato la notizia.
Fonte
Tunisia - Gravi le condizioni del presidente, Tunisi scossa dagli attentati
Sono gravissime le condizioni di salute del presidente della Tunisia Beji Caid Essebsi ricoverato da ieri in un ospedale militare del Paese.
A fornire alla stampa l’ultimo bollettino medico del capo dello Stato è lo stesso ufficio di Essebsi che in una nota ha fatto sapere che
le condizioni di salute del 92enne leader tunisino sono “gravi” ma
“stabili” e che “si sta sottoponendo a tutti i controlli necessari”. Il
presidente era stato ricoverato in ospedale brevemente anche la scorsa
settimana per ricevere quello che il suo staff ha definito “un
trattamento non serio”. Ieri, inizialmente, era girata voce che fosse
morto. Era stato poi il suo consigliere Firas Guefresh a smentire su
Twitter le indiscrezioni che circolavano sulla stampa.
Primo presidente eletto democraticamente in Tunisia dopo le proteste del 2011, Essebsi è figura di primo piano nel mondo politico locale da quando è stato deposto Zine el-Abidine Ben Ali: è stato infatti colui che ha guidato la fase della transizione politica come primo ministro nel 2011 ed è stato eletto capo dello stato tre anni dopo.
La sua carriera politica ha però inizi lontani: Essebsi ha servito come ministro degli esteri all’epoca del presidente, nonché fondatore della Tunisia moderna, Habib Bouruiba e ha ricoperto la carica di presidente del Parlamento al tempo di Ben Ali. Leader del laico Nidaa Tunis, la scorsa primavera Essebsi aveva dichiarato che non si sarebbe candidato per un secondo mandato alle presidenziali di novembre. Una decisione che ha creato non pochi problemi al suo partito che sosteneva la sua candidatura e che ancora oggi non ha trovato un valido sostituto.
La scena politica tunisina continua ad essere tribolata: nell’ultimo anno la coalizione di governo (formata dagli islamisti di Ennahda e da Nidaa Tunis) si è spaccata e ha perso pezzi. Tra i fuoriusciti, lo scorso settembre, c’è anche il premier Yousef Chahed che ha dato vita ad un partito tutto suo (Yahya Tunes, “Forza Tunisia”) insieme ad altri 40 deputati. Le polemiche politiche si inseriscono in una situazione economica e sociale niente affatto semplice. L’esecutivo è stato finora incapace di dare risposte concrete ai problemi che affliggono il Paese: la diffusa corruzione, l’alto tasso di disoccupazione (soprattutto tra i giovani), le diseguaglianze socio-economiche e la marginalizzazione delle aree periferiche. Un humus sociale e politico che è stato ideale per il gruppo jihadista dello “Stato Islamico” per reclutare combattenti da inviare nel (fu) “califfato” di Siria e Iraq. Ma che ha anche continuato a causare l’immigrazione clandestina di centinaia di persone verso la sponda settentrionale del Mediterraneo affidata ad imbarcazioni di fortuna non di rado affondate lungo il tragitto. Nonostante la retorica di Roma dei “porti chiusi”, i tunisini continuano ad arrivare sulle coste italiane: gli ultimi, scortati dalla nostra Guardia Costiera, sono arrivati l’altro giorno nella stessa Lampedusa dove è ancora impedito, invece, lo sbarco ai 42 migranti della Sea Watch 3.
Si scappa da disoccupazione, povertà, mancanza di futuro, ma anche dallo stato di emergenza che, imposto durante le rivolte tunisine del 2011 fino al 2014, è stato reintrodotto nel 2015 quando il museo Bardo di Tunisi (prima) e un resort turistico di Susa (poi) sono stati teatro di due sanguinosi attentati terroristici. L’ultima estensione dello stato di emergenza risale allo scorso 5 giugno e come al solito non sono mancate le proteste: con il pretesto dell’emergenza, infatti, le autorità possono compiere migliaia di arresti e perquisizioni illegittime, imporre il coprifuoco, sospendere il diritto di sciopero e assemblea e le attività di movimenti e ong.
Senza dimenticare che la Tunisia, raccontata dai media come l’unica “rivoluzione araba di successo”, continua ad essere scossa di tanto in tanto da attentati. Gli ultimi ieri mattina quando due kamikaze si sono fatti saltare in aria a Tunisi uccidendo un poliziotto e ferendo 11 persone (morti anche i due attentatori). Gli attacchi terroristici sono avvenuti nel cuore pulsante della capitale tra Rue Charles de Gaulle e Avenue Bourghiba e presso la sede della guardia nazionale nel distretto di al-Qarijiani (qui sono stati feriti 4 ufficiali). Ma ad essere stata colpita è stata anche la città di Gafsa a sud: qui un comando armato ha sparato senza conseguenze sui militari che erano a protezione delle infrastrutture di trasmissione sul monte Orbata.
Gli attentati di ieri rischiano di rendere il percorso verso le parlamentari del 6 ottobre e le presidenziali del 17 novembre ancora più complesso e carico di tensione. A rendere incandescente il clima nel Paese ci pensa però anche la politica: ha destato più di qualche protesta la recente approvazione di un emendamento alla legge elettorale che porta al 3% la soglia di sbarramento per le politiche ed esclude dalla presidenza chi possiede mezzi d’informazione e controlla enti di beneficenza. A restare fuori potrebbe essere anche Nabil Karoui, il proprietario di Nesma Tv, che è dato in testa nei sondaggi. Tutto dipenderà però da cosa accadrà a Essebsi: nel caso in cui dovesse morire l’emendamento (che non ha ancora la sua firma) salterebbe e si andrebbe con ogni probabilità a voto anticipato.
Fonte
Primo presidente eletto democraticamente in Tunisia dopo le proteste del 2011, Essebsi è figura di primo piano nel mondo politico locale da quando è stato deposto Zine el-Abidine Ben Ali: è stato infatti colui che ha guidato la fase della transizione politica come primo ministro nel 2011 ed è stato eletto capo dello stato tre anni dopo.
La sua carriera politica ha però inizi lontani: Essebsi ha servito come ministro degli esteri all’epoca del presidente, nonché fondatore della Tunisia moderna, Habib Bouruiba e ha ricoperto la carica di presidente del Parlamento al tempo di Ben Ali. Leader del laico Nidaa Tunis, la scorsa primavera Essebsi aveva dichiarato che non si sarebbe candidato per un secondo mandato alle presidenziali di novembre. Una decisione che ha creato non pochi problemi al suo partito che sosteneva la sua candidatura e che ancora oggi non ha trovato un valido sostituto.
La scena politica tunisina continua ad essere tribolata: nell’ultimo anno la coalizione di governo (formata dagli islamisti di Ennahda e da Nidaa Tunis) si è spaccata e ha perso pezzi. Tra i fuoriusciti, lo scorso settembre, c’è anche il premier Yousef Chahed che ha dato vita ad un partito tutto suo (Yahya Tunes, “Forza Tunisia”) insieme ad altri 40 deputati. Le polemiche politiche si inseriscono in una situazione economica e sociale niente affatto semplice. L’esecutivo è stato finora incapace di dare risposte concrete ai problemi che affliggono il Paese: la diffusa corruzione, l’alto tasso di disoccupazione (soprattutto tra i giovani), le diseguaglianze socio-economiche e la marginalizzazione delle aree periferiche. Un humus sociale e politico che è stato ideale per il gruppo jihadista dello “Stato Islamico” per reclutare combattenti da inviare nel (fu) “califfato” di Siria e Iraq. Ma che ha anche continuato a causare l’immigrazione clandestina di centinaia di persone verso la sponda settentrionale del Mediterraneo affidata ad imbarcazioni di fortuna non di rado affondate lungo il tragitto. Nonostante la retorica di Roma dei “porti chiusi”, i tunisini continuano ad arrivare sulle coste italiane: gli ultimi, scortati dalla nostra Guardia Costiera, sono arrivati l’altro giorno nella stessa Lampedusa dove è ancora impedito, invece, lo sbarco ai 42 migranti della Sea Watch 3.
Si scappa da disoccupazione, povertà, mancanza di futuro, ma anche dallo stato di emergenza che, imposto durante le rivolte tunisine del 2011 fino al 2014, è stato reintrodotto nel 2015 quando il museo Bardo di Tunisi (prima) e un resort turistico di Susa (poi) sono stati teatro di due sanguinosi attentati terroristici. L’ultima estensione dello stato di emergenza risale allo scorso 5 giugno e come al solito non sono mancate le proteste: con il pretesto dell’emergenza, infatti, le autorità possono compiere migliaia di arresti e perquisizioni illegittime, imporre il coprifuoco, sospendere il diritto di sciopero e assemblea e le attività di movimenti e ong.
Senza dimenticare che la Tunisia, raccontata dai media come l’unica “rivoluzione araba di successo”, continua ad essere scossa di tanto in tanto da attentati. Gli ultimi ieri mattina quando due kamikaze si sono fatti saltare in aria a Tunisi uccidendo un poliziotto e ferendo 11 persone (morti anche i due attentatori). Gli attacchi terroristici sono avvenuti nel cuore pulsante della capitale tra Rue Charles de Gaulle e Avenue Bourghiba e presso la sede della guardia nazionale nel distretto di al-Qarijiani (qui sono stati feriti 4 ufficiali). Ma ad essere stata colpita è stata anche la città di Gafsa a sud: qui un comando armato ha sparato senza conseguenze sui militari che erano a protezione delle infrastrutture di trasmissione sul monte Orbata.
Gli attentati di ieri rischiano di rendere il percorso verso le parlamentari del 6 ottobre e le presidenziali del 17 novembre ancora più complesso e carico di tensione. A rendere incandescente il clima nel Paese ci pensa però anche la politica: ha destato più di qualche protesta la recente approvazione di un emendamento alla legge elettorale che porta al 3% la soglia di sbarramento per le politiche ed esclude dalla presidenza chi possiede mezzi d’informazione e controlla enti di beneficenza. A restare fuori potrebbe essere anche Nabil Karoui, il proprietario di Nesma Tv, che è dato in testa nei sondaggi. Tutto dipenderà però da cosa accadrà a Essebsi: nel caso in cui dovesse morire l’emendamento (che non ha ancora la sua firma) salterebbe e si andrebbe con ogni probabilità a voto anticipato.
Fonte
Egitto - L'economia a un passo dalla bancarotta
Pino Dragoni
«L’economia egiziana è al collasso». Tra debito, austerità e una gestione privatistica del potere, il rischio è che l’Egitto possa presto ritrovarsi in piena bancarotta, il «primo passo su una strada sempre più angusta verso il totale fallimento dello Stato».
A lanciare l’allarme dalle colonne virtuali della rivista Foreign Policy è Yehia Hamed, ex ministro degli investimenti nel governo di Mohamed Morsi, rovesciato dal colpo di stato militare del 2013.
Recentemente una banca di investimenti ha definito l’Egitto «la più attraente storia di riforma» in Medio Oriente, Africa ed est Europa e in molti tra istituzioni finanziarie ed esperti continuano a lodare la ripresa egiziana e i successi ottenuti da al-Sisi nella stabilizzazione degli indicatori macroeconomici. Ma cosa si nasconde dietro i toni trionfalistici e le rosee prospettive di rilancio?
L’articolo di Hamed snocciola una serie preoccupante di dati e definisce «un grande inganno» quello che per molti è il miracolo economico egiziano degli ultimi anni.
Dal 2014 (da quando cioè al-Sisi è al potere) il debito estero è quintuplicato, superando i 96 miliardi di dollari, un record storico per il paese (solo tra il 2017 e il 2018 l’aumento è stato del 17%). Nello stesso periodo il debito interno è più che raddoppiato, facendo schizzare il rapporto debito/Pil dal 87,1% del 2013 al 101,2% del 2017.
Ma l’aspetto più grave è il costo del debito sulle finanze dello Stato. Secondo i dati della Banca Centrale egiziana il paese oggi spende ben il 38% del suo budget statale solo per ripagare gli interessi sul debito. Se a ciò si aggiungono i prestiti contratti, si arriva a un impressionante 58% del bilancio. Il paradosso è che oggi l’Egitto continua a indebitarsi principalmente per coprire il costo dei crediti ottenuti in passato.
Non è chiaro fin quando i creditori internazionali saranno disposti a dare fiducia a un paese così fortemente esposto, mentre il sostegno dei partner del Golfo resta intermittente e dipende in gran parte da condizioni politiche.
Ma cosa ha portato a questa situazione? Come intende affrontarla il governo egiziano? E quali sono le conseguenze per la popolazione?
La massiccia svalutazione della lira egiziana del novembre 2016 ha ulteriormente indebolito la capacità di far fronte all’indebitamento. Intanto la crescita del Pil è rimasta bassa, anche a causa di un calo sostanzioso dell’export e del turismo, trainata solo da gas e petrolio. Ma secondo Maged Mandour, analista del think tank Carnegie, la vera causa di questa «crisi del debito» sarebbe la gestione economica dei militari al potere.
In questi anni una gran parte degli aiuti, prestiti e investimenti sono andati a finanziare progetti faraonici con uno scarso impatto sul tessuto produttivo del paese, come il raddoppio del canale di Suez (8 miliardi di dollari) e la costruzione della nuova capitale amministrativa (secondo alcune stime potrebbe costare fino a 300 miliardi di dollari).
Inoltre tra 2013 e 2017 l’importazione di armamenti è aumentata del 215% rispetto ai quattro anni precedenti, facendo dell’Egitto il terzo importatore mondiale di armi al mondo.
Per garantirsi il sostegno dei livelli più alti dell’esercito, il regime di al-Sisi ha lasciato che i generali si arricchissero espandendo notevolmente le loro attività economiche. Godendo di numerose esenzioni fiscali e di un accesso privilegiato agli appalti pubblici, le imprese che fanno capo alla Difesa hanno ormai tentacoli in tutti i settori più remunerativi dell’economia egiziana: dal cemento ai pannelli solari, dai resort turistici agli allevamenti ittici. Il ministero della Produzione militare quest’anno ha annunciato che i profitti delle sue imprese saranno quintuplicati rispetto al 2013-14.
Secondo un’inchiesta di Reuters, una concorrenza così spietata e iniqua spaventa gli investitori soprattutto stranieri, che si tengono alla larga dai settori in cui si concentrano gli interessi dei militari, facendo così crollare anche l’afflusso di capitali esteri.
Il ministro delle Finanze promette di riportare il rapporto debito/Pil all’80% entro il 2020 attraverso la riduzione del deficit. Ma non potendo contare su maggiori entrate dovute alla crescita, l’unica ricetta applicata finora sono tagli alla spesa e aumento della pressione fiscale.
A guidare questo processo dal 2016 è il Fondo monetario internazionale, che in cambio di un prestito da 12 miliardi di dollari ha imposto un durissimo piano di austerità, applicato alla lettera dal regime. Il governo ha puntato sull’introduzione dell’Iva per aumentare le entrate (imposta regressiva perché colpisce più duramente le classi medie e basse), mentre negli ultimi quattro anni è diminuito il gettito delle imposte sui profitti delle imprese.
Ma la misura più drammatica è il taglio dei sussidi, soprattutto quelli sull’energia e i carburanti, che per decenni hanno permesso agli egiziani più poveri di poter consumare a prezzi calmierati. Entro fine giugno il governo si appresta a eliminare definitivamente i sussidi sull’elettricità (causando un aumento del 15% nei prezzi) già tagliati del 30% nel 2016, del 40% nel 2017 e del 20% nel 2018. L’effetto sarà di aumentare ulteriormente il costo della vita e l’inflazione, salita dell’1,1% solo nel mese di maggio (è al 14,4%).
Tutto ciò in un paese in cui, per ammissione della stessa Banca mondiale, «il 60% della popolazione è povero o vulnerabile e le diseguaglianze sono in aumento». La popolazione è piegata da anni di austerità e sviluppo diseguale. Il Times ha raccontato che durante questo Ramadan si è creato un commercio di scarti di cibo avanzati da hotel e ristoranti.
Dall’inizio delle riforme il governo non diffonde più i dati sul tasso di povertà, che già nel 2015 era al 30% e secondo molti era già stimato largamente per difetto.
Per quanto ancora il castello di carte reggerà e fin quando gli egiziani sopporteranno?
Fonte
«L’economia egiziana è al collasso». Tra debito, austerità e una gestione privatistica del potere, il rischio è che l’Egitto possa presto ritrovarsi in piena bancarotta, il «primo passo su una strada sempre più angusta verso il totale fallimento dello Stato».
A lanciare l’allarme dalle colonne virtuali della rivista Foreign Policy è Yehia Hamed, ex ministro degli investimenti nel governo di Mohamed Morsi, rovesciato dal colpo di stato militare del 2013.
Recentemente una banca di investimenti ha definito l’Egitto «la più attraente storia di riforma» in Medio Oriente, Africa ed est Europa e in molti tra istituzioni finanziarie ed esperti continuano a lodare la ripresa egiziana e i successi ottenuti da al-Sisi nella stabilizzazione degli indicatori macroeconomici. Ma cosa si nasconde dietro i toni trionfalistici e le rosee prospettive di rilancio?
L’articolo di Hamed snocciola una serie preoccupante di dati e definisce «un grande inganno» quello che per molti è il miracolo economico egiziano degli ultimi anni.
Dal 2014 (da quando cioè al-Sisi è al potere) il debito estero è quintuplicato, superando i 96 miliardi di dollari, un record storico per il paese (solo tra il 2017 e il 2018 l’aumento è stato del 17%). Nello stesso periodo il debito interno è più che raddoppiato, facendo schizzare il rapporto debito/Pil dal 87,1% del 2013 al 101,2% del 2017.
Ma l’aspetto più grave è il costo del debito sulle finanze dello Stato. Secondo i dati della Banca Centrale egiziana il paese oggi spende ben il 38% del suo budget statale solo per ripagare gli interessi sul debito. Se a ciò si aggiungono i prestiti contratti, si arriva a un impressionante 58% del bilancio. Il paradosso è che oggi l’Egitto continua a indebitarsi principalmente per coprire il costo dei crediti ottenuti in passato.
Non è chiaro fin quando i creditori internazionali saranno disposti a dare fiducia a un paese così fortemente esposto, mentre il sostegno dei partner del Golfo resta intermittente e dipende in gran parte da condizioni politiche.
Ma cosa ha portato a questa situazione? Come intende affrontarla il governo egiziano? E quali sono le conseguenze per la popolazione?
La massiccia svalutazione della lira egiziana del novembre 2016 ha ulteriormente indebolito la capacità di far fronte all’indebitamento. Intanto la crescita del Pil è rimasta bassa, anche a causa di un calo sostanzioso dell’export e del turismo, trainata solo da gas e petrolio. Ma secondo Maged Mandour, analista del think tank Carnegie, la vera causa di questa «crisi del debito» sarebbe la gestione economica dei militari al potere.
In questi anni una gran parte degli aiuti, prestiti e investimenti sono andati a finanziare progetti faraonici con uno scarso impatto sul tessuto produttivo del paese, come il raddoppio del canale di Suez (8 miliardi di dollari) e la costruzione della nuova capitale amministrativa (secondo alcune stime potrebbe costare fino a 300 miliardi di dollari).
Inoltre tra 2013 e 2017 l’importazione di armamenti è aumentata del 215% rispetto ai quattro anni precedenti, facendo dell’Egitto il terzo importatore mondiale di armi al mondo.
Per garantirsi il sostegno dei livelli più alti dell’esercito, il regime di al-Sisi ha lasciato che i generali si arricchissero espandendo notevolmente le loro attività economiche. Godendo di numerose esenzioni fiscali e di un accesso privilegiato agli appalti pubblici, le imprese che fanno capo alla Difesa hanno ormai tentacoli in tutti i settori più remunerativi dell’economia egiziana: dal cemento ai pannelli solari, dai resort turistici agli allevamenti ittici. Il ministero della Produzione militare quest’anno ha annunciato che i profitti delle sue imprese saranno quintuplicati rispetto al 2013-14.
Secondo un’inchiesta di Reuters, una concorrenza così spietata e iniqua spaventa gli investitori soprattutto stranieri, che si tengono alla larga dai settori in cui si concentrano gli interessi dei militari, facendo così crollare anche l’afflusso di capitali esteri.
Il ministro delle Finanze promette di riportare il rapporto debito/Pil all’80% entro il 2020 attraverso la riduzione del deficit. Ma non potendo contare su maggiori entrate dovute alla crescita, l’unica ricetta applicata finora sono tagli alla spesa e aumento della pressione fiscale.
A guidare questo processo dal 2016 è il Fondo monetario internazionale, che in cambio di un prestito da 12 miliardi di dollari ha imposto un durissimo piano di austerità, applicato alla lettera dal regime. Il governo ha puntato sull’introduzione dell’Iva per aumentare le entrate (imposta regressiva perché colpisce più duramente le classi medie e basse), mentre negli ultimi quattro anni è diminuito il gettito delle imposte sui profitti delle imprese.
Ma la misura più drammatica è il taglio dei sussidi, soprattutto quelli sull’energia e i carburanti, che per decenni hanno permesso agli egiziani più poveri di poter consumare a prezzi calmierati. Entro fine giugno il governo si appresta a eliminare definitivamente i sussidi sull’elettricità (causando un aumento del 15% nei prezzi) già tagliati del 30% nel 2016, del 40% nel 2017 e del 20% nel 2018. L’effetto sarà di aumentare ulteriormente il costo della vita e l’inflazione, salita dell’1,1% solo nel mese di maggio (è al 14,4%).
Tutto ciò in un paese in cui, per ammissione della stessa Banca mondiale, «il 60% della popolazione è povero o vulnerabile e le diseguaglianze sono in aumento». La popolazione è piegata da anni di austerità e sviluppo diseguale. Il Times ha raccontato che durante questo Ramadan si è creato un commercio di scarti di cibo avanzati da hotel e ristoranti.
Dall’inizio delle riforme il governo non diffonde più i dati sul tasso di povertà, che già nel 2015 era al 30% e secondo molti era già stimato largamente per difetto.
Per quanto ancora il castello di carte reggerà e fin quando gli egiziani sopporteranno?
Fonte
Iscriviti a:
Post (Atom)