31/03/2020
Draghi indica il futuro ma dribbla una domanda: chi pagherà questa crisi?
Tra le inettitudini di chi insiste nel considerarla una recessione
passeggera e ritiene di poterla gestire con i consueti strumenti di
politica economica, Mario Draghi ha avuto il merito sul Financial Times di sgombrare il campo dalle illusioni e di riconoscere la dimensione effettiva di questa crisi senza precedenti.
L’ex presidente della BCE dichiara che siamo “come in guerra”, e come è sempre accaduto durante e dopo le guerre la risposta di politica economica “dovrà consistere in un aumento significativo del debito pubblico”. A suo avviso, “la perdita di reddito sostenuta dal settore privato dovrà essere assorbita, in tutto o in parte, dai bilanci pubblici”. Draghi aggiunge che dalle finanze pubbliche bisognerà tirar fuori anche il capitale di cui le banche avranno bisogno per coprire i debiti privati divenuti inesigibili: un modo discreto per chiarire che gli Stati potrebbero esser costretti a riacquisire una parte consistente delle banche, e non solo di quelle. Per queste ragioni, “livelli di debito pubblico molto più elevati diventeranno una caratteristica permanente delle nostre economie e saranno accompagnati dalla cancellazione del debito privato”.
Persino alcuni tra i più arcigni nemici del debito pubblico oggi riconoscono che quella suggerita da Draghi è l’unica via in grado di scongiurare una depressione di lungo periodo. Nell’indicarla, tuttavia, l’ex presidente della BCE elude una questione cruciale: anche se si eviterà la deflazione da debiti e la connessa depressione, i costi di questa crisi saranno pesanti. Chi li pagherà? Su quali gruppi sociali ricadrà l’onere del tracollo in corso? Sostenere che il debito pubblico assorbirà l’impatto non è sufficiente. Prendendo spunto da un’altra recente proposta pubblicata sul Financial Times, è possibile approfondire la questione sotto quattro aspetti cruciali.
In primo luogo, affinché l’espansione del debito pubblico sia governabile non basta sperare, come fa Draghi, che i tassi d’interesse resteranno bassi “probabilmente” anche in futuro. Come ho sostenuto in una discussione con Olivier Blanchard, diversamente da quel che pensano gli economisti mainstream il tasso d’interesse è questione non di “probabilità” ma di politica: si tratta cioè di una variabile che va tenuta ai minimi livelli possibili con una politica di governo dei mercati che consiste nel blocco della speculazione, nel controllo dei movimenti di capitale e più in generale in quella che va sotto il nome di “repressione finanziaria”. Questo tipo di politica sposta l’onere della crisi sui rentiers e sui gamblers della finanza mentre salvaguarda le attività produttive, i beneficiari del welfare e i lavoratori.
In secondo luogo, l’uso delle risorse derivanti dall’espansione del debito pubblico non può basarsi su forme più o meno surrettizie di “helicopter money”. Oggi questa formula viene considerata una benefica eresia ma pochi ricordano che essa trae origine da un approccio alla teoria e alla politica monetaria di tipo conservatore, che era fondato sulla “neutralità degli effetti distributivi”: ossia erogazioni uguali per tutti, ricchi o poveri che fossero. Attuare questa politica, come si tenta di fare negli USA, è sbagliato. Piuttosto, combinate con una politica fiscale nuovamente progressiva, le risorse finanziarie derivanti dall’espansione del debito pubblico dovrebbero esser distribuite in modo selettivo, sostenendo in primo luogo i redditi dei gruppi sociali più svantaggiati e la solvibilità delle imprese situate al centro delle catene input-output.
In terzo luogo, al di là dei problemi di debito, di solvibilità e di domanda, non va dimenticato che questa è una crisi che investe anche il lato dell’offerta. Se le misure di distanziamento sociale dureranno a lungo, ci sarà un impatto inevitabile sull’efficienza complessiva dei sistemi economici, con una caduta della produttività del lavoro e degli altri input e un conseguente aumento dei costi di produzione e distribuzione. Questi maggiori oneri potranno ricadere sulle rendite, sui profitti oppure sui salari a seconda del tipo di politica adottata. Minori saranno i tassi d’interesse rispetto all’andamento dei redditi nominali, maggiore sarà la possibilità di alleggerire le attività produttive da carichi fiscali, e quindi maggiore sarà il carico sulle rendite piuttosto che sui profitti d’impresa e sui salari. In ogni caso, una politica di salvaguardia dei salari, delle pensioni e di tutte le forme di sussidio contro eventuali fiammate inflazionistiche si renderà necessaria per tutelare il potere d’acquisto dei lavoratori e dei soggetti sociali più deboli.
Infine, c’è il rischio che prolungati distanziamenti sociali diano anche luogo a problemi di “disorganizzazione” dei mercati, con strozzature nelle catene della produzione e difficoltà di approvvigionamento che potrebbero estendersi ben al di là del settore sanitario. Per contenere tali strozzature e impedire che diventino occasioni di speculazione, è necessario provvedere a una “riorganizzazione” dei mercati tramite moderne forme di pianificazione pubblica, ove e quando necessario anche con amministrazioni mirate delle catene produttive e dei prezzi.
Ovviamente, maggiore sarà il coordinamento internazionale, maggiore sarà l’efficacia delle misure anti-crisi. Tuttavia, come sappiamo, il coordinamento non si sta verificando, men che meno nell’Unione europea. Eppure gli eventi presto saranno soverchianti, e bisognerà agire comunque. Credo sia indicativo, in questo senso, che proprio Draghi nel suo articolo non abbia mai accennato all’Europa unita: lui che la salvò dal tracollo, con questo silenzio sembra suggerire che stavolta potremmo vederci costretti a farne a meno per salvare noi stessi.
L’espansione del debito pubblico è dunque l’unica prospettiva razionale, ma non basta. Occorre chiarire come saranno gestiti i costi di questa crisi inedita e tremenda. Un piano che sposti l’onere principale sui rentiers, contrasti ogni forma di speculazione e salvaguardi i lavoratori e i soggetti sociali più deboli potrebbe rivelarsi necessario per la rinascita non semplicemente economica, ma civile e democratica. Proprio come accade alla fine di una guerra, quando le forze illuminate della società escono vittoriose.
Fonte
L’ex presidente della BCE dichiara che siamo “come in guerra”, e come è sempre accaduto durante e dopo le guerre la risposta di politica economica “dovrà consistere in un aumento significativo del debito pubblico”. A suo avviso, “la perdita di reddito sostenuta dal settore privato dovrà essere assorbita, in tutto o in parte, dai bilanci pubblici”. Draghi aggiunge che dalle finanze pubbliche bisognerà tirar fuori anche il capitale di cui le banche avranno bisogno per coprire i debiti privati divenuti inesigibili: un modo discreto per chiarire che gli Stati potrebbero esser costretti a riacquisire una parte consistente delle banche, e non solo di quelle. Per queste ragioni, “livelli di debito pubblico molto più elevati diventeranno una caratteristica permanente delle nostre economie e saranno accompagnati dalla cancellazione del debito privato”.
Persino alcuni tra i più arcigni nemici del debito pubblico oggi riconoscono che quella suggerita da Draghi è l’unica via in grado di scongiurare una depressione di lungo periodo. Nell’indicarla, tuttavia, l’ex presidente della BCE elude una questione cruciale: anche se si eviterà la deflazione da debiti e la connessa depressione, i costi di questa crisi saranno pesanti. Chi li pagherà? Su quali gruppi sociali ricadrà l’onere del tracollo in corso? Sostenere che il debito pubblico assorbirà l’impatto non è sufficiente. Prendendo spunto da un’altra recente proposta pubblicata sul Financial Times, è possibile approfondire la questione sotto quattro aspetti cruciali.
In primo luogo, affinché l’espansione del debito pubblico sia governabile non basta sperare, come fa Draghi, che i tassi d’interesse resteranno bassi “probabilmente” anche in futuro. Come ho sostenuto in una discussione con Olivier Blanchard, diversamente da quel che pensano gli economisti mainstream il tasso d’interesse è questione non di “probabilità” ma di politica: si tratta cioè di una variabile che va tenuta ai minimi livelli possibili con una politica di governo dei mercati che consiste nel blocco della speculazione, nel controllo dei movimenti di capitale e più in generale in quella che va sotto il nome di “repressione finanziaria”. Questo tipo di politica sposta l’onere della crisi sui rentiers e sui gamblers della finanza mentre salvaguarda le attività produttive, i beneficiari del welfare e i lavoratori.
In secondo luogo, l’uso delle risorse derivanti dall’espansione del debito pubblico non può basarsi su forme più o meno surrettizie di “helicopter money”. Oggi questa formula viene considerata una benefica eresia ma pochi ricordano che essa trae origine da un approccio alla teoria e alla politica monetaria di tipo conservatore, che era fondato sulla “neutralità degli effetti distributivi”: ossia erogazioni uguali per tutti, ricchi o poveri che fossero. Attuare questa politica, come si tenta di fare negli USA, è sbagliato. Piuttosto, combinate con una politica fiscale nuovamente progressiva, le risorse finanziarie derivanti dall’espansione del debito pubblico dovrebbero esser distribuite in modo selettivo, sostenendo in primo luogo i redditi dei gruppi sociali più svantaggiati e la solvibilità delle imprese situate al centro delle catene input-output.
In terzo luogo, al di là dei problemi di debito, di solvibilità e di domanda, non va dimenticato che questa è una crisi che investe anche il lato dell’offerta. Se le misure di distanziamento sociale dureranno a lungo, ci sarà un impatto inevitabile sull’efficienza complessiva dei sistemi economici, con una caduta della produttività del lavoro e degli altri input e un conseguente aumento dei costi di produzione e distribuzione. Questi maggiori oneri potranno ricadere sulle rendite, sui profitti oppure sui salari a seconda del tipo di politica adottata. Minori saranno i tassi d’interesse rispetto all’andamento dei redditi nominali, maggiore sarà la possibilità di alleggerire le attività produttive da carichi fiscali, e quindi maggiore sarà il carico sulle rendite piuttosto che sui profitti d’impresa e sui salari. In ogni caso, una politica di salvaguardia dei salari, delle pensioni e di tutte le forme di sussidio contro eventuali fiammate inflazionistiche si renderà necessaria per tutelare il potere d’acquisto dei lavoratori e dei soggetti sociali più deboli.
Infine, c’è il rischio che prolungati distanziamenti sociali diano anche luogo a problemi di “disorganizzazione” dei mercati, con strozzature nelle catene della produzione e difficoltà di approvvigionamento che potrebbero estendersi ben al di là del settore sanitario. Per contenere tali strozzature e impedire che diventino occasioni di speculazione, è necessario provvedere a una “riorganizzazione” dei mercati tramite moderne forme di pianificazione pubblica, ove e quando necessario anche con amministrazioni mirate delle catene produttive e dei prezzi.
Ovviamente, maggiore sarà il coordinamento internazionale, maggiore sarà l’efficacia delle misure anti-crisi. Tuttavia, come sappiamo, il coordinamento non si sta verificando, men che meno nell’Unione europea. Eppure gli eventi presto saranno soverchianti, e bisognerà agire comunque. Credo sia indicativo, in questo senso, che proprio Draghi nel suo articolo non abbia mai accennato all’Europa unita: lui che la salvò dal tracollo, con questo silenzio sembra suggerire che stavolta potremmo vederci costretti a farne a meno per salvare noi stessi.
L’espansione del debito pubblico è dunque l’unica prospettiva razionale, ma non basta. Occorre chiarire come saranno gestiti i costi di questa crisi inedita e tremenda. Un piano che sposti l’onere principale sui rentiers, contrasti ogni forma di speculazione e salvaguardi i lavoratori e i soggetti sociali più deboli potrebbe rivelarsi necessario per la rinascita non semplicemente economica, ma civile e democratica. Proprio come accade alla fine di una guerra, quando le forze illuminate della società escono vittoriose.
Fonte
I pazzi che pensano a “riaprire” in piena epidemia...
Non siamo né virologi né epidemiologi, ma sappiamo qualcosa di organizzazione e circolazione sociale. Così fin dall’inizio – e con più forza dalla sera dell’8 marzo – abbiamo provato a spiegare a tutti perché quella della “zona arancione larga” era una follia criminale.
Quel giorno il governo Conte decise di non chiudere la Val Seriana (buona parte della zona industriale bergamasca) in cui erano stati accertati grossi focolai di infezione, su pressione esplicita della Lega e di Confindustria, che fino a quel giorno avevano promosso le campagne mediatiche sul “non si ferma” (da Torino a Milano, complice il piddino Sala).
Non era quella zona l’unica che avrebbe dovuto essere dichiarata “rossa”, imponendo la chiusura totale di ogni attività e il divieto di ingresso e uscita. Ma si sarebbe trattato di zone territorialmente ristrette, tutto sommato “circondabili” con un dispiegamento di forze dell’ordine relativamente impegnativo ma non impossibile.
Il governo Conte scelse invece di fare “arancione” tutta la Lombardia più altre 14 province del Nord, tra le proteste inascoltabili del leghista Zaia perché vi erano comprese tre province venete.
“Zona arancione” non significava niente, perché un territorio così immenso non era “cinturabile”. Per di più i leghisti lumbard anticiparono alla stampa il contenuto del decreto che stava per essere firmato, mettendo così in moto una fuga precipitosa di migliaia di persone verso il Sud e altre regioni fin lì quasi immuni.
Peggio ancora, dopo pochi giorni il governo ha esteso a tutta Italia la stessa normativa, lasciando però aperte circa 800.000 aziende produttive, molte delle quali certamente non definibili “essenziali” al fine di combattere il virus e far rifornire la popolazione di alimenti e medicinali.
Scrivemmo allora: Se tutto il territorio è “zona rossa”, allora non c’è nessuna “zona rossa”.
Era lampante che si trattava di una strategia molto diversa da quelle adottate in Cina, Corea del Sud, Taiwan, ecc. dove erano state chiuse totalmente zone relativamente piccole (nelle dimensioni cinesi, almeno), mentre il resto del Paese proseguiva la vita in modo quasi normale pur tra grandi cautele, misure di distanziamento e protezioni individuali obbligatorie. Paesi che dunque producevano – sia pure amputati di parti rilevanti – e quindi potevano supplire in qualche modo al deficit che si veniva a creare; ma senza diffondere il contagio.
In una logica “da Paese”, ossia che antepone l’interesse generale della popolazione a quello di gruppi privatistici ristretti, quella scelta era ed è l’unica possibile per “confinare” efficacemente un’epidemia.
La stessa invasione della privacy con sistemi di tracciamento degli spostamenti individuali, associata alla possibilità-necessità di seguire ora per ora lo stato di salute di contagiati in quarantena a casa, non sollevava obiezioni né nelle popolazioni interessate, e neppure nei media occidentali.
Ed è utile sottolineare infatti come Corea del Sud e Taiwan non siano affatto definite “dittature comuniste”...
In tutto l’Occidente neoliberista, a cominciare dall’Italia – primo Paese “invaso” dal virus (anche se la posizione della Germania sembra assai meno limpida di quanto non ammette l’”etica protestante”) – si è invece preferita una strategia chiaramente “zoppa”. Si è infatti cercato di “contemperare” le esigenze sanitarie (chiusura drastica di alcune zone) con la priorità considerata assoluta: continuare a produrre, a qualsiasi costo.
E lo stesso hanno fatto, resistendo oltre ogni limite, Gran Bretagna, Spagna, Francia, Germania, Stati Uniti (dove quel criminale di Trump giudicherebbe un successo avere “solo” 100.000 morti!). Lo schema mentale – gli interessi materiali – neoliberista fa fare le stesse cose anche se poi ognuno le fa per conto proprio... e sono stronzate che producono stragi.
Perché una cosa è produrre – come nella Cina “fuori Wuhan” o la Corea “fuori Daewoo” – in condizioni di semi-sicurezza, tutt’altra è continuare a farlo nel bel mezzo dei focolai del coronavirus, con milioni di persone che escono di casa, si stipano su autobus, metro, treni, e poi negli spogliatoi delle fabbriche, nelle mense, nelle officine.
Milioni di persone che circolano, contagiano o vengono contagiati, e poi rientrano in casa, dove contagiano familiari di qualsiasi età.
Certo, le progressive e spesso insensate “ordinanze” che vietano la circolazione delle persone non al lavoro hanno diminuito statisticamente le possibilità di contagio rispetto a una situazione totalmente “free”. Ma se non si bloccano mai quella valanga di attività “non essenziali” possiamo star sicuri che il virus non verrà mai estirpato. Almeno fino a quando non sarà stata sperimentata una cura efficace disponibilità in quantitativi di massa, oppure scoperto un vaccino (anche qui: in decine di milioni di dosi).
Ripetiamo di non essere né virologi né epidemiologi. Ma ci sembra di non aver detto, né oggi né quasi un mese fa, qualcosa di diverso – e dunque sbagliato – rispetto a quanto prova a spiegare il professor Qiu Yunqing, infettivologo cinese di 57 anni, al vertice della delegazione di tredici esperti che ha appena visitato alcuni ospedali del nord Italia.
Qui di seguito l’articolo con cui Il Fatto sintetizza l’intervista da lui concessa a Repubblica. Nelle stesse ore in cui quel giornale varava la “campagna per riaprire le attività”! E non è neanche l’unico...
Siamo in mano a dei pazzi criminali che per due soldi in più sterminerebbero tutti...
Un mese di distanziamento sociale “rigido” con tutte le serrande abbassate: fabbriche, uffici, negozi. Tutto chiuso. “E il contagio si fermerebbe”. Lo afferma, in un intervista a ‘la Repubblica’, il professor Qiu Yunqing, infettivologo cinese di 57 anni, al vertice della delegazione di tredici esperti che ha appena visitato alcuni ospedali del nord Italia.
Da quel che ha potuto osservare, dice, servirebbe “un vero blocco collettivo delle attività, come si è fatto in Cina. Con rifornimenti alimentari per quartieri, o blocchi di palazzi. Serve il controllo rigido della diffusione del contagio, altrimenti non finiranno mai le persone da curare, ed è così che gli ospedali vanno in tilt. Non vi sono altre misure, lo dico perché noi l’abbiamo sperimentato. Ci tengo che il messaggio passi al vostro Paese”.
Qiu Yunqing è il vicedirettore dell’ospedale universitario della regione di Zhejiang: confrontando la situazione nelle strutture italiane, commenta “i livelli di protezione sono sicuramente inferiori ai nostri. Parlo di maschere, di tute protettive in Tyvek. Le maschere generiche non bastano, l’impressione è che gli operatori non siano abbastanza tutelati. Forse per mancanza di risorse effettive, o, all’inizio, di mancata comprensione del problema. Come è successo a Wuhan, nel primo periodo c’è stata una situazione simile: non si sapeva cosa fosse, questo virus, e non c’era la possibilità di avere risorse”.
E serve anche più personale, per dare il cambio ai medici provati da turni troppo lunghi: “Una malattia come questa richiede tute pesanti, quindi il lavoro è fisicamente ancora più faticoso – spiega l’infettivologo – Non si può reggere un turno di 8 ore, bisogna a scendere a 4, 6 ore. Quindi ci vuole più gente, un terzo in più del solito“.
Un’ultima osservazione riguarda il noto problema delle terapie intensive. “Lì ho visto delle criticità – osserva – Le strutture di degenza sono spesso vecchie, e questo complica molto. Non è una critica, noi abbiamo creato ospedali nuovi, ma anche gli altri nostri ospedali erano recenti, costruiti ai tempi della Sars, quindi con criteri nuovi su organizzazione di spazi e lavoro. Difficile farlo in strutture datate”.
Di fronte all’emergenza attuale, aggiunge, “nessun ospedale, neanche il più moderno, può resistere all’afflusso gigantesco di pazienti, come sta succedendo in Italia”. Bisogna evitare che le situazioni ‘sommerse’ – di chi è a casa, o è asintomatico – esplodano. “I malati vanno intercettati prima. Servono cliniche dove si ricoverano i positivi, anche se asintomatici. Li si monitora, e si può intervenire in tempo, se si aggravano. Ma non devono stare a casa senza controlli, né devono andare al pronto soccorso. Devono stare in questi posti finché non si negativizzano. Nel frattempo bisogna tracciare i loro contatti, e controllarli”. Come? “Con l’analisi dei movimenti, se un malato è stato in un autobus, bisogna rintracciare tutti gli occupanti – conclude – Si deve fare una ricerca anamnestica dettagliata“.
Fonte
Quel giorno il governo Conte decise di non chiudere la Val Seriana (buona parte della zona industriale bergamasca) in cui erano stati accertati grossi focolai di infezione, su pressione esplicita della Lega e di Confindustria, che fino a quel giorno avevano promosso le campagne mediatiche sul “non si ferma” (da Torino a Milano, complice il piddino Sala).
Non era quella zona l’unica che avrebbe dovuto essere dichiarata “rossa”, imponendo la chiusura totale di ogni attività e il divieto di ingresso e uscita. Ma si sarebbe trattato di zone territorialmente ristrette, tutto sommato “circondabili” con un dispiegamento di forze dell’ordine relativamente impegnativo ma non impossibile.
Il governo Conte scelse invece di fare “arancione” tutta la Lombardia più altre 14 province del Nord, tra le proteste inascoltabili del leghista Zaia perché vi erano comprese tre province venete.
“Zona arancione” non significava niente, perché un territorio così immenso non era “cinturabile”. Per di più i leghisti lumbard anticiparono alla stampa il contenuto del decreto che stava per essere firmato, mettendo così in moto una fuga precipitosa di migliaia di persone verso il Sud e altre regioni fin lì quasi immuni.
Peggio ancora, dopo pochi giorni il governo ha esteso a tutta Italia la stessa normativa, lasciando però aperte circa 800.000 aziende produttive, molte delle quali certamente non definibili “essenziali” al fine di combattere il virus e far rifornire la popolazione di alimenti e medicinali.
Scrivemmo allora: Se tutto il territorio è “zona rossa”, allora non c’è nessuna “zona rossa”.
Era lampante che si trattava di una strategia molto diversa da quelle adottate in Cina, Corea del Sud, Taiwan, ecc. dove erano state chiuse totalmente zone relativamente piccole (nelle dimensioni cinesi, almeno), mentre il resto del Paese proseguiva la vita in modo quasi normale pur tra grandi cautele, misure di distanziamento e protezioni individuali obbligatorie. Paesi che dunque producevano – sia pure amputati di parti rilevanti – e quindi potevano supplire in qualche modo al deficit che si veniva a creare; ma senza diffondere il contagio.
In una logica “da Paese”, ossia che antepone l’interesse generale della popolazione a quello di gruppi privatistici ristretti, quella scelta era ed è l’unica possibile per “confinare” efficacemente un’epidemia.
La stessa invasione della privacy con sistemi di tracciamento degli spostamenti individuali, associata alla possibilità-necessità di seguire ora per ora lo stato di salute di contagiati in quarantena a casa, non sollevava obiezioni né nelle popolazioni interessate, e neppure nei media occidentali.
Ed è utile sottolineare infatti come Corea del Sud e Taiwan non siano affatto definite “dittature comuniste”...
In tutto l’Occidente neoliberista, a cominciare dall’Italia – primo Paese “invaso” dal virus (anche se la posizione della Germania sembra assai meno limpida di quanto non ammette l’”etica protestante”) – si è invece preferita una strategia chiaramente “zoppa”. Si è infatti cercato di “contemperare” le esigenze sanitarie (chiusura drastica di alcune zone) con la priorità considerata assoluta: continuare a produrre, a qualsiasi costo.
E lo stesso hanno fatto, resistendo oltre ogni limite, Gran Bretagna, Spagna, Francia, Germania, Stati Uniti (dove quel criminale di Trump giudicherebbe un successo avere “solo” 100.000 morti!). Lo schema mentale – gli interessi materiali – neoliberista fa fare le stesse cose anche se poi ognuno le fa per conto proprio... e sono stronzate che producono stragi.
Perché una cosa è produrre – come nella Cina “fuori Wuhan” o la Corea “fuori Daewoo” – in condizioni di semi-sicurezza, tutt’altra è continuare a farlo nel bel mezzo dei focolai del coronavirus, con milioni di persone che escono di casa, si stipano su autobus, metro, treni, e poi negli spogliatoi delle fabbriche, nelle mense, nelle officine.
Milioni di persone che circolano, contagiano o vengono contagiati, e poi rientrano in casa, dove contagiano familiari di qualsiasi età.
Certo, le progressive e spesso insensate “ordinanze” che vietano la circolazione delle persone non al lavoro hanno diminuito statisticamente le possibilità di contagio rispetto a una situazione totalmente “free”. Ma se non si bloccano mai quella valanga di attività “non essenziali” possiamo star sicuri che il virus non verrà mai estirpato. Almeno fino a quando non sarà stata sperimentata una cura efficace disponibilità in quantitativi di massa, oppure scoperto un vaccino (anche qui: in decine di milioni di dosi).
Ripetiamo di non essere né virologi né epidemiologi. Ma ci sembra di non aver detto, né oggi né quasi un mese fa, qualcosa di diverso – e dunque sbagliato – rispetto a quanto prova a spiegare il professor Qiu Yunqing, infettivologo cinese di 57 anni, al vertice della delegazione di tredici esperti che ha appena visitato alcuni ospedali del nord Italia.
Qui di seguito l’articolo con cui Il Fatto sintetizza l’intervista da lui concessa a Repubblica. Nelle stesse ore in cui quel giornale varava la “campagna per riaprire le attività”! E non è neanche l’unico...
Siamo in mano a dei pazzi criminali che per due soldi in più sterminerebbero tutti...
*****
Coronavirus, l’infettivologo cinese: “Per fermare il contagio bisogna chiudere tutto. Servono più tutele per i vostri medici”
Un mese di distanziamento sociale “rigido” con tutte le serrande abbassate: fabbriche, uffici, negozi. Tutto chiuso. “E il contagio si fermerebbe”. Lo afferma, in un intervista a ‘la Repubblica’, il professor Qiu Yunqing, infettivologo cinese di 57 anni, al vertice della delegazione di tredici esperti che ha appena visitato alcuni ospedali del nord Italia.
Da quel che ha potuto osservare, dice, servirebbe “un vero blocco collettivo delle attività, come si è fatto in Cina. Con rifornimenti alimentari per quartieri, o blocchi di palazzi. Serve il controllo rigido della diffusione del contagio, altrimenti non finiranno mai le persone da curare, ed è così che gli ospedali vanno in tilt. Non vi sono altre misure, lo dico perché noi l’abbiamo sperimentato. Ci tengo che il messaggio passi al vostro Paese”.
Qiu Yunqing è il vicedirettore dell’ospedale universitario della regione di Zhejiang: confrontando la situazione nelle strutture italiane, commenta “i livelli di protezione sono sicuramente inferiori ai nostri. Parlo di maschere, di tute protettive in Tyvek. Le maschere generiche non bastano, l’impressione è che gli operatori non siano abbastanza tutelati. Forse per mancanza di risorse effettive, o, all’inizio, di mancata comprensione del problema. Come è successo a Wuhan, nel primo periodo c’è stata una situazione simile: non si sapeva cosa fosse, questo virus, e non c’era la possibilità di avere risorse”.
E serve anche più personale, per dare il cambio ai medici provati da turni troppo lunghi: “Una malattia come questa richiede tute pesanti, quindi il lavoro è fisicamente ancora più faticoso – spiega l’infettivologo – Non si può reggere un turno di 8 ore, bisogna a scendere a 4, 6 ore. Quindi ci vuole più gente, un terzo in più del solito“.
Un’ultima osservazione riguarda il noto problema delle terapie intensive. “Lì ho visto delle criticità – osserva – Le strutture di degenza sono spesso vecchie, e questo complica molto. Non è una critica, noi abbiamo creato ospedali nuovi, ma anche gli altri nostri ospedali erano recenti, costruiti ai tempi della Sars, quindi con criteri nuovi su organizzazione di spazi e lavoro. Difficile farlo in strutture datate”.
Di fronte all’emergenza attuale, aggiunge, “nessun ospedale, neanche il più moderno, può resistere all’afflusso gigantesco di pazienti, come sta succedendo in Italia”. Bisogna evitare che le situazioni ‘sommerse’ – di chi è a casa, o è asintomatico – esplodano. “I malati vanno intercettati prima. Servono cliniche dove si ricoverano i positivi, anche se asintomatici. Li si monitora, e si può intervenire in tempo, se si aggravano. Ma non devono stare a casa senza controlli, né devono andare al pronto soccorso. Devono stare in questi posti finché non si negativizzano. Nel frattempo bisogna tracciare i loro contatti, e controllarli”. Come? “Con l’analisi dei movimenti, se un malato è stato in un autobus, bisogna rintracciare tutti gli occupanti – conclude – Si deve fare una ricerca anamnestica dettagliata“.
Fonte
Tunisia - Quarantena di massa in tutto il paese per contrastare la diffusione del virus
«Signor Presidente e Signor Primo Ministro le scrivo per richiedere di adottare tutte le misure necessarie a contrastare questo tsunami sanitario (…) la Tunisia possiede 175 strutture ospedaliere con 15mila dottori di cui 500 rianimatori e solamente 241 posti letto specifici e respiratori, cifre che sicuramente non potranno reggere se il virus si espanderà nel paese come in Europa». L’appello fatto alle istituzioni tunisine dalla dottoressa Lilia Bouguira (attivista dei diritti umani e medico) dà il quadro della situazione di quello che potrebbe avvenire in Tunisia, se il contagio si espanderà.
La Tunisia è il quinto paese più colpito del continente con 258 contagiati e con 8 decessi. Numeri ancora relativamente bassi che preoccupano, però, le istituzioni tunisine visto che la crescita dei contagiati è triplicata nell’ultima settimana e sono state individuate nel paese 4 aree di focolaio. Cifre ancora basse, secondo la stampa tunisina, anche perché nel paese sono stati fatti ad oggi complessivamente 700 tamponi (problema riscontrato in tutto il continente africano dall’Organizzazione Mondiale della Sanità). Alle restrizioni delle scorse settimane su chiusura di scuole, università, bar, ristoranti, frontiere marittime e voli verso l’Europa (solo uno alla settimana verso le principali capitali), si è aggiunto il coprifuoco notturno (dalle 18 alle 6 del mattino) e la quarantena generalizzata in tutto il paese a partire da domenica 22 Marzo fino al 4 Aprile, con l’utilizzo dell’esercito.
Restrizioni annunciate in televisione dal neo presidente della repubblica, Kais Saied, che hanno suscitato polemiche in tutto il paese, soprattutto riguardo alle perplessità ed alla mancanza di provvedimenti in materia di potenziamento delle strutture sanitarie, di personale medico e di reperimento di materiale sanitario in termini di farmaci, dispositivi di protezione e respiratori.
Un battesimo difficile per il fragile governo di Elyes Fakhfakh, votato in parlamento il 27 febbraio, che nell’arco di un mese deve affrontare la diffusione del virus Covid-19, con la chiusura di attività manifatturiere e con il crollo del settore turistico, che si vanno ad aggiungere alle già difficili condizioni dell’economia tunisina ed all’alto tasso di disoccupazione giovanile (40% nelle zone rurali).
Il decreto governativo è suddiviso in diversi articoli con i primi punti che riguardano i “bisogni di base” della popolazione, le limitazioni di spostamento, il rinvio dei pagamenti. Vengono, inoltre, previste misure di sostegno all’economia, alle aziende ed ai dipendenti pubblici. Misure e provvedimenti economici che hanno portato il primo ministro Fakhfakh a dichiarare che si dovranno rinegoziare nuovamente i finanziamenti e gli accordi presi con il Fondo Monetario Internazionale.
«La situazione in cui ci troviamo oggi avrà un costo molto elevato per il sistema sanitario, che è già in difficoltà a causa della mancanza di risorse» ha dichiarato il premier «abbiamo comunque deciso di adottare una serie di misure per preservare lavoro ed economia».
In riferimento alle richieste delle opposizioni politiche e dell’opinione pubblica riguardo alla mancanza di provvedimenti per il potenziamento delle strutture sanitarie il ministro della Sanità Abdelattif El Mekki ha cercato di rassicurare evocando una «possibile requisizione di cliniche private, proprio con l’obiettivo di garantire la cura per tutti i tunisini».
Fonte
La Tunisia è il quinto paese più colpito del continente con 258 contagiati e con 8 decessi. Numeri ancora relativamente bassi che preoccupano, però, le istituzioni tunisine visto che la crescita dei contagiati è triplicata nell’ultima settimana e sono state individuate nel paese 4 aree di focolaio. Cifre ancora basse, secondo la stampa tunisina, anche perché nel paese sono stati fatti ad oggi complessivamente 700 tamponi (problema riscontrato in tutto il continente africano dall’Organizzazione Mondiale della Sanità). Alle restrizioni delle scorse settimane su chiusura di scuole, università, bar, ristoranti, frontiere marittime e voli verso l’Europa (solo uno alla settimana verso le principali capitali), si è aggiunto il coprifuoco notturno (dalle 18 alle 6 del mattino) e la quarantena generalizzata in tutto il paese a partire da domenica 22 Marzo fino al 4 Aprile, con l’utilizzo dell’esercito.
Restrizioni annunciate in televisione dal neo presidente della repubblica, Kais Saied, che hanno suscitato polemiche in tutto il paese, soprattutto riguardo alle perplessità ed alla mancanza di provvedimenti in materia di potenziamento delle strutture sanitarie, di personale medico e di reperimento di materiale sanitario in termini di farmaci, dispositivi di protezione e respiratori.
Un battesimo difficile per il fragile governo di Elyes Fakhfakh, votato in parlamento il 27 febbraio, che nell’arco di un mese deve affrontare la diffusione del virus Covid-19, con la chiusura di attività manifatturiere e con il crollo del settore turistico, che si vanno ad aggiungere alle già difficili condizioni dell’economia tunisina ed all’alto tasso di disoccupazione giovanile (40% nelle zone rurali).
Il decreto governativo è suddiviso in diversi articoli con i primi punti che riguardano i “bisogni di base” della popolazione, le limitazioni di spostamento, il rinvio dei pagamenti. Vengono, inoltre, previste misure di sostegno all’economia, alle aziende ed ai dipendenti pubblici. Misure e provvedimenti economici che hanno portato il primo ministro Fakhfakh a dichiarare che si dovranno rinegoziare nuovamente i finanziamenti e gli accordi presi con il Fondo Monetario Internazionale.
«La situazione in cui ci troviamo oggi avrà un costo molto elevato per il sistema sanitario, che è già in difficoltà a causa della mancanza di risorse» ha dichiarato il premier «abbiamo comunque deciso di adottare una serie di misure per preservare lavoro ed economia».
In riferimento alle richieste delle opposizioni politiche e dell’opinione pubblica riguardo alla mancanza di provvedimenti per il potenziamento delle strutture sanitarie il ministro della Sanità Abdelattif El Mekki ha cercato di rassicurare evocando una «possibile requisizione di cliniche private, proprio con l’obiettivo di garantire la cura per tutti i tunisini».
Fonte
Ciao Manolis!
In questi giorni di mestizia globale è morto – per una malattia pregressa – ad Atene il compagno Manolis Glezos. Una straordinaria figura umana e politica che incarnava la pluridecennale lotta dei comunisti greci contro il fascismo e per il Socialismo.
Manolis, come molti giovani nativi delle isole della Grecia, dovette trasferirsi, fin da giovanissimo, sulla terraferma dove iniziò subito la sua attività antifascista.
Celebre divenne la sua plateale azione propagandistica e di aperta ribellione quando – la notte del 30 maggio del 1941 – sfidando il rigido coprifuoco militare, strappò la bandiera nazista che sovrastava l’Acropoli di Atene sostituendola con quella della Grecia. In quei duri anni del tallone di ferro nazista, Manolis fu più volte incarcerato e perse continuamente il lavoro.
Durante i pesanti anni del dopoguerra, quando il Partito Comunista Greco (KKE) era fuorilegge, continuò in varie forme la sua attività sociale e politica in formazioni socialiste sempre, però, rappresentando posizioni di strenua difesa degli interessi storici e materiali dei settori popolari della società ellenica.
Con la nascista di Syriza – lungo il decennio 2000/2010 che vide lo sviluppo e la generalizzazione di un articolato movimento popolare anti/austerity – si schierò a favore di Tsipras e del suo tentativo di spezzare la gabbia dell’Unione Europea che stava massacrando il popolo greco.
La sua puntuale presenza – nelle piazze e nelle istituzioni – simboleggiava quel filo rosso che legava gli ideali della resistenza all’occupazione nazi/fascista con le lotte contro lo strangolamento finanziario ed economico che la Trojka e i suoi lacchè locali stavano consumando contro i popoli ellenici.
Manolis – che a scanso di una becera vulgata coltivata dalla stampa borghese non è mai stato un “estremista” – comprese subito l’atto politico della capitolazione, ai diktat dell’Unione Europea, che Syriza e il governo Tsipras operarono nel luglio 2015 nonostante un Referendum Popolare avesse votato a maggioranza l’OXI e legittimato il governo greco a “tenere duro verso la pressione della UE”.
Infatti Manolis ruppe con Tsipras e lo ricordiamo ancora alla testa dei cortei a Piazza Syntagma – davanti al palazzone del Parlamento greco – che si scontravano con la polizia del governo e che reclamavano il rispetto della volontà popolare che si era espressa per non accettare supinamente il cosiddetto Terzo Memorandum.
Oggi la Grecia è stata devastata dalla cura “lacrime e sangue” targata Unione Europea, Alexis Tsipras non è più al governo e quel moto sociale che aveva lasciato intravedere una possibilità di rottura con il polo imperialista europeo è dovuto rifluire a causa di cedimenti politici e della mancanza di una adeguata solidarietà internazionale ed internazionalista verso quel passaggio politico del conflitto continentale.
La morte di Manolis – del resto lui stesso lo ha ricordato in numerose testimonianze ed interviste affrontando un bilancio della sua vita politica – non certifica, in alcun modo, l’esaurirsi di una spinta, in Grecia come altrove, della necessità di opporsi al vecchio, come al nuovo, autoritarismo dei mercati, dei padroni e delle loro istituzioni sovranazionali. Del resto, nonostante la pesantezza delle condizioni di vita e di lavoro dei ceti popolari, in Grecia continua ad agire un qualificato movimento sindacale indipendente e i comunisti, a vario titolo, continuano a svolgere una importante funzione d’avanguardia.
Ed è su questa linea di condotta che – da comunisti da quest’altra parte del mare – alutiamo il compagno Manolis Glezos!
Fonte
Manolis, come molti giovani nativi delle isole della Grecia, dovette trasferirsi, fin da giovanissimo, sulla terraferma dove iniziò subito la sua attività antifascista.
Celebre divenne la sua plateale azione propagandistica e di aperta ribellione quando – la notte del 30 maggio del 1941 – sfidando il rigido coprifuoco militare, strappò la bandiera nazista che sovrastava l’Acropoli di Atene sostituendola con quella della Grecia. In quei duri anni del tallone di ferro nazista, Manolis fu più volte incarcerato e perse continuamente il lavoro.
Durante i pesanti anni del dopoguerra, quando il Partito Comunista Greco (KKE) era fuorilegge, continuò in varie forme la sua attività sociale e politica in formazioni socialiste sempre, però, rappresentando posizioni di strenua difesa degli interessi storici e materiali dei settori popolari della società ellenica.
Con la nascista di Syriza – lungo il decennio 2000/2010 che vide lo sviluppo e la generalizzazione di un articolato movimento popolare anti/austerity – si schierò a favore di Tsipras e del suo tentativo di spezzare la gabbia dell’Unione Europea che stava massacrando il popolo greco.
La sua puntuale presenza – nelle piazze e nelle istituzioni – simboleggiava quel filo rosso che legava gli ideali della resistenza all’occupazione nazi/fascista con le lotte contro lo strangolamento finanziario ed economico che la Trojka e i suoi lacchè locali stavano consumando contro i popoli ellenici.
Manolis – che a scanso di una becera vulgata coltivata dalla stampa borghese non è mai stato un “estremista” – comprese subito l’atto politico della capitolazione, ai diktat dell’Unione Europea, che Syriza e il governo Tsipras operarono nel luglio 2015 nonostante un Referendum Popolare avesse votato a maggioranza l’OXI e legittimato il governo greco a “tenere duro verso la pressione della UE”.
Infatti Manolis ruppe con Tsipras e lo ricordiamo ancora alla testa dei cortei a Piazza Syntagma – davanti al palazzone del Parlamento greco – che si scontravano con la polizia del governo e che reclamavano il rispetto della volontà popolare che si era espressa per non accettare supinamente il cosiddetto Terzo Memorandum.
Oggi la Grecia è stata devastata dalla cura “lacrime e sangue” targata Unione Europea, Alexis Tsipras non è più al governo e quel moto sociale che aveva lasciato intravedere una possibilità di rottura con il polo imperialista europeo è dovuto rifluire a causa di cedimenti politici e della mancanza di una adeguata solidarietà internazionale ed internazionalista verso quel passaggio politico del conflitto continentale.
La morte di Manolis – del resto lui stesso lo ha ricordato in numerose testimonianze ed interviste affrontando un bilancio della sua vita politica – non certifica, in alcun modo, l’esaurirsi di una spinta, in Grecia come altrove, della necessità di opporsi al vecchio, come al nuovo, autoritarismo dei mercati, dei padroni e delle loro istituzioni sovranazionali. Del resto, nonostante la pesantezza delle condizioni di vita e di lavoro dei ceti popolari, in Grecia continua ad agire un qualificato movimento sindacale indipendente e i comunisti, a vario titolo, continuano a svolgere una importante funzione d’avanguardia.
Ed è su questa linea di condotta che – da comunisti da quest’altra parte del mare – alutiamo il compagno Manolis Glezos!
Fonte
La Cina decolla di nuovo. Un’occasione per l’Italexit
Stanotte sono stati diffusi in Cina gli indici PMI manifatturieri e dei servizi. Erano molto attesi, dopo la gravissima crisi da coronavirus, con il fermo totale della provincia considerata la “Detroit cinese”, dove è concentrata l’industria automobilistica.
Vi è stato un notevole balzo. Alcuni dati: l’indice manifatturiero è passato da 35,7 di febbraio a 52 di marzo. L’indice dei servizi è balzato invece dal minimo di 29,6 di febbraio a 52,3 di marzo.
Ricordiamo che la soglia di punti 50 indica recessione o rilancio. In questo caso vi è stato un notevole recupero, davvero impressionante. L’indice delle esportazioni è passato da 28,7 di febbraio a 48,2 di marzo; mentre l’importantissimo indice di importazione, cioè quanto la Cina richiede al mercato mondiale, è passato da 31,9 di febbraio a 48,4 di marzo.
L’ Istituto di statistica cinese ci tiene a sottolineare che è ancora presto per cantare vittoria, ma sicuramente i prossimi stimoli fiscali in via di definizione tenderanno a confermare il dato.
La riconversione manifatturiera avvenuta in Cina a gennaio ha portato ad un boom di produzione di ventilatori polmonari, mascherine, materiale sanitario, che stanno rifornendo il mondo intero.
Lo stesso New York Times ieri riferiva che 52 aerei erano atterrati a New York per portare materiale sanitario agli americani; notizia ribadita ieri sera anche dal sito Milano Finanza.
Secondo molte stime, gli Usa hanno bisogno di 3,5 miliardi di mascherine e la domanda è talmente alta che le stesse fabbriche tessili italiane stanno lavorando a pieno ritmo, riconvertendosi su questo tipo di articoli.
Molti sono normali acquisti, ma si ha notizia di imprenditori cinesi che stanno donando agli americani milioni di mascherine e materiale sanitario; tra questi Jack Ma, fondatore e a.d. di Alibaba.
Dunque, il colloquio avvenuto tre giorni fa tra Trump e Xi Jinping sta portando i primi frutti alla sanità americana. È un evento epocale, un tornante della storia, ma già a gennaio si era capito della situazione di tregua-intesa tra Usa e Cina, con l’accordo commerciale.
A organizzare il tutto il marito di Invanka Trump, figlia prediletta del Presidente, che ieri ha postato la notizia. Kushner, molto legato agli ambienti di Wall Street, dice chiaramente che la piazza finanziaria americana vuole un’intesa a largo raggio con la Cina.
Ciò si ripercuoterà sull’Unione Europea, in particolare sul nostro Paese, nodo strategico delle relazioni internazionali, essendo al centro del Mediterraneo.
L’Italia diventa potenziale ponte, pivot tra superpotenze.
Corteggiata da Usa, Russia e Cina e malvista in ambienti comunitari, può e deve dotarsi di una strategia di exit. Ora o mai più.
Fonte
Vi è stato un notevole balzo. Alcuni dati: l’indice manifatturiero è passato da 35,7 di febbraio a 52 di marzo. L’indice dei servizi è balzato invece dal minimo di 29,6 di febbraio a 52,3 di marzo.
Ricordiamo che la soglia di punti 50 indica recessione o rilancio. In questo caso vi è stato un notevole recupero, davvero impressionante. L’indice delle esportazioni è passato da 28,7 di febbraio a 48,2 di marzo; mentre l’importantissimo indice di importazione, cioè quanto la Cina richiede al mercato mondiale, è passato da 31,9 di febbraio a 48,4 di marzo.
L’ Istituto di statistica cinese ci tiene a sottolineare che è ancora presto per cantare vittoria, ma sicuramente i prossimi stimoli fiscali in via di definizione tenderanno a confermare il dato.
La riconversione manifatturiera avvenuta in Cina a gennaio ha portato ad un boom di produzione di ventilatori polmonari, mascherine, materiale sanitario, che stanno rifornendo il mondo intero.
Lo stesso New York Times ieri riferiva che 52 aerei erano atterrati a New York per portare materiale sanitario agli americani; notizia ribadita ieri sera anche dal sito Milano Finanza.
Secondo molte stime, gli Usa hanno bisogno di 3,5 miliardi di mascherine e la domanda è talmente alta che le stesse fabbriche tessili italiane stanno lavorando a pieno ritmo, riconvertendosi su questo tipo di articoli.
Molti sono normali acquisti, ma si ha notizia di imprenditori cinesi che stanno donando agli americani milioni di mascherine e materiale sanitario; tra questi Jack Ma, fondatore e a.d. di Alibaba.
Dunque, il colloquio avvenuto tre giorni fa tra Trump e Xi Jinping sta portando i primi frutti alla sanità americana. È un evento epocale, un tornante della storia, ma già a gennaio si era capito della situazione di tregua-intesa tra Usa e Cina, con l’accordo commerciale.
A organizzare il tutto il marito di Invanka Trump, figlia prediletta del Presidente, che ieri ha postato la notizia. Kushner, molto legato agli ambienti di Wall Street, dice chiaramente che la piazza finanziaria americana vuole un’intesa a largo raggio con la Cina.
Ciò si ripercuoterà sull’Unione Europea, in particolare sul nostro Paese, nodo strategico delle relazioni internazionali, essendo al centro del Mediterraneo.
L’Italia diventa potenziale ponte, pivot tra superpotenze.
Corteggiata da Usa, Russia e Cina e malvista in ambienti comunitari, può e deve dotarsi di una strategia di exit. Ora o mai più.
Fonte
Virus, sistema, governo e noi...
Durante la Conferenza Stampa di sabato 28 marzo,
il Presidente del Consiglio e il ministro dell’economia del Governo
Italiano hanno annunciato alcune norme per combattere l’emergenza
sociale che si potrebbe verificare nei prossimi giorni, perdurando la
crisi innestata dalla pandemia in Italia.
Che alcuni provvedimenti siano urgenti e doverosi lo ammettono tutti.
Al termine delle relazioni, i giornalisti presenti hanno comunque deciso di non commentare le misure concentrandosi sulle questioni più generali relative ai rapporti tra l’Italia e la UE. In questo senso, le risposte di Conte e Gualtieri sono state reticenti e interlocutorie, ma è emersa comunque una distanza di prospettive che, fino a una settimana fa, era addirittura impensabile.
Probabilmente, le misure annunciate di contrasto alla povertà immediata sono deboli, insufficienti e discutibili sulle modalità. Si potrebbe dire sempre meglio che niente, ed effettivamente questo ragionamento ha una sua logica. Il problema è però più generale ed attiene nell’immediato alle capacità di spesa reali dell’Italia visto che ogni accordo complessivo in sede UE è per lo meno incerto e tutto da verificare.
L’Unione Europea ha festeggiato da poco i suoi 50 anni di esistenza. Una esistenza la cui vocazione è emersa in maniera inequivocabile almeno dagli anni 90 del secolo appena trascorso. L’Unione Europea ha festeggiato da poco i suoi 50 anni di esistenza. Una esistenza la cui vocazione è emersa in maniera inequivocabile almeno dagli anni ‘90 del secolo appena trascorso. Dopo la fine dell’esperimento socialista nella galassia sovietica, l’Unione Europea è stata la specifica risposta che le classi dominanti e i governi europei hanno deciso di darsi all’interno di una nuova fase dei rapporti internazionali, caratterizzati dalla fine delle alternative, da nuovi tipi di competizione internazionale, da una redistribuzione delle filiere produttive su scala mondiale.
Il processo di costituzione dell’Unione Europea entra quindi, dal trattato di Maastricht in poi, in una fase completamente nuova fino alla creazione della moneta unica, passando per l’elaborazione del Trattato di Lisbona che la dota di una sorta di costituzione informale, fino all’allargamento ai paesi dell’Est europeo.
Non è questa la sede per analizzare i singoli passaggi ma appare con tutta evidenza, e la pandemia con le sue conseguenze immediate e future non fa che rendere il tutto più chiaro, urgente e inequivocabile, che l’Unione Europea ha fallito in tutti i suoi obiettivi. Sicuramente ha fallito nei confronti dei diritti di gran parte del corpo sociale dei paesi membri a cominciare da quelli dei lavoratori, dei cittadini a basso reddito, delle piccole imprese. Fallimento che oggi può impattare duramente anche su quei settori che, invece, ci hanno guadagnato in ricchezza e potere a scapito dei più deboli. Contrazione generalizzata dei salari, aumento a dismisura della precarietà sociale, distruzione del welfare costruito dopo il secondo conflitto mondiale, disoccupazione generalizzata, distruzione del servizio sanitario nazionale, smantellamento dei servizi pubblici in generale, nessuna traccia di pianificazione economica se non di quella necessaria alle grandi imprese per competere su un mercato internazionale che altro non produce che enormi bolle finanziarie non risolvibili ma solo tamponabili attraverso ulteriori scarichi di responsabilità e oneri verso i lavoratori e verso interi stati (il caso della Grecia è forse il più emblematico del nostro continente).
Oggi la pandemia rischia di far saltare definitivamente il tappo a una situazione che era insostenibile già da tempo. Il disastro della sanità, con l’elenco dei tagli che ci sono stati negli ultimi decenni, non solo in Italia, ne è l’emblema. Ma anche i balbettii con cui i paesi europei e l’Italia affrontano il tema delle misure di contenimento del contagio, ci racconta di un sistema che rischia di travolgere se stesso (a cominciare dal macello sanitario lasciato indisturbato ad agire contro i lavoratori) senza nessuna possibilità di intervento da parte di governi in totale balia degli interessi dei padroni. La novità è che il sacrificio imposto a lavoratori e operatori sanitari, non può passare inosservato, non può essere considerato, cinicamente, alla maniera classica del capitale, come un fatto normale e necessario per competere; diventa impossibile non capire che attraverso queste politiche, la diffusione del contagio non risparmierà neppure le grandi imprese che rischiano di essere spazzate via lo stesso da uno tsunami internazionale.
Noi non possiamo sapere come finirà l’inedito braccio di ferro che sembra contrapporre il nostro e altri governi europei al governo tedesco e ai suoi alleati. Siamo in una situazione completamente diversa da quella che era stata affrontata dal governo di Syriza nel punto più drammatico della crisi greca nel 2015. In quel caso, Tsipras capitolò senza nessun aiuto concreto da nessun paese membro; lì si trattava di sacrificare i lavoratori e le classi popolari greche e l’Unione Europea, mostrando il suo volte feroce ed inumano, lo fece per salvare se stessa e le sue classi padronali. Ora, il volto feroce del MES, l’approccio di alcuni paesi che stanno nascondendo la reale natura della crisi in funzione di un aumento competitivo del proprio sistema industriale per il dopo pandemia, rischiano di essere crudeltà inutili. Quindi, quale sia la reale natura della contrapposizione in seno alla UE e a cosa allude per il nostro futuro va compreso bene; da una parte c’è chi ritiene che la crisi pandemica si risolverà con il sacrificio di milioni di persone e che tutto questa debba essere affrontato con iniezioni economiche che salvaguardino lo status quo: soldi per l’emergenza mantenendo uno stretto vincolo sulla destinazione a banche ed imprese e sacrifici da scaricare nuovamente su welfare, lavoratori e classi popolari. Questa è l’idea di fondo degli Stati legati al blocco tedesco ordoliberista. Dall’altra parte Italia, Francia e Spagna, che vorrebbero un meccanismo in cui i soldi possano essere destinati direttamente agli Stati per l’emergenza e per una ricostruzione del tessuto industriale. Le due ipotesi non sono equivalenti in quanto la prima serve esclusivamente a mantenere i rapporti di forza tra Stati esattamente come sono e, se possibile, acuire il divario tra paesi “virtuosi” e paesi “cicala”. La seconda allude a un meccanismo più solidale tra stati ma rischia comunque di essere insufficiente in quanto manterrebbe inalterato il meccanismo interno ai singoli stati nella divisione ineguale delle risorse e non affronterebbe nessun problema strutturale di fondo.
Ciò di cui abbiamo bisogno è di un meccanismo completamente ribaltato: bisogna ricostruire totalmente un rapporto sociale distrutto dalla fase neoliberista del capitalismo: i soldi devono essere usati per la ricostruzione del welfare, per il recupero dei diritti dei salariati, per la diminuzione della precarietà e della disoccupazione, per la reinternalizzazione dei servizi, per la scuola pubblica, per la riconversione del sistema industriale nel suo complesso.
Abbiamo bisogno di ricostruire il sistema industriale e sociale, per farlo non servono solo risorse ma anche recuperare il concetto di pianificazione e azione pubblica nell’economia, una idea di futuro che tenga conto dell’intera collettività. Un meccanismo solidale in cui i deboli e i lavoratori siano al centro di una esperienza collettiva. Abbiamo bisogno di tornare a muoverci dal punto di vista delle relazioni internazionali non più per alimentare contrapposizioni tra blocchi, guerre per il controllo delle risorse, devastazioni ambientali, ma per istituire relazioni solidali.
Con tutte le contraddizioni che si portano dietro, oggi assistiamo a uno spettacolo in cui paesi come Cina, Cuba o Venezuela ci stanno dando una lezione solidale. Non esiste un reale modello immediatamente trasferibile all’Italia date le differenze di cultura storica e di contesto. I patti di azione tra quei paesi ci sono ma sono legati anche ad interessi concreti non sempre idealizzabili. I sistemi economici e di governo sono diversi e si portano dietro enormi contraddizioni. Ma è difficile non vedere come nel mondo esistono comunque differenti modelli (anche se interconnessi tra loro in maniera non necessariamente virtuosa) che, in questo come in altre crisi, danno risposte qualitativamente diverse, non solo a livello di salvaguardia per le fasce meno protette ma anche a livello di risultati pratici.
Oggi possiamo anche valutare come tendenzialmente positiva la posizione del Governo italiano nei confronti della UE, lavorare e sostenere gli sforzi per una “svolta epocale” (come sostenuto da Conte) per la UE. Molto probabilmente non si arriverà a questa svolta e si troverà un compromesso da valutare. Le responsabilità, le attitudini e i referenti sociali del nostro governo non permettono comunque nessuna illusione di fondo. Ma la situazione è tale che anche questa possibile “svolta” non ci porterà fuori dal pantano in cui siamo immersi. L’Unione Europea è un progetto fallito anche se proverà (o per lo meno sarà costretta) a cambiare parte della propria natura. Prima questo mostro salterà in aria meglio sarà, non solo per noi, ma per tutti i lavoratori e gli sfruttati in Europa.
I popoli e i lavoratori europei nel loro complesso hanno bisogno di altro.
Hanno bisogno di istituzioni e governi che si rendano autonomi da un modello di sviluppo fallimentare, hanno bisogno di una prospettiva socialista, solidale e collettiva in grado di relazionarsi in maniera solidale con l’intero pianeta. Ciò di cui dobbiamo decidere è che tipo di relazioni sociali vogliamo avere, quale potere avranno i lavoratori nelle scelte da intraprendere, come vogliamo che siano la sanità, la scuola, i trasporti. Dobbiamo decidere se l’Italia debba continuare a produrre armi o apparati medici, se vuole continuare ad applicare sanzioni e ad alimentare guerre, se vuole costringere interi paesi a perire mentre si scatenano guerre per le risorse e milioni di persone sono costrette a migrare per essere emarginate e sfruttate nei paesi ricchi oppure vuole lavorare per una sana cooperazione tra popoli. Dobbiamo scegliere se vogliamo sacrificare le nostre vite per profitti di pochi, morire per guerre, pandemie prossime venture, se vogliamo essere considerati eroi da chi continua, oggi come ieri, a mandarci al macello oppure lavorare per una impresa collettiva in cui i sacrifici li facciamo per noi e non per padroni e governanti avidi, corrotti e incapaci.
Ciò ci interroga anche come militanti e attivisti comunisti: oggi è in gioco un modello di ricostruzione; la pandemia agisce e agirà come una tabula rasa rispetto a una guerra di posizione in cui ognuno di noi faceva per se stesso. Abbiamo oggettive difficoltà a intervenire in qualsiasi dibattito a causa delle nostre divisioni storiche sia a livello del nostro paese sia a livello internazionale. Vale forse la pena di sviluppare un ragionamento complessivo sulla situazione attuale e futura, capire se vogliamo intervenire e provare ad incidere su un processo di rinnovamento che comunque ci sarà per forza di cose, capire quale è il modo per provare a farlo. Tra le cose da comprendere nella fase che si apre c’è anche il fatto che l’atteggiamento tenuto fino a ora come comunisti ed anticapitalisti è stato totalmente inadeguato ed è giunto il momento di affrontare anche questa questione con urgenza e spirito unitario.
Fonte
Al termine delle relazioni, i giornalisti presenti hanno comunque deciso di non commentare le misure concentrandosi sulle questioni più generali relative ai rapporti tra l’Italia e la UE. In questo senso, le risposte di Conte e Gualtieri sono state reticenti e interlocutorie, ma è emersa comunque una distanza di prospettive che, fino a una settimana fa, era addirittura impensabile.
Probabilmente, le misure annunciate di contrasto alla povertà immediata sono deboli, insufficienti e discutibili sulle modalità. Si potrebbe dire sempre meglio che niente, ed effettivamente questo ragionamento ha una sua logica. Il problema è però più generale ed attiene nell’immediato alle capacità di spesa reali dell’Italia visto che ogni accordo complessivo in sede UE è per lo meno incerto e tutto da verificare.
L’Unione Europea ha festeggiato da poco i suoi 50 anni di esistenza. Una esistenza la cui vocazione è emersa in maniera inequivocabile almeno dagli anni 90 del secolo appena trascorso. L’Unione Europea ha festeggiato da poco i suoi 50 anni di esistenza. Una esistenza la cui vocazione è emersa in maniera inequivocabile almeno dagli anni ‘90 del secolo appena trascorso. Dopo la fine dell’esperimento socialista nella galassia sovietica, l’Unione Europea è stata la specifica risposta che le classi dominanti e i governi europei hanno deciso di darsi all’interno di una nuova fase dei rapporti internazionali, caratterizzati dalla fine delle alternative, da nuovi tipi di competizione internazionale, da una redistribuzione delle filiere produttive su scala mondiale.
Il processo di costituzione dell’Unione Europea entra quindi, dal trattato di Maastricht in poi, in una fase completamente nuova fino alla creazione della moneta unica, passando per l’elaborazione del Trattato di Lisbona che la dota di una sorta di costituzione informale, fino all’allargamento ai paesi dell’Est europeo.
Non è questa la sede per analizzare i singoli passaggi ma appare con tutta evidenza, e la pandemia con le sue conseguenze immediate e future non fa che rendere il tutto più chiaro, urgente e inequivocabile, che l’Unione Europea ha fallito in tutti i suoi obiettivi. Sicuramente ha fallito nei confronti dei diritti di gran parte del corpo sociale dei paesi membri a cominciare da quelli dei lavoratori, dei cittadini a basso reddito, delle piccole imprese. Fallimento che oggi può impattare duramente anche su quei settori che, invece, ci hanno guadagnato in ricchezza e potere a scapito dei più deboli. Contrazione generalizzata dei salari, aumento a dismisura della precarietà sociale, distruzione del welfare costruito dopo il secondo conflitto mondiale, disoccupazione generalizzata, distruzione del servizio sanitario nazionale, smantellamento dei servizi pubblici in generale, nessuna traccia di pianificazione economica se non di quella necessaria alle grandi imprese per competere su un mercato internazionale che altro non produce che enormi bolle finanziarie non risolvibili ma solo tamponabili attraverso ulteriori scarichi di responsabilità e oneri verso i lavoratori e verso interi stati (il caso della Grecia è forse il più emblematico del nostro continente).
Oggi la pandemia rischia di far saltare definitivamente il tappo a una situazione che era insostenibile già da tempo. Il disastro della sanità, con l’elenco dei tagli che ci sono stati negli ultimi decenni, non solo in Italia, ne è l’emblema. Ma anche i balbettii con cui i paesi europei e l’Italia affrontano il tema delle misure di contenimento del contagio, ci racconta di un sistema che rischia di travolgere se stesso (a cominciare dal macello sanitario lasciato indisturbato ad agire contro i lavoratori) senza nessuna possibilità di intervento da parte di governi in totale balia degli interessi dei padroni. La novità è che il sacrificio imposto a lavoratori e operatori sanitari, non può passare inosservato, non può essere considerato, cinicamente, alla maniera classica del capitale, come un fatto normale e necessario per competere; diventa impossibile non capire che attraverso queste politiche, la diffusione del contagio non risparmierà neppure le grandi imprese che rischiano di essere spazzate via lo stesso da uno tsunami internazionale.
Noi non possiamo sapere come finirà l’inedito braccio di ferro che sembra contrapporre il nostro e altri governi europei al governo tedesco e ai suoi alleati. Siamo in una situazione completamente diversa da quella che era stata affrontata dal governo di Syriza nel punto più drammatico della crisi greca nel 2015. In quel caso, Tsipras capitolò senza nessun aiuto concreto da nessun paese membro; lì si trattava di sacrificare i lavoratori e le classi popolari greche e l’Unione Europea, mostrando il suo volte feroce ed inumano, lo fece per salvare se stessa e le sue classi padronali. Ora, il volto feroce del MES, l’approccio di alcuni paesi che stanno nascondendo la reale natura della crisi in funzione di un aumento competitivo del proprio sistema industriale per il dopo pandemia, rischiano di essere crudeltà inutili. Quindi, quale sia la reale natura della contrapposizione in seno alla UE e a cosa allude per il nostro futuro va compreso bene; da una parte c’è chi ritiene che la crisi pandemica si risolverà con il sacrificio di milioni di persone e che tutto questa debba essere affrontato con iniezioni economiche che salvaguardino lo status quo: soldi per l’emergenza mantenendo uno stretto vincolo sulla destinazione a banche ed imprese e sacrifici da scaricare nuovamente su welfare, lavoratori e classi popolari. Questa è l’idea di fondo degli Stati legati al blocco tedesco ordoliberista. Dall’altra parte Italia, Francia e Spagna, che vorrebbero un meccanismo in cui i soldi possano essere destinati direttamente agli Stati per l’emergenza e per una ricostruzione del tessuto industriale. Le due ipotesi non sono equivalenti in quanto la prima serve esclusivamente a mantenere i rapporti di forza tra Stati esattamente come sono e, se possibile, acuire il divario tra paesi “virtuosi” e paesi “cicala”. La seconda allude a un meccanismo più solidale tra stati ma rischia comunque di essere insufficiente in quanto manterrebbe inalterato il meccanismo interno ai singoli stati nella divisione ineguale delle risorse e non affronterebbe nessun problema strutturale di fondo.
Ciò di cui abbiamo bisogno è di un meccanismo completamente ribaltato: bisogna ricostruire totalmente un rapporto sociale distrutto dalla fase neoliberista del capitalismo: i soldi devono essere usati per la ricostruzione del welfare, per il recupero dei diritti dei salariati, per la diminuzione della precarietà e della disoccupazione, per la reinternalizzazione dei servizi, per la scuola pubblica, per la riconversione del sistema industriale nel suo complesso.
Abbiamo bisogno di ricostruire il sistema industriale e sociale, per farlo non servono solo risorse ma anche recuperare il concetto di pianificazione e azione pubblica nell’economia, una idea di futuro che tenga conto dell’intera collettività. Un meccanismo solidale in cui i deboli e i lavoratori siano al centro di una esperienza collettiva. Abbiamo bisogno di tornare a muoverci dal punto di vista delle relazioni internazionali non più per alimentare contrapposizioni tra blocchi, guerre per il controllo delle risorse, devastazioni ambientali, ma per istituire relazioni solidali.
Con tutte le contraddizioni che si portano dietro, oggi assistiamo a uno spettacolo in cui paesi come Cina, Cuba o Venezuela ci stanno dando una lezione solidale. Non esiste un reale modello immediatamente trasferibile all’Italia date le differenze di cultura storica e di contesto. I patti di azione tra quei paesi ci sono ma sono legati anche ad interessi concreti non sempre idealizzabili. I sistemi economici e di governo sono diversi e si portano dietro enormi contraddizioni. Ma è difficile non vedere come nel mondo esistono comunque differenti modelli (anche se interconnessi tra loro in maniera non necessariamente virtuosa) che, in questo come in altre crisi, danno risposte qualitativamente diverse, non solo a livello di salvaguardia per le fasce meno protette ma anche a livello di risultati pratici.
Oggi possiamo anche valutare come tendenzialmente positiva la posizione del Governo italiano nei confronti della UE, lavorare e sostenere gli sforzi per una “svolta epocale” (come sostenuto da Conte) per la UE. Molto probabilmente non si arriverà a questa svolta e si troverà un compromesso da valutare. Le responsabilità, le attitudini e i referenti sociali del nostro governo non permettono comunque nessuna illusione di fondo. Ma la situazione è tale che anche questa possibile “svolta” non ci porterà fuori dal pantano in cui siamo immersi. L’Unione Europea è un progetto fallito anche se proverà (o per lo meno sarà costretta) a cambiare parte della propria natura. Prima questo mostro salterà in aria meglio sarà, non solo per noi, ma per tutti i lavoratori e gli sfruttati in Europa.
I popoli e i lavoratori europei nel loro complesso hanno bisogno di altro.
Hanno bisogno di istituzioni e governi che si rendano autonomi da un modello di sviluppo fallimentare, hanno bisogno di una prospettiva socialista, solidale e collettiva in grado di relazionarsi in maniera solidale con l’intero pianeta. Ciò di cui dobbiamo decidere è che tipo di relazioni sociali vogliamo avere, quale potere avranno i lavoratori nelle scelte da intraprendere, come vogliamo che siano la sanità, la scuola, i trasporti. Dobbiamo decidere se l’Italia debba continuare a produrre armi o apparati medici, se vuole continuare ad applicare sanzioni e ad alimentare guerre, se vuole costringere interi paesi a perire mentre si scatenano guerre per le risorse e milioni di persone sono costrette a migrare per essere emarginate e sfruttate nei paesi ricchi oppure vuole lavorare per una sana cooperazione tra popoli. Dobbiamo scegliere se vogliamo sacrificare le nostre vite per profitti di pochi, morire per guerre, pandemie prossime venture, se vogliamo essere considerati eroi da chi continua, oggi come ieri, a mandarci al macello oppure lavorare per una impresa collettiva in cui i sacrifici li facciamo per noi e non per padroni e governanti avidi, corrotti e incapaci.
Ciò ci interroga anche come militanti e attivisti comunisti: oggi è in gioco un modello di ricostruzione; la pandemia agisce e agirà come una tabula rasa rispetto a una guerra di posizione in cui ognuno di noi faceva per se stesso. Abbiamo oggettive difficoltà a intervenire in qualsiasi dibattito a causa delle nostre divisioni storiche sia a livello del nostro paese sia a livello internazionale. Vale forse la pena di sviluppare un ragionamento complessivo sulla situazione attuale e futura, capire se vogliamo intervenire e provare ad incidere su un processo di rinnovamento che comunque ci sarà per forza di cose, capire quale è il modo per provare a farlo. Tra le cose da comprendere nella fase che si apre c’è anche il fatto che l’atteggiamento tenuto fino a ora come comunisti ed anticapitalisti è stato totalmente inadeguato ed è giunto il momento di affrontare anche questa questione con urgenza e spirito unitario.
Fonte
Oro nero al ribasso, una partita che rischia di essere mortale
di Alberto Negri
A 20 dollari al barile è la serrata di un mondo, quello del petrolio, per la guerra dei prezzi tra Arabia Saudita e Russia e per il calo drastico della domanda internazionale depressa dalla crisi pandemica ed economica: in poche settimane da 100milioni di barili al giorno di consumi si è passati a 75, il 20% in meno.
All’orizzonte, mentre un Trump disorientato e sull’orlo di una crisi impensabile ha telefonato ieri a Putin, si profila la rovina delle società petrolifere americane dello shale oil ma soprattutto di interi popoli e nazioni che campano sulle esportazioni di oro nero. Il mondo arabo e il Golfo sono in tilt, l’Iran ha l’acqua alla gola per le sanzioni Usa e in Nordafrica, dall’Egitto all’Algeria, alla Tunisia, si profila una recessione senza precedenti, accompagnata da conflitti che non si fermano e da crisi di legittimità dei regimi che devono almeno far mangiare la propria gente. Una destabilizzazione che investe Iraq, Siria, Iran, Libano, Giordania e milioni di profughi che vagano dentro e ai margini di stati sempre più poveri e ora anche devastati dall’epidemia del coronavirus.
Questo è un mondo che più o meno direttamente dipende, per far quadrare i conti e sopravvivere, dall’oro nero e dagli investimenti legati all’industria petrolifera. Se i Paesi del Golfo, i più ricchi, stringono i cordoni della borsa anche per gli altri le prospettive sono plumbee. Basti pensare che il Qatar ha appena donato 150 milioni di dollari a Gaza.
Neanche troppo sullo sfondo ci sono gli Stati Uniti che non rinunciano al regime change a Teheran, epicentro mediorientale del Covid-19, mentre la Turchia regola i conti con i curdi uccidendo Nazife Bilen, la donna più alta in grado nelle fila dei combattenti del Pkk: perché le crisi, anche le peggiori, non fermano le guerre e neppure i volonterosi carnefici di popoli come Erdogan che è sempre in battaglia anche contro Assad nell’inferno umanitario di Idlib.
Succede così quello che non era accaduto con la Grande Depressione del 1929: essere pagati per portare via il petrolio in eccedenza. Non si era mai visto. I produttori non sanno dove stoccarlo e per questo alcuni Paesi e diverse multinazionali hanno cominciato a chiudere i pozzi e pure le raffinerie. Quando la crisi da coronavirus finirà potrebbe anche accadere il contrario: che non ci sarà abbastanza oro nero sui mercati.
La guerra del petrolio è stata innescata dal gran rifiuto della Russia di tagliare la produzione come aveva chiesto l’Arabia Saudita all’”Opec +1″, l’accordo dello storico Cartello petrolifero con Mosca che finora aveva tenuto a galla le quotazioni. Trump adesso si aggrappa a Putin per far rialzare i prezzi dopo avere convinto il “principe nero” Mohammed bin Salman a tagliare la produzione. Mosca pur di non cedere e mettere fuori mercato le società Usa, gravate dai debiti, è pronta a bruciare le riserve del Fondo sovrano russo (150 miliardi di dollari) per coprire le entrate mancate. In palio c’è la leadership del mercato dell’energia, non solo quello del petrolio ma anche del gas dove la Russia domina le forniture in Europa sia direttamente sia tramite l’hub della Turchia di Erdogan.
Ecco perché la battaglia ha risvolti strategici formidabili: si tratta anche di influenzare gli eventi in una vasta area dal Mediterraneo al Medio Oriente al Nordafrica. Ma anche lo zar potrebbe ripensarci: il gioco al ribasso può diventare una partita mortale.
Le compagnie americane dello shale oil sono in coma. Avevano cominciato la loro ascesa nel 2008 quando il costo del barile flirtava con quota 150 dollari, un’enormità che aveva spinto le società a investire a raffica nell’innovazione ma anche a indebitarsi. Già erano entrate in difficoltà nel 2016 quando era cominciato il calo del greggio e ora non sanno come ripagare i debiti, i loro titoli ormai sono quasi spazzatura. Da allora nel settore ci sono stati dozzine di fallimenti con debiti oltre i 120 miliardi di dollari.
Sono lacrime e sangue per tutti. Gli effetti dei ribassi possono essere prevedibili dal punto di vista economico ma assai più oscuri da quello strategico: se la situazione dovesse perdurare nel tempo i bilanci di paesi produttori, già in difficoltà per motivi interni e internazionali – come l’Iran sotto embargo, l’Algeria in una fase di transizione assai critica, l’Iraq delle rivolte e la Libia strangolata dalla guerra civile – possono subire colpi fatali. In questi Paesi il petrolio paga tutto o quasi: dal pane sulla tavola della gente comune ai ricatti di milizie che nessuno tiene a freno.
Fonte
A 20 dollari al barile è la serrata di un mondo, quello del petrolio, per la guerra dei prezzi tra Arabia Saudita e Russia e per il calo drastico della domanda internazionale depressa dalla crisi pandemica ed economica: in poche settimane da 100milioni di barili al giorno di consumi si è passati a 75, il 20% in meno.
All’orizzonte, mentre un Trump disorientato e sull’orlo di una crisi impensabile ha telefonato ieri a Putin, si profila la rovina delle società petrolifere americane dello shale oil ma soprattutto di interi popoli e nazioni che campano sulle esportazioni di oro nero. Il mondo arabo e il Golfo sono in tilt, l’Iran ha l’acqua alla gola per le sanzioni Usa e in Nordafrica, dall’Egitto all’Algeria, alla Tunisia, si profila una recessione senza precedenti, accompagnata da conflitti che non si fermano e da crisi di legittimità dei regimi che devono almeno far mangiare la propria gente. Una destabilizzazione che investe Iraq, Siria, Iran, Libano, Giordania e milioni di profughi che vagano dentro e ai margini di stati sempre più poveri e ora anche devastati dall’epidemia del coronavirus.
Questo è un mondo che più o meno direttamente dipende, per far quadrare i conti e sopravvivere, dall’oro nero e dagli investimenti legati all’industria petrolifera. Se i Paesi del Golfo, i più ricchi, stringono i cordoni della borsa anche per gli altri le prospettive sono plumbee. Basti pensare che il Qatar ha appena donato 150 milioni di dollari a Gaza.
Neanche troppo sullo sfondo ci sono gli Stati Uniti che non rinunciano al regime change a Teheran, epicentro mediorientale del Covid-19, mentre la Turchia regola i conti con i curdi uccidendo Nazife Bilen, la donna più alta in grado nelle fila dei combattenti del Pkk: perché le crisi, anche le peggiori, non fermano le guerre e neppure i volonterosi carnefici di popoli come Erdogan che è sempre in battaglia anche contro Assad nell’inferno umanitario di Idlib.
Succede così quello che non era accaduto con la Grande Depressione del 1929: essere pagati per portare via il petrolio in eccedenza. Non si era mai visto. I produttori non sanno dove stoccarlo e per questo alcuni Paesi e diverse multinazionali hanno cominciato a chiudere i pozzi e pure le raffinerie. Quando la crisi da coronavirus finirà potrebbe anche accadere il contrario: che non ci sarà abbastanza oro nero sui mercati.
La guerra del petrolio è stata innescata dal gran rifiuto della Russia di tagliare la produzione come aveva chiesto l’Arabia Saudita all’”Opec +1″, l’accordo dello storico Cartello petrolifero con Mosca che finora aveva tenuto a galla le quotazioni. Trump adesso si aggrappa a Putin per far rialzare i prezzi dopo avere convinto il “principe nero” Mohammed bin Salman a tagliare la produzione. Mosca pur di non cedere e mettere fuori mercato le società Usa, gravate dai debiti, è pronta a bruciare le riserve del Fondo sovrano russo (150 miliardi di dollari) per coprire le entrate mancate. In palio c’è la leadership del mercato dell’energia, non solo quello del petrolio ma anche del gas dove la Russia domina le forniture in Europa sia direttamente sia tramite l’hub della Turchia di Erdogan.
Ecco perché la battaglia ha risvolti strategici formidabili: si tratta anche di influenzare gli eventi in una vasta area dal Mediterraneo al Medio Oriente al Nordafrica. Ma anche lo zar potrebbe ripensarci: il gioco al ribasso può diventare una partita mortale.
Le compagnie americane dello shale oil sono in coma. Avevano cominciato la loro ascesa nel 2008 quando il costo del barile flirtava con quota 150 dollari, un’enormità che aveva spinto le società a investire a raffica nell’innovazione ma anche a indebitarsi. Già erano entrate in difficoltà nel 2016 quando era cominciato il calo del greggio e ora non sanno come ripagare i debiti, i loro titoli ormai sono quasi spazzatura. Da allora nel settore ci sono stati dozzine di fallimenti con debiti oltre i 120 miliardi di dollari.
Sono lacrime e sangue per tutti. Gli effetti dei ribassi possono essere prevedibili dal punto di vista economico ma assai più oscuri da quello strategico: se la situazione dovesse perdurare nel tempo i bilanci di paesi produttori, già in difficoltà per motivi interni e internazionali – come l’Iran sotto embargo, l’Algeria in una fase di transizione assai critica, l’Iraq delle rivolte e la Libia strangolata dalla guerra civile – possono subire colpi fatali. In questi Paesi il petrolio paga tutto o quasi: dal pane sulla tavola della gente comune ai ricatti di milizie che nessuno tiene a freno.
Fonte
30/03/2020
Quello che i Draghi non dicono
“Siamo in guerra e dobbiamo comportarci
di conseguenza”. Sono queste le parole con cui Mario Draghi, l’ex
presidente della Banca Centrale Europea (BCE), si è recentemente
pronunciato sul Financial Times in merito a come affrontare l’attuale emergenza economica e sanitaria conseguente alla diffusione del Coronavirus. Draghi ci dice che, in tempi di guerra o pandemia, quando si rischia il collasso dell’intero sistema produttivo, occorre fare ricorso ad un massiccio intervento pubblico per salvare il salvabile sia in termini di vite che di occupazione: “È già chiaro che la risposta dovrà comprendere un significativo incremento del debito pubblico”, con alti livelli di debito pubblico che diventeranno “una caratteristica permanente delle nostre economie”.
Sembrerebbero pensieri e parole in controtendenza rispetto a quelli solitamente espressi dallo stesso Draghi da Governatore della Banca d’Italia prima e della BCE poi. Ricordiamo infatti diversi episodi nei quali ha sostenuto il ricatto del debito per condizionare i Paesi della periferia: dalla lettera cofirmata al Governo Berlusconi alla crisi degli spread, con l’emblematica gestione del caso greco o, più in generale, la sistematica ingerenza nella vita politica ed economica dei Paesi dell’Eurozona. In tempo di guerra, però, l’intervento statale non è così malvisto nemmeno da Draghi. Lo Stato, quindi, dovrebbe spendere tutto il necessario per fronteggiare la crisi sanitaria ed economica scatenata dal dilagare della Covid-19. Il tema, continua l’ex governatore della BCE, non è quindi “se spendere o no”, bensì “come spendere”. I provvedimenti dello Stato per lavoratori e imprese saranno costosi: occorrerà sia potenziare gli ammortizzatori sociali come la cassa integrazione, sia rimborsare alle banche parte dei crediti che hanno verso le imprese non capaci di onorarli. Insomma, occorrono soldi, tanti soldi, se si vuole davvero “proteggere sia i posti di lavoro che la capacità produttiva”.
Tuttavia, una domanda sorge spontanea a questo punto: dove le prendiamo queste risorse per fronteggiare la crisi? Nell’attuale assetto istituzionale dell’Eurozona esistono essenzialmente due vie percorribili.
La prima è il ricorso al mercato: per finanziare la spesa aggiuntiva necessaria a fronteggiare l’emergenza, i governi potrebbero farsi prestare soldi dai mercati (banche, fondi di investimento, risparmiatori), emettendo titoli del debito pubblico. Sappiamo tuttavia che in questo scenario il ricatto dello spread sarebbe dietro l’angolo per i Paesi periferici, mentre i Paesi centrali potrebbero indebitarsi a tassi nulli o addirittura negativi non incorrendo in nessun rischio di instabilità finanziaria.
La seconda è il ricorso ad un prestito di carattere istituzionale erogato da una istituzione dell’Unione Europea. Occorre qui compiere un’ulteriore differenziazione.
– In un caso, un ente dell’UE come ad esempio la Banca Europea per gli Investimenti potrebbe emettere dei titoli di debito chiamati Covidbond, i quali sarebbero collocati sui mercati e, verosimilmente, sottoscritti almeno in parte dalla BCE. Le risorse così reperite sarebbero poi prestate ai singoli Stati. Si tratterebbe, almeno nell’idea dei Paesi periferici, di un aiuto apparentemente incondizionato. Non è detto però che questa sia la forma che assumerebbero, e non sembra nemmeno che questo sia lo scenario più plausibile (tutt’altro, almeno stando alle recenti dichiarazioni dei Paesi del nord, e alle comprensibili reazioni di alcuni Paesi periferici).
– Nell’altro caso, le risorse sarebbero ottenute dai singoli Stati facendo ricorso ad un prestito diretto dal MES, fondo che attualmente conta circa 700 miliardi di euro. Il prestito sarebbe erogato a condizione di un impegno (messo nero su bianco fin da subito tramite la sottoscrizione di un Memorandum o di una lettera di intenti) ad adottare ferree misure di austerità negli anni a venire.
In entrambi i casi, i singoli Paesi registrerebbero un aumento delle passività verso le istituzioni europee; nel secondo caso dovremmo fronteggiare con certezza la scure della condizionalità con le annesse pretese di tagli alla spesa pubblica e riforme del mercato del lavoro.
Torniamo ora a Draghi. Sul punto specifico di come reperire le risorse necessarie le sue parole diventano molto più sibilline: Draghi non menziona nessuna soluzione al problema di come finanziare il debito che lui stesso, con tanta veemenza, ci incoraggia a fare. Neppure prende in considerazione l’idea che l’Italia ‘vada per conto suo’ (a reperire le risorse sui mercati), dato che “sotto certi aspetti, l’Europa è ben attrezzata a fronteggiare questo straordinario shock”. Draghi sta senz’altro caldeggiando l’ipotesi di un prestito delle istituzioni europee lasciando però abilmente aperta la porta ad entrambe le interpretazioni: se le istituzioni europee saranno ‘morbide’, concederanno il prestito incondizionato, altrimenti sarà scelta la strada ‘dura’ del MES. Ciò che però sappiamo per certo è che mentre i Covidbond andrebbero ingegnerizzati (al momento sono solo uno slogan) e calati negli attuali assetti istituzionali, il MES è uno strumento già esistente e a disposizione delle economie europee.
Alla luce di quanto visto possiamo quindi dire due cose. Primo, in questo momento, premere per l’indebitamento significa sostanzialmente premere per il ricorso al MES. Secondo, Covidbond o MES, in entrambi i casi un Paese che ricorresse a questo tipo di prestiti cadrebbe nella morsa dell’austerità: più edulcorata, e con qualche margine di negoziazione, nel caso dei Covidbond, messa atrocemente nero su bianco fin da subito nel caso dell’appello al MES. In entrambi i casi l’obiettivo ultimo delle istituzioni europee sarebbe l’utilizzo dell’attuale crisi come un’occasione imperdibile per imporre con ancora più forza il loro controllo sulle economie nazionali.
Nel frattempo, l’Italia si dice pronta a varare una ulteriore manovra per fronteggiare l’emergenza, e quindi si troverà nella posizione di dover reperire le risorse per finanziare il deficit aggiuntivo. Stando alle dichiarazioni, occorrerà trovare circa 45 miliardi per finanziare la manovra di marzo e quella che arriverà ad aprile. E non basteranno se davvero si vorrà evitare il tracollo economico paventato. Tuttavia, nel contesto appena discusso la recente uscita del Premier Conte (“faremo da soli, spenderemo quanto serve”) rischia di essere una minaccia vuota qualora, come ribadito recentemente dalla neo-Governatrice Lagarde e salvo sorprese, la BCE non farà nulla per contenere la speculazione, con conseguente aumento del differenziale di rendimento rispetto ai Paesi centrali. In tal senso, nell’improbabile caso in cui Conte forzasse la mano, si aprirebbe uno scenario nel quale molti nodi verrebbero al pettine: sarebbe l’episodio più tangibile del costante strangolamento al quale la gabbia europea ci sottopone.
Al momento sappiamo solo che l’Eurogruppo si è riunito e ha rilasciato un comunicato in cui dice che stanno lavorando sul MES e sull’ECCL. Il Consiglio Europeo, da par suo, è in stallo e ha rinviato la palla all’Eurogruppo, lasciandogli 14 giorni per decidere. Con i Covidbond già bocciati da Olanda e Germania, e sotto il ricatto dello spread, l’Italia sarà quasi certamente costretta a ricorrere al MES. A quel punto, le condizioni del prestito saranno oggetto di negoziazione: uno scenario non improbabile è quello di un prestito condizionato non alle ferree regole previste per l’accesso alla Linea di Credito a Condizioni Rafforzate (ECCL), per le quali occorre la firma di un memorandum, bensì alla meno rigorosa ma comunque coercitiva lettera di intenti prevista per l’accesso alla Linea di Credito Precauzionale Condizionate (PCCL). Intenti che attesterebbero, ad ogni modo, l’impegno dell’Italia a mantenersi, nei prossimi anni, nel doloroso tracciato dell’austerità che solchiamo da ormai tre decenni.
Ribaltando il discorso di Draghi, la guerra in cui siamo non va solo intesa come la sacrosanta battaglia contro il Coronavirus ed i suoi effetti sull’economia, bensì anche come quella da combattere contro quei subdoli meccanismi di disciplina che, anche ai tempi della Covid-19, sono all’opera per imporre miseria, disoccupazione e precarietà ai Paesi periferici e più in generale alle classi subalterne. Meccanismi che, come visto, al momento vedono il ricorso al MES come l’unica soluzione strutturata sul tavolo.
Qualora l’attuale esecutivo decida di non accettare il prestito dal MES, rimarrebbe in auge l’ipotesi, molto discussa in questi giorni, di Draghi premier. La guida del governo da parte dell’ex presidente della BCE sarebbe nient’altro che la continuazione del MES con altri mezzi, la condizionalità fatta persona, incarnata da una figura perfetta per garantire il rispetto di quell’impegno a restare sul tracciato dell’austerità, resa più politicamente digeribile dall’evitare l’umiliazione del Memorandum. Sempre di lacrime e sangue si tratterebbe, ma in doppiopetto e corredate di un curriculum impeccabile.
Fonte
Sembrerebbero pensieri e parole in controtendenza rispetto a quelli solitamente espressi dallo stesso Draghi da Governatore della Banca d’Italia prima e della BCE poi. Ricordiamo infatti diversi episodi nei quali ha sostenuto il ricatto del debito per condizionare i Paesi della periferia: dalla lettera cofirmata al Governo Berlusconi alla crisi degli spread, con l’emblematica gestione del caso greco o, più in generale, la sistematica ingerenza nella vita politica ed economica dei Paesi dell’Eurozona. In tempo di guerra, però, l’intervento statale non è così malvisto nemmeno da Draghi. Lo Stato, quindi, dovrebbe spendere tutto il necessario per fronteggiare la crisi sanitaria ed economica scatenata dal dilagare della Covid-19. Il tema, continua l’ex governatore della BCE, non è quindi “se spendere o no”, bensì “come spendere”. I provvedimenti dello Stato per lavoratori e imprese saranno costosi: occorrerà sia potenziare gli ammortizzatori sociali come la cassa integrazione, sia rimborsare alle banche parte dei crediti che hanno verso le imprese non capaci di onorarli. Insomma, occorrono soldi, tanti soldi, se si vuole davvero “proteggere sia i posti di lavoro che la capacità produttiva”.
Tuttavia, una domanda sorge spontanea a questo punto: dove le prendiamo queste risorse per fronteggiare la crisi? Nell’attuale assetto istituzionale dell’Eurozona esistono essenzialmente due vie percorribili.
La prima è il ricorso al mercato: per finanziare la spesa aggiuntiva necessaria a fronteggiare l’emergenza, i governi potrebbero farsi prestare soldi dai mercati (banche, fondi di investimento, risparmiatori), emettendo titoli del debito pubblico. Sappiamo tuttavia che in questo scenario il ricatto dello spread sarebbe dietro l’angolo per i Paesi periferici, mentre i Paesi centrali potrebbero indebitarsi a tassi nulli o addirittura negativi non incorrendo in nessun rischio di instabilità finanziaria.
La seconda è il ricorso ad un prestito di carattere istituzionale erogato da una istituzione dell’Unione Europea. Occorre qui compiere un’ulteriore differenziazione.
– In un caso, un ente dell’UE come ad esempio la Banca Europea per gli Investimenti potrebbe emettere dei titoli di debito chiamati Covidbond, i quali sarebbero collocati sui mercati e, verosimilmente, sottoscritti almeno in parte dalla BCE. Le risorse così reperite sarebbero poi prestate ai singoli Stati. Si tratterebbe, almeno nell’idea dei Paesi periferici, di un aiuto apparentemente incondizionato. Non è detto però che questa sia la forma che assumerebbero, e non sembra nemmeno che questo sia lo scenario più plausibile (tutt’altro, almeno stando alle recenti dichiarazioni dei Paesi del nord, e alle comprensibili reazioni di alcuni Paesi periferici).
– Nell’altro caso, le risorse sarebbero ottenute dai singoli Stati facendo ricorso ad un prestito diretto dal MES, fondo che attualmente conta circa 700 miliardi di euro. Il prestito sarebbe erogato a condizione di un impegno (messo nero su bianco fin da subito tramite la sottoscrizione di un Memorandum o di una lettera di intenti) ad adottare ferree misure di austerità negli anni a venire.
In entrambi i casi, i singoli Paesi registrerebbero un aumento delle passività verso le istituzioni europee; nel secondo caso dovremmo fronteggiare con certezza la scure della condizionalità con le annesse pretese di tagli alla spesa pubblica e riforme del mercato del lavoro.
Torniamo ora a Draghi. Sul punto specifico di come reperire le risorse necessarie le sue parole diventano molto più sibilline: Draghi non menziona nessuna soluzione al problema di come finanziare il debito che lui stesso, con tanta veemenza, ci incoraggia a fare. Neppure prende in considerazione l’idea che l’Italia ‘vada per conto suo’ (a reperire le risorse sui mercati), dato che “sotto certi aspetti, l’Europa è ben attrezzata a fronteggiare questo straordinario shock”. Draghi sta senz’altro caldeggiando l’ipotesi di un prestito delle istituzioni europee lasciando però abilmente aperta la porta ad entrambe le interpretazioni: se le istituzioni europee saranno ‘morbide’, concederanno il prestito incondizionato, altrimenti sarà scelta la strada ‘dura’ del MES. Ciò che però sappiamo per certo è che mentre i Covidbond andrebbero ingegnerizzati (al momento sono solo uno slogan) e calati negli attuali assetti istituzionali, il MES è uno strumento già esistente e a disposizione delle economie europee.
Alla luce di quanto visto possiamo quindi dire due cose. Primo, in questo momento, premere per l’indebitamento significa sostanzialmente premere per il ricorso al MES. Secondo, Covidbond o MES, in entrambi i casi un Paese che ricorresse a questo tipo di prestiti cadrebbe nella morsa dell’austerità: più edulcorata, e con qualche margine di negoziazione, nel caso dei Covidbond, messa atrocemente nero su bianco fin da subito nel caso dell’appello al MES. In entrambi i casi l’obiettivo ultimo delle istituzioni europee sarebbe l’utilizzo dell’attuale crisi come un’occasione imperdibile per imporre con ancora più forza il loro controllo sulle economie nazionali.
Nel frattempo, l’Italia si dice pronta a varare una ulteriore manovra per fronteggiare l’emergenza, e quindi si troverà nella posizione di dover reperire le risorse per finanziare il deficit aggiuntivo. Stando alle dichiarazioni, occorrerà trovare circa 45 miliardi per finanziare la manovra di marzo e quella che arriverà ad aprile. E non basteranno se davvero si vorrà evitare il tracollo economico paventato. Tuttavia, nel contesto appena discusso la recente uscita del Premier Conte (“faremo da soli, spenderemo quanto serve”) rischia di essere una minaccia vuota qualora, come ribadito recentemente dalla neo-Governatrice Lagarde e salvo sorprese, la BCE non farà nulla per contenere la speculazione, con conseguente aumento del differenziale di rendimento rispetto ai Paesi centrali. In tal senso, nell’improbabile caso in cui Conte forzasse la mano, si aprirebbe uno scenario nel quale molti nodi verrebbero al pettine: sarebbe l’episodio più tangibile del costante strangolamento al quale la gabbia europea ci sottopone.
Al momento sappiamo solo che l’Eurogruppo si è riunito e ha rilasciato un comunicato in cui dice che stanno lavorando sul MES e sull’ECCL. Il Consiglio Europeo, da par suo, è in stallo e ha rinviato la palla all’Eurogruppo, lasciandogli 14 giorni per decidere. Con i Covidbond già bocciati da Olanda e Germania, e sotto il ricatto dello spread, l’Italia sarà quasi certamente costretta a ricorrere al MES. A quel punto, le condizioni del prestito saranno oggetto di negoziazione: uno scenario non improbabile è quello di un prestito condizionato non alle ferree regole previste per l’accesso alla Linea di Credito a Condizioni Rafforzate (ECCL), per le quali occorre la firma di un memorandum, bensì alla meno rigorosa ma comunque coercitiva lettera di intenti prevista per l’accesso alla Linea di Credito Precauzionale Condizionate (PCCL). Intenti che attesterebbero, ad ogni modo, l’impegno dell’Italia a mantenersi, nei prossimi anni, nel doloroso tracciato dell’austerità che solchiamo da ormai tre decenni.
Ribaltando il discorso di Draghi, la guerra in cui siamo non va solo intesa come la sacrosanta battaglia contro il Coronavirus ed i suoi effetti sull’economia, bensì anche come quella da combattere contro quei subdoli meccanismi di disciplina che, anche ai tempi della Covid-19, sono all’opera per imporre miseria, disoccupazione e precarietà ai Paesi periferici e più in generale alle classi subalterne. Meccanismi che, come visto, al momento vedono il ricorso al MES come l’unica soluzione strutturata sul tavolo.
Qualora l’attuale esecutivo decida di non accettare il prestito dal MES, rimarrebbe in auge l’ipotesi, molto discussa in questi giorni, di Draghi premier. La guida del governo da parte dell’ex presidente della BCE sarebbe nient’altro che la continuazione del MES con altri mezzi, la condizionalità fatta persona, incarnata da una figura perfetta per garantire il rispetto di quell’impegno a restare sul tracciato dell’austerità, resa più politicamente digeribile dall’evitare l’umiliazione del Memorandum. Sempre di lacrime e sangue si tratterebbe, ma in doppiopetto e corredate di un curriculum impeccabile.
Fonte
Coldiretti: “senza stranieri raccolti a rischio, servono studenti e pensionati”
È come in quel film del 2011 che narrava di una città veneta in cui, in una notte, scompaiono tutti gli immigrati ed al tizio che invocava, tutti i giorni, dalla sua TV privata, uno tsunami xenofobo, va in tilt la fabbrichetta.
Quella di Coldiretti sembra una confessione in piena regola: la grande filiera agroalimentare italiana si regge sullo sfruttamento selvaggio dei lavoratori stranieri senza diritti, preda del capolarato e del ricatto del rinnovo del permesso di soggiorno.
Sono i braccianti agricoli che lavorano nelle campagne di Puglia, Calabria, Agro Pontino ecc. che si spaccano la schiena per 14 ore al giorno; che vivono in quelle sterminate baraccopoli che vanno a fuoco ogni due per tre; che sono prive di acqua e di ogni più elementare servizio, in primis, quelli igienici.
Come i 10 che sono morti il 5 agosto del 2018, ammassati nel furgone del caporale come bestie verso il macello, sulla strada provinciale 105 tra Ascoli Satriano e Castelluccio dei Sauri, in Puglia.
O come il nostro compagno di USB, Soumaila Sacko, bracciante e sindacalista attivista per i diritti dei lavoratori agricoli ucciso a fucilate il 2 giugno del 2018 nei pressi della tendopoli di San Ferdinando(RC), nella piana di Gioia Tauro in Calabria. San Ferdinando: una baraccopoli che accoglie centinaia di braccianti in condizioni disumane ed in cui, a gennaio, sempre in quell’anno maledetto, perse la vita Becky Moses, una ragazza di 26 anni proveniente dal Niger.
Se pensi da schiavista, neanche ci fa più caso, a quel che dici.
Fonte
Quella di Coldiretti sembra una confessione in piena regola: la grande filiera agroalimentare italiana si regge sullo sfruttamento selvaggio dei lavoratori stranieri senza diritti, preda del capolarato e del ricatto del rinnovo del permesso di soggiorno.
Sono i braccianti agricoli che lavorano nelle campagne di Puglia, Calabria, Agro Pontino ecc. che si spaccano la schiena per 14 ore al giorno; che vivono in quelle sterminate baraccopoli che vanno a fuoco ogni due per tre; che sono prive di acqua e di ogni più elementare servizio, in primis, quelli igienici.
Come i 10 che sono morti il 5 agosto del 2018, ammassati nel furgone del caporale come bestie verso il macello, sulla strada provinciale 105 tra Ascoli Satriano e Castelluccio dei Sauri, in Puglia.
O come il nostro compagno di USB, Soumaila Sacko, bracciante e sindacalista attivista per i diritti dei lavoratori agricoli ucciso a fucilate il 2 giugno del 2018 nei pressi della tendopoli di San Ferdinando(RC), nella piana di Gioia Tauro in Calabria. San Ferdinando: una baraccopoli che accoglie centinaia di braccianti in condizioni disumane ed in cui, a gennaio, sempre in quell’anno maledetto, perse la vita Becky Moses, una ragazza di 26 anni proveniente dal Niger.
Se pensi da schiavista, neanche ci fa più caso, a quel che dici.
Fonte
La sanità italiana di fronte alla crisi del coronavirus
Il testo seguente non aggiunge nulla di nuovo per chi lo propone e per chi segue questa e altre pagine. Anzi a dirla tutta c'è pure chi si è espresso meglio – sia nell'analisi numerica, sia politica – sull'argomento.
Qui, infatti, risulta quasi surreale definire l'attuale pandemia come "fenomeno inaspettato" dal momento che le epidemie di SARS e "suina" datano rispettivamente 2003 e 2009, non proprio ieri insomma...
Altrettanto miope è la considerazione per cui il SSN non necessiti di interventi a livello istituzionale e manageriale, come se la riforma del titolo V della Costituzione – che ha regionalizzato le prestazioni sanitarie – e l'aziendalizzazione degli ospedali, fossero passate come acqua fresca sulla qualità del servizio di cura e assistenza erogato alla cittadinanza...
Insomma anche i più onesti e ben disposti componenti della società civile hanno ancora parecchie cortine fumogene da diradare davanti ai propri orizzonti, ma, quantomeno, il dato materiale della riduzione delle risorse con cui operare è oggi riconosciuto da tutti.
OCIS si è recentemente occupata del tema dello stato della sanità italiana tramite due interventi redatti dal sottoscritto (Fact Sheet, 10/2019 e Policy Memo, 10/2019). I due interventi mettevano in chiaro quali siano le principali luci ed ombre del nostro sistema sanitario nazionale (SSN) e lo facevano in tempi non sospetti rispetto alla crisi attuale (era l’ottobre 2019).
Rimandando ai due testi sopra menzionati per gli approfondimenti necessari, è utile rileggere oggi i punti essenziali messi a suo tempo in luce per poi riflettere su quanto sta drammaticamente accadendo ora e su quanto sarà necessario fare in futuro. Innanzitutto, il documento metteva in chiaro un aspetto fondamentale, che risalta drammaticamente ora in piena crisi: il nostro SSN ha assicurato e continua ad assicurare una buona qualità della cura. Tuttavia, esso presenta tre elementi critici, che adesso rischiano di diventare esplosivi: la limitatezza delle risorse economiche messe a disposizione del SSN; l’eccessivo carico posto sulle spalle degli operatori della sanità (dai medici agli infermieri e alle altre figure professionali) in termini di condizioni di lavoro; le diseguaglianze nell’accesso ai servizi.
Rispetto alle polemiche di questi giorni, con varie fonti che parlano di tagli draconiani alla sanità italiana degli ultimi anni, occorre essere più precisi. La figura 1 mette in luce quanto è successo alla spesa pubblica sanitaria in Italia nel medio periodo. È utile impiegare come indicatore la spesa pro-capite a prezzi costanti per capire se un aumento della spesa nel corso del tempo sia dovuto ad un effettivo incremento delle risorse immesse nel SSN o dipenda invece dall’inflazione (la spesa aumenta solo nominalmente ma non realmente) o da un aumento della popolazione nel suo complesso (la spesa aumenta perché vi sono più persone). Se prendiamo l’ultimo ventennio (dal 2000 al 2018), notiamo che la spesa è aumentata e non diminuita. Tuttavia, questo aumento si è verificato sostanzialmente nel primo decennio del XXI secolo, mentre nell’ultimo decennio vi sono stati prima tagli e poi stabilità nella spesa, che però non è tornata ai livelli pre-crisi.
Figura 1 Andamento nel tempo della spesa pro-capite pubblica in sanità in Italia (spesa espressa in euro e a prezzi costanti 2010) (anni 2000-2018)
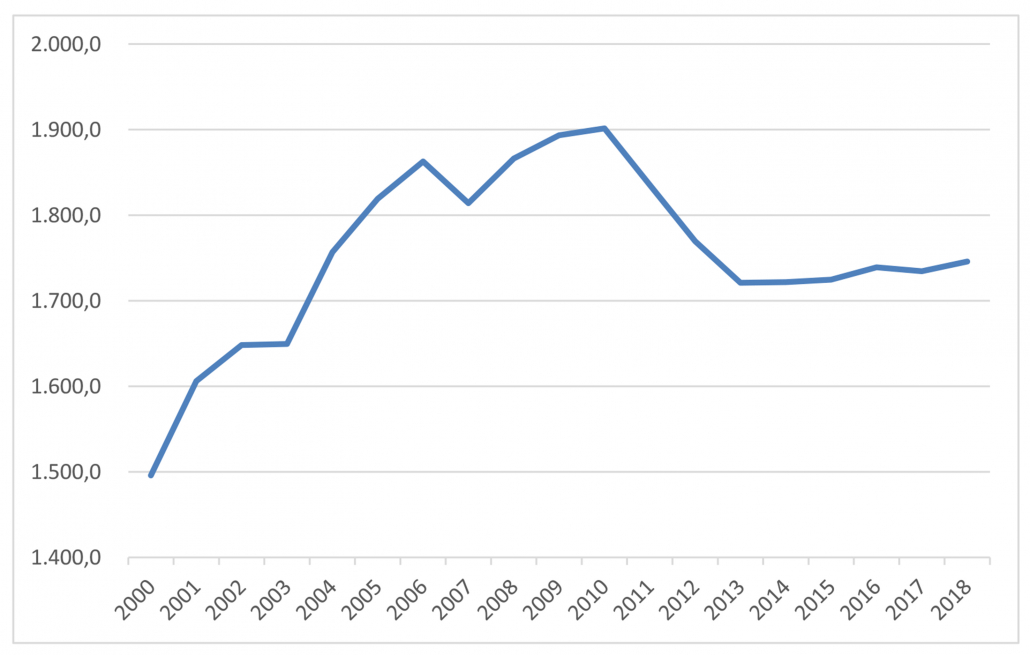
Inoltre, dato anche più preoccupante, l’Italia nell’ultimo ventennio ha complessivamente perso terreno rispetto a buona parte del resto dell’Europa occidentale: pur avendo aumentato la spesa, lo ha fatto meno di tanti altri paesi. L’Italia è un paese che ormai da due decenni spende (molto) meno per la salute di ciascuno di noi rispetto all’Europa occidentale (tabella 1, ripresa da Fact Sheet 10/2019). Già nel 2000 la spesa pro-capite pubblica in sanità in Italia era di circa il 9% più bassa della media dei paesi dell’UE-15. In altri termini, nel 2000 per ogni 100 euro spesi in sanità pubblica per un cittadino dell’Europa occidentale, l’Italia ne spendeva 91. La situazione è precipitata negli anni della crisi. Nel 2018 il nostro paese spendeva oltre un quarto di meno per ciascuno di noi rispetto alla media dell’UE-15.
Tabella 1. Le risorse economiche per la sanità pubblica in Italia in ottica comparata nel tempo (spesa pubblica italiana pro-capite in sanità espressa in percentuale di quella media dell’UE-15 a parità di potere di acquisto)
Fonte: elaborazione da OECD Health Statistics online database (2019) (https://stats.oecd.org) – tabella tratta da FACT SHEET OCIS n.10 – Ottobre 2019
Quindi, l’Italia nel medio periodo (venti anni) non ha tagliato la spesa: oggi si spende di più pro-capite di quanto si facesse nel 2000. Tuttavia, ha fatto tagli nell’ultimo decennio e soprattutto spende per ognuno di noi molto meno di quanto fanno mediamente gli altri paesi dell’Europa occidentale. La domanda da porsi è, quindi, perché gli altri paesi europei spendono più di noi? Siamo efficienti noi e gli altri spreconi?
Di certo, l’Italia ha fatto passi avanti nell’efficienza del sistema sanitario, al di là dei lamenti che regolarmente fino a pochi mesi fa si alzavano sul tema e chiedevano (chiederanno?) ulteriori tagli, efficienza e spending review. Tuttavia, non va dimenticato che la spesa pro-capite altrove è cresciuta più che da noi per tenere dietro a due tendenze non controllabili semplicemente con migliore efficienza nell’uso delle risorse: l’invecchiamento della popolazione (buona parte della spesa sanitaria si concentra sulle fasce più adulte ed anziane della popolazione, anche in tempi di non coronavirus, e quindi se aumentano gli anziani aumenta il bisogno e... dovrebbe aumentare la spesa); la tecnologia (parte della spesa è guidata da innovazioni nei macchinari per diagnosi e cura, così come da nuovi farmaci, che migliorano la qualità della cura e, spesso, della vita). Pertanto, la nostra efficienza di questi anni (ripeto, con buona pace di alcuni che ancora continuano a pretendere spending review in sanità...) è già encomiabile ma non è in grado di coprire i buchi che un limitato aumento della spesa nel medio periodo – e addirittura tagli nell’ultimo decennio – ha creato.
A pagare le spese in questi ultimi decenni (soprattutto l’ultimo) di un sistema che regge sotto il profilo della performance, ma con risorse finanziarie calanti (e ormai scarse), sono stati i lavoratori e alcuni gruppi sociali. Ripeto quanto scritto ad ottobre. Per quanto riguarda i lavoratori, nell’ultimo decennio il blocco delle assunzioni, che ha riguardato anche la sanità, ha accentuato due caratteri già tipici del SSN: la scarsa presenza relativa di infermieri e una forza lavoro di medici che va invecchiando e calando numericamente. La tabella 2 ci mostra in maniera impietosa lo stato delle risorse umane nella sanità italiana in ottica comparata. Rispetto agli altri paesi considerati nella tabella, l’Italia ha molto meno personale in campo sanitario e sociale. Inoltre, specificatamente in campo sanitario ha relativamente pochi infermieri e una forza lavoro di medici, abbastanza in linea con quella di altri paesi ma molto più “invecchiata”: oltre la metà dei medici italiani ha più di 55 anni.
Inoltre, la spesa sanitaria pubblica pro-capite più bassa che in molti altri paesi ha comportato un maggiore esborso di risorse da parte dei cittadini. Chiaramente, non tutti possono permettersi di pagare di tasca propria prestazioni sanitarie e, quindi, accanto a una incidenza della spesa privata in sanità più alta che altrove in Europa occidentale, vi è una fetta di popolazione comparativamente più consistente, concentrata fra quella a redditi bassi e medio-bassi, che afferma di dover rinunciare ad alcune cure sanitarie per motivi di costo, distanza o liste di attesa. Infine, specificità tutta Italia, oltre che per classe sociale, i problemi di accesso e di qualità delle cure assumono un grado e una intensità differenti a seconda del territorio, con le regioni del Sud Italia in genere nettamente più svantaggiate rispetto a quelle del Centro-Nord.
Due punti importanti vanno, infine, sottolineati rispetto alle critiche che vengono indirizzate a come è stato gestito il SSN in questi ultimi decenni. Primo, realisticamente fino a pochi mesi fa pochissimi (per non dire quasi nessuno) di coloro che si occupavano di sanità pensavano che la sfida al SSN sarebbe arrivata da una epidemia (tanto meno da una pandemia). Il pensiero che si è affermato (condiviso anche dal sottoscritto) era invece quello di dover rafforzare il sistema di intervento non tanto rispetto alle acuzie (su cui molti passi avanti si sono fatti in questi decenni) quanto verso la cura delle cronicità. Negli ultimi decenni era questa l’area di bisogno socio-sanitario largamente in espansione. Quindi, la logica che ha guidato la trasformazione di molti sistemi sanitari occidentali è stata: meno posti letto per acuti in ospedale e più attività di ambulatoriale/specialistica sul territorio, più strutture socio-sanitarie residenziali (ad esempio, RSA) e più interventi domiciliari. L’Italia da questo punto di vista non è stata totalmente in grado di effettuare la transizione ed è rimasta in mezzo al guado. Si sono chiusi reparti ospedalieri e in una parte del paese (soprattutto il Centro-Sud) non si sono rafforzate adeguatamente le reti di intervento territoriali. Nel momento in cui è arrivato un fenomeno drammatico e inaspettato per quasi tutti gli esperti in sanità come il coronavirus, il nostro paese si è ritrovato con meno posti letto in ospedale, ma senza neanche una adeguata dotazione di servizi socio-sanitari residenziali e territoriali, e con un numero decrescente di medici ed infermieri, che già da un decennio stavano (sup-) portando sulle proprie spalle i tagli alla sanità. La tabella 3 serve di nuovo per contestualizzare il caso italiano in ottica comparata. Il numero di posti letto ospedalieri per acuti in Italia è relativamente contenuto ma non è molto differente da quello che avviene in molti altri paesi. Semmai, da questo punto di vista la Germania (un paese di cui si discute molto in questi giorni sui mass media) è un caso “anomalo” rispetto a tutti gli altri. Il problema è che gli altri paesi hanno investito molto più che in Italia in tutto ciò che non è acuto ospedaliero.
Quest’ultima riflessione ci porta alle conclusioni del nostro ragionamento. Nell’ultimo ventennio, ed in particolare nell’ultimo decennio, indipendentemente da chi abbia governato a livello nazionale, non si è avuto un serio investimento in sanità. Anzi. Alcuni segnali in positivo sono giunti con l’ultima legge di Stabilità dello scorso dicembre. Tuttavia, vi è un problema generalizzato di scarsa attenzione alla cura e alla manutenzione della sanità pubblica. Come scrivevo alcuni mesi fa nel Policy Memo sopra citato, se si osservano in prospettiva comparata il livello (scarso) di risorse economiche investite nella sanità pubblica nell’ultimo ventennio e i buoni risultati in termini di cura e di salute ottenuti rispetto a quanto avvenuto in molti altri paesi occidentali, possiamo parlare di un ‘quasi miracolo’: riuscire ad avere una buona sanità pubblica con limitate risorse. Aggiungevo in quel testo che le possibilità che il ‘quasi miracolo’ continui si stanno, però, rarefacendo, dato che si basavano sul super-sfruttamento della professionalità, etica e disponibilità di chi opera in sanità e sulla capacità di spesa privata di molte famiglie. Il crescente disinvestimento nelle risorse umane stava minando la resilienza del personale in sanità, crescentemente oberato di incarichi. Tutto ciò avveniva prima dell’emergenza Coronavirus...
La ricetta quasi banale che si proponeva in quella sede era: la sanità pubblica italiana ha semplicemente bisogno di più risorse finanziarie. Il SSN è migliorabile, ma ha già raggiunto un buon, se non ottimo livello, di performance gestionale e professionale. Non sono necessari chissà quali interventi di ingegneria istituzionale o manageriale per mantenere il SSN a livelli adeguati: bastano più soldi per investimenti in assunzioni e per il personale (a partire da più borse di studio per gli specializzandi nelle discipline mediche), oltre che in manutenzione/ampliamento di servizi e strutture. Indubbiamente la capacità di azione del SSN è migliore al Centro-Nord Italia rispetto al Sud, dove ancora c’è molto da fare in termini di efficientamento e appropriatezza degli interventi pubblici. Tuttavia, il tema della spesa resta centrale e ritengo opportuno concludere queste riflessioni con una domanda: come mai la politica in questi anni ha prestato attenzione a tanti temi importanti, relativi alla protezione sociale delle persone, aumentando considerevolmente la spesa pubblica in un periodo di austerity (dalle pensioni con “Quota 100” al Reddito di Cittadinanza nel campo del contrasto alla povertà per fare i due esempi più recenti) ma ha trascurato la sanità (e si dovrebbe aggiungere, il sistema educativo e le politiche per la cura di bambini e anziani)?
Sicuramente una parte della risposta va cercata nella drammaticità della situazione italiana dell’ultimo decennio, che ha spinto l’attenzione della politica verso alcune direzioni piuttosto che altre (ad esempio, dal 2007 al 2018 i poveri relativi sono passati da circa 6 milioni a 9 milioni). Purtroppo, la sanità è rimasta indietro. Tuttavia, dato che viviamo in democrazia, occorre evitare di dare la colpa solo alla politica. In democrazia funziona un principio di competizione / collaborazione che si basa sulla domanda di interventi (politiche) da parte di cittadini, imprese e società civile e sull’offerta di interventi da parte di partiti e governi. Se la sanità non ha acquisito un ruolo importante nell’agenda dei governi dell’ultimo decennio (in realtà sarebbe più appropriato riferirsi all’ultimo ventennio) è stato sicuramente per miopia della politica che, anche per tante ragioni comprensibili si è data altre priorità, ma anche per scarsa attenzione di cittadini, imprese e società civile, anche essi (noi) abbastanza miopi da non mettere la sanità ai primi posti delle loro richieste ai partiti.
La pandemia in atto ci ricorda drammaticamente come il nostro paese non si possa permettere di continuare la tendenza dell’ultimo ventennio. Tutto ciò richiede sicuramente una classe politica adeguata (decenni fa, prima dell’ondata del neopopulismo approssimativo e da tastiera degli ultimi anni, avremmo scritto che abbiamo bisogno di una ‘élite modernizzante’, utilizzando con accezione positiva i termini di ‘élite’ e “modernizzazione”), ma anche una società civile che si mobilita concretamente e mette il rilancio ed il sostegno alla sanità pubblica (unitamente all’istruzione e al sostegno alle attività di cura delle famiglie) al centro delle domande di tutela fatte alla politica.
Se dopo la fine della crisi pandemica attuale la società civile e i cittadini non si organizzeranno e non chiederanno maggiore attenzione alla sanità, limitandosi a ringraziare gli eroi della sanità, che stanno pagando un prezzo altissimo in termini di salute, il dramma che stiamo attraversando in questo periodo non ci avrà insegnato a sufficienza quali sono le priorità a cui dobbiamo guardare come paese e su quali punti pretendere prioritariamente risposte adeguate dalla classe politica e dalle istituzioni.
Fonte
Qui, infatti, risulta quasi surreale definire l'attuale pandemia come "fenomeno inaspettato" dal momento che le epidemie di SARS e "suina" datano rispettivamente 2003 e 2009, non proprio ieri insomma...
Altrettanto miope è la considerazione per cui il SSN non necessiti di interventi a livello istituzionale e manageriale, come se la riforma del titolo V della Costituzione – che ha regionalizzato le prestazioni sanitarie – e l'aziendalizzazione degli ospedali, fossero passate come acqua fresca sulla qualità del servizio di cura e assistenza erogato alla cittadinanza...
Insomma anche i più onesti e ben disposti componenti della società civile hanno ancora parecchie cortine fumogene da diradare davanti ai propri orizzonti, ma, quantomeno, il dato materiale della riduzione delle risorse con cui operare è oggi riconosciuto da tutti.
*****
OCIS si è recentemente occupata del tema dello stato della sanità italiana tramite due interventi redatti dal sottoscritto (Fact Sheet, 10/2019 e Policy Memo, 10/2019). I due interventi mettevano in chiaro quali siano le principali luci ed ombre del nostro sistema sanitario nazionale (SSN) e lo facevano in tempi non sospetti rispetto alla crisi attuale (era l’ottobre 2019).
Rimandando ai due testi sopra menzionati per gli approfondimenti necessari, è utile rileggere oggi i punti essenziali messi a suo tempo in luce per poi riflettere su quanto sta drammaticamente accadendo ora e su quanto sarà necessario fare in futuro. Innanzitutto, il documento metteva in chiaro un aspetto fondamentale, che risalta drammaticamente ora in piena crisi: il nostro SSN ha assicurato e continua ad assicurare una buona qualità della cura. Tuttavia, esso presenta tre elementi critici, che adesso rischiano di diventare esplosivi: la limitatezza delle risorse economiche messe a disposizione del SSN; l’eccessivo carico posto sulle spalle degli operatori della sanità (dai medici agli infermieri e alle altre figure professionali) in termini di condizioni di lavoro; le diseguaglianze nell’accesso ai servizi.
Rispetto alle polemiche di questi giorni, con varie fonti che parlano di tagli draconiani alla sanità italiana degli ultimi anni, occorre essere più precisi. La figura 1 mette in luce quanto è successo alla spesa pubblica sanitaria in Italia nel medio periodo. È utile impiegare come indicatore la spesa pro-capite a prezzi costanti per capire se un aumento della spesa nel corso del tempo sia dovuto ad un effettivo incremento delle risorse immesse nel SSN o dipenda invece dall’inflazione (la spesa aumenta solo nominalmente ma non realmente) o da un aumento della popolazione nel suo complesso (la spesa aumenta perché vi sono più persone). Se prendiamo l’ultimo ventennio (dal 2000 al 2018), notiamo che la spesa è aumentata e non diminuita. Tuttavia, questo aumento si è verificato sostanzialmente nel primo decennio del XXI secolo, mentre nell’ultimo decennio vi sono stati prima tagli e poi stabilità nella spesa, che però non è tornata ai livelli pre-crisi.
Figura 1 Andamento nel tempo della spesa pro-capite pubblica in sanità in Italia (spesa espressa in euro e a prezzi costanti 2010) (anni 2000-2018)
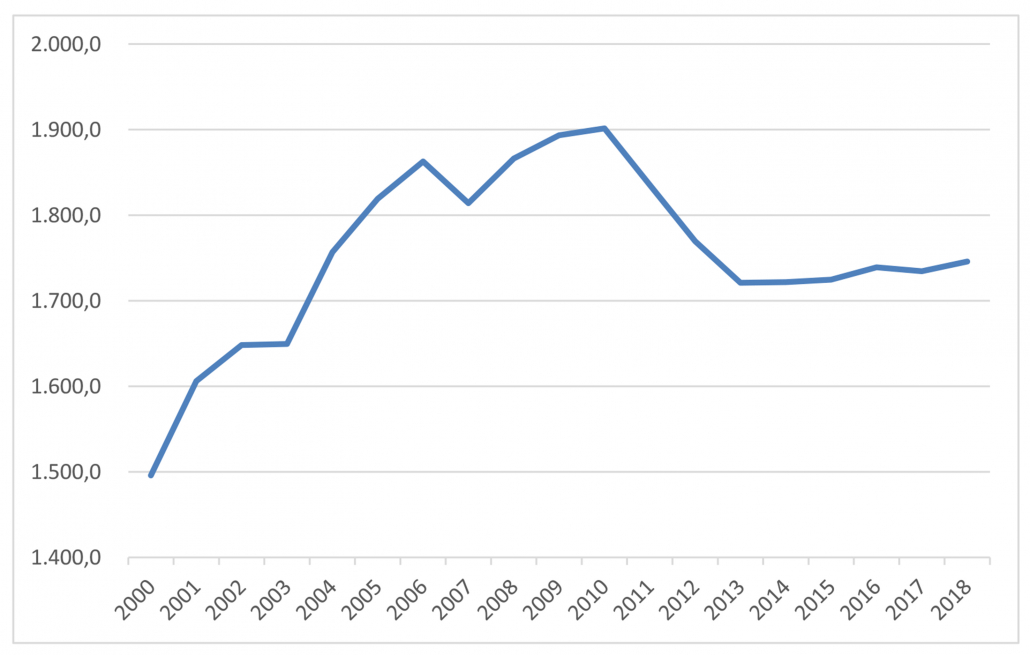
Fonte: elaborazione da OECD Health Statistics online database (2020) (https://stats.oecd.org)
Inoltre, dato anche più preoccupante, l’Italia nell’ultimo ventennio ha complessivamente perso terreno rispetto a buona parte del resto dell’Europa occidentale: pur avendo aumentato la spesa, lo ha fatto meno di tanti altri paesi. L’Italia è un paese che ormai da due decenni spende (molto) meno per la salute di ciascuno di noi rispetto all’Europa occidentale (tabella 1, ripresa da Fact Sheet 10/2019). Già nel 2000 la spesa pro-capite pubblica in sanità in Italia era di circa il 9% più bassa della media dei paesi dell’UE-15. In altri termini, nel 2000 per ogni 100 euro spesi in sanità pubblica per un cittadino dell’Europa occidentale, l’Italia ne spendeva 91. La situazione è precipitata negli anni della crisi. Nel 2018 il nostro paese spendeva oltre un quarto di meno per ciascuno di noi rispetto alla media dell’UE-15.
Tabella 1. Le risorse economiche per la sanità pubblica in Italia in ottica comparata nel tempo (spesa pubblica italiana pro-capite in sanità espressa in percentuale di quella media dell’UE-15 a parità di potere di acquisto)
| 2000 | 2005 | 2010 | 2018 |
| 91% | 90% | 83% | 73% |
Fonte: elaborazione da OECD Health Statistics online database (2019) (https://stats.oecd.org) – tabella tratta da FACT SHEET OCIS n.10 – Ottobre 2019
Quindi, l’Italia nel medio periodo (venti anni) non ha tagliato la spesa: oggi si spende di più pro-capite di quanto si facesse nel 2000. Tuttavia, ha fatto tagli nell’ultimo decennio e soprattutto spende per ognuno di noi molto meno di quanto fanno mediamente gli altri paesi dell’Europa occidentale. La domanda da porsi è, quindi, perché gli altri paesi europei spendono più di noi? Siamo efficienti noi e gli altri spreconi?
Di certo, l’Italia ha fatto passi avanti nell’efficienza del sistema sanitario, al di là dei lamenti che regolarmente fino a pochi mesi fa si alzavano sul tema e chiedevano (chiederanno?) ulteriori tagli, efficienza e spending review. Tuttavia, non va dimenticato che la spesa pro-capite altrove è cresciuta più che da noi per tenere dietro a due tendenze non controllabili semplicemente con migliore efficienza nell’uso delle risorse: l’invecchiamento della popolazione (buona parte della spesa sanitaria si concentra sulle fasce più adulte ed anziane della popolazione, anche in tempi di non coronavirus, e quindi se aumentano gli anziani aumenta il bisogno e... dovrebbe aumentare la spesa); la tecnologia (parte della spesa è guidata da innovazioni nei macchinari per diagnosi e cura, così come da nuovi farmaci, che migliorano la qualità della cura e, spesso, della vita). Pertanto, la nostra efficienza di questi anni (ripeto, con buona pace di alcuni che ancora continuano a pretendere spending review in sanità...) è già encomiabile ma non è in grado di coprire i buchi che un limitato aumento della spesa nel medio periodo – e addirittura tagli nell’ultimo decennio – ha creato.
A pagare le spese in questi ultimi decenni (soprattutto l’ultimo) di un sistema che regge sotto il profilo della performance, ma con risorse finanziarie calanti (e ormai scarse), sono stati i lavoratori e alcuni gruppi sociali. Ripeto quanto scritto ad ottobre. Per quanto riguarda i lavoratori, nell’ultimo decennio il blocco delle assunzioni, che ha riguardato anche la sanità, ha accentuato due caratteri già tipici del SSN: la scarsa presenza relativa di infermieri e una forza lavoro di medici che va invecchiando e calando numericamente. La tabella 2 ci mostra in maniera impietosa lo stato delle risorse umane nella sanità italiana in ottica comparata. Rispetto agli altri paesi considerati nella tabella, l’Italia ha molto meno personale in campo sanitario e sociale. Inoltre, specificatamente in campo sanitario ha relativamente pochi infermieri e una forza lavoro di medici, abbastanza in linea con quella di altri paesi ma molto più “invecchiata”: oltre la metà dei medici italiani ha più di 55 anni.
Tabella 2. La dotazione di risorse umane nella sanità italiana in ottica comparata (anno 2016)
| N° di professionisti in sanità e servizi sociali ogni 1000 abitanti | N° di infermieri ogni 1000 abitanti | N° di medici ogni 1000 abitanti | % di medici con almeno 55 anni su totale dei medici | |
| Francia | 58,5 | 10,2 | 3,1 | 45,6 |
| Germania | 69,7 | 12,8 | 4,2 | 45,7 |
| Italia | 31,3 | 5,6 | 3,9 | 53,1 |
| Svezia | 85,3 | 10,9 | 4,1 | 43,7 |
| Regno Unito | 59,2 | 7,9 | 2,8 | 25,7 |
Fonte: elaborazione da OECD Health Statistics online database (2020) (https://stats.oecd.org)
Inoltre, la spesa sanitaria pubblica pro-capite più bassa che in molti altri paesi ha comportato un maggiore esborso di risorse da parte dei cittadini. Chiaramente, non tutti possono permettersi di pagare di tasca propria prestazioni sanitarie e, quindi, accanto a una incidenza della spesa privata in sanità più alta che altrove in Europa occidentale, vi è una fetta di popolazione comparativamente più consistente, concentrata fra quella a redditi bassi e medio-bassi, che afferma di dover rinunciare ad alcune cure sanitarie per motivi di costo, distanza o liste di attesa. Infine, specificità tutta Italia, oltre che per classe sociale, i problemi di accesso e di qualità delle cure assumono un grado e una intensità differenti a seconda del territorio, con le regioni del Sud Italia in genere nettamente più svantaggiate rispetto a quelle del Centro-Nord.
Due punti importanti vanno, infine, sottolineati rispetto alle critiche che vengono indirizzate a come è stato gestito il SSN in questi ultimi decenni. Primo, realisticamente fino a pochi mesi fa pochissimi (per non dire quasi nessuno) di coloro che si occupavano di sanità pensavano che la sfida al SSN sarebbe arrivata da una epidemia (tanto meno da una pandemia). Il pensiero che si è affermato (condiviso anche dal sottoscritto) era invece quello di dover rafforzare il sistema di intervento non tanto rispetto alle acuzie (su cui molti passi avanti si sono fatti in questi decenni) quanto verso la cura delle cronicità. Negli ultimi decenni era questa l’area di bisogno socio-sanitario largamente in espansione. Quindi, la logica che ha guidato la trasformazione di molti sistemi sanitari occidentali è stata: meno posti letto per acuti in ospedale e più attività di ambulatoriale/specialistica sul territorio, più strutture socio-sanitarie residenziali (ad esempio, RSA) e più interventi domiciliari. L’Italia da questo punto di vista non è stata totalmente in grado di effettuare la transizione ed è rimasta in mezzo al guado. Si sono chiusi reparti ospedalieri e in una parte del paese (soprattutto il Centro-Sud) non si sono rafforzate adeguatamente le reti di intervento territoriali. Nel momento in cui è arrivato un fenomeno drammatico e inaspettato per quasi tutti gli esperti in sanità come il coronavirus, il nostro paese si è ritrovato con meno posti letto in ospedale, ma senza neanche una adeguata dotazione di servizi socio-sanitari residenziali e territoriali, e con un numero decrescente di medici ed infermieri, che già da un decennio stavano (sup-) portando sulle proprie spalle i tagli alla sanità. La tabella 3 serve di nuovo per contestualizzare il caso italiano in ottica comparata. Il numero di posti letto ospedalieri per acuti in Italia è relativamente contenuto ma non è molto differente da quello che avviene in molti altri paesi. Semmai, da questo punto di vista la Germania (un paese di cui si discute molto in questi giorni sui mass media) è un caso “anomalo” rispetto a tutti gli altri. Il problema è che gli altri paesi hanno investito molto più che in Italia in tutto ciò che non è acuto ospedaliero.
Tabella 3. Dotazione e caratteristiche dei posti letto nel sistema sanitario e socio-sanitario italiano (anno 2016)
| N° di posti letto per acuti negli ospedali ogni 100 mila abitanti | N° di posti letto per riabilitazione e lungodegenze negli ospedali ogni 100 mila abitanti | % anziani (non autosufficienti) ospitati in strutture residenziali extra-ospedaliere | |
| Francia | 309 | 205 | 4,0 |
| Germania | 602 | 199 | 3,8 |
| Italia | 262 | 56 | 2,0 |
| Svezia | 204 | n.d. | 6,0 |
| Regno Unito | 211 | n.d | 4,2 |
Fonte: elaborazioni da OECD Health Statistics online database (2020) (https://stats.oecd.org) e da Eurostat online database
Quest’ultima riflessione ci porta alle conclusioni del nostro ragionamento. Nell’ultimo ventennio, ed in particolare nell’ultimo decennio, indipendentemente da chi abbia governato a livello nazionale, non si è avuto un serio investimento in sanità. Anzi. Alcuni segnali in positivo sono giunti con l’ultima legge di Stabilità dello scorso dicembre. Tuttavia, vi è un problema generalizzato di scarsa attenzione alla cura e alla manutenzione della sanità pubblica. Come scrivevo alcuni mesi fa nel Policy Memo sopra citato, se si osservano in prospettiva comparata il livello (scarso) di risorse economiche investite nella sanità pubblica nell’ultimo ventennio e i buoni risultati in termini di cura e di salute ottenuti rispetto a quanto avvenuto in molti altri paesi occidentali, possiamo parlare di un ‘quasi miracolo’: riuscire ad avere una buona sanità pubblica con limitate risorse. Aggiungevo in quel testo che le possibilità che il ‘quasi miracolo’ continui si stanno, però, rarefacendo, dato che si basavano sul super-sfruttamento della professionalità, etica e disponibilità di chi opera in sanità e sulla capacità di spesa privata di molte famiglie. Il crescente disinvestimento nelle risorse umane stava minando la resilienza del personale in sanità, crescentemente oberato di incarichi. Tutto ciò avveniva prima dell’emergenza Coronavirus...
La ricetta quasi banale che si proponeva in quella sede era: la sanità pubblica italiana ha semplicemente bisogno di più risorse finanziarie. Il SSN è migliorabile, ma ha già raggiunto un buon, se non ottimo livello, di performance gestionale e professionale. Non sono necessari chissà quali interventi di ingegneria istituzionale o manageriale per mantenere il SSN a livelli adeguati: bastano più soldi per investimenti in assunzioni e per il personale (a partire da più borse di studio per gli specializzandi nelle discipline mediche), oltre che in manutenzione/ampliamento di servizi e strutture. Indubbiamente la capacità di azione del SSN è migliore al Centro-Nord Italia rispetto al Sud, dove ancora c’è molto da fare in termini di efficientamento e appropriatezza degli interventi pubblici. Tuttavia, il tema della spesa resta centrale e ritengo opportuno concludere queste riflessioni con una domanda: come mai la politica in questi anni ha prestato attenzione a tanti temi importanti, relativi alla protezione sociale delle persone, aumentando considerevolmente la spesa pubblica in un periodo di austerity (dalle pensioni con “Quota 100” al Reddito di Cittadinanza nel campo del contrasto alla povertà per fare i due esempi più recenti) ma ha trascurato la sanità (e si dovrebbe aggiungere, il sistema educativo e le politiche per la cura di bambini e anziani)?
Sicuramente una parte della risposta va cercata nella drammaticità della situazione italiana dell’ultimo decennio, che ha spinto l’attenzione della politica verso alcune direzioni piuttosto che altre (ad esempio, dal 2007 al 2018 i poveri relativi sono passati da circa 6 milioni a 9 milioni). Purtroppo, la sanità è rimasta indietro. Tuttavia, dato che viviamo in democrazia, occorre evitare di dare la colpa solo alla politica. In democrazia funziona un principio di competizione / collaborazione che si basa sulla domanda di interventi (politiche) da parte di cittadini, imprese e società civile e sull’offerta di interventi da parte di partiti e governi. Se la sanità non ha acquisito un ruolo importante nell’agenda dei governi dell’ultimo decennio (in realtà sarebbe più appropriato riferirsi all’ultimo ventennio) è stato sicuramente per miopia della politica che, anche per tante ragioni comprensibili si è data altre priorità, ma anche per scarsa attenzione di cittadini, imprese e società civile, anche essi (noi) abbastanza miopi da non mettere la sanità ai primi posti delle loro richieste ai partiti.
La pandemia in atto ci ricorda drammaticamente come il nostro paese non si possa permettere di continuare la tendenza dell’ultimo ventennio. Tutto ciò richiede sicuramente una classe politica adeguata (decenni fa, prima dell’ondata del neopopulismo approssimativo e da tastiera degli ultimi anni, avremmo scritto che abbiamo bisogno di una ‘élite modernizzante’, utilizzando con accezione positiva i termini di ‘élite’ e “modernizzazione”), ma anche una società civile che si mobilita concretamente e mette il rilancio ed il sostegno alla sanità pubblica (unitamente all’istruzione e al sostegno alle attività di cura delle famiglie) al centro delle domande di tutela fatte alla politica.
Se dopo la fine della crisi pandemica attuale la società civile e i cittadini non si organizzeranno e non chiederanno maggiore attenzione alla sanità, limitandosi a ringraziare gli eroi della sanità, che stanno pagando un prezzo altissimo in termini di salute, il dramma che stiamo attraversando in questo periodo non ci avrà insegnato a sufficienza quali sono le priorità a cui dobbiamo guardare come paese e su quali punti pretendere prioritariamente risposte adeguate dalla classe politica e dalle istituzioni.
Fonte
Gran Bretagna - Il sindacato della sanità inchioda Johnson alle sue responsabilità
Abbiamo visto in queste settimane i problemi che sono stati causati dal coronavirus e di come non sempre la situazione viene affrontata dai governi nel migliore dei modi a causa anche della malagestione dei sistemi economici e sanitari.
Rispetto alla situazione nel Regno Unito abbiamo trovato un articolo sulla situazione degli ospedali e delle richieste che l’RFN (Royal College of Nursing, sindacato e associazione degli infermieri e degli operatori sanitari) fa al governo per garantire il minimo di condizioni di sicurezza su uno dei luoghi di lavoro maggiormente a rischio contagio
Di seguito riportiamo la traduzione dell’articolo.
Sono state fatte nuove chiamate al primo ministro per garantire una fornitura sufficiente di dispositivi di protezione individuale (DPI) per quelli in prima linea e per dare priorità agli infermieri per i test di Covid-19.
In una lettera indirizzata al numero 10 (il numero 10 di Downing Street è la residenza e la sede del Primo Ministro del Regno Unito, ndr.), il Royal College of Nursing (sindacato e associazione degli infermieri e degli operatori sanitari, ndr.) ha esortato Boris Johnson a “intervenire personalmente” e ad agire per garantire a infermieri e colleghi l’accesso a DPI sufficienti.
Il sindacato ha anche invitato il sig. Johnson ad aumentare il numero di test Covid-19 per infermieri in modo che il personale con possibili sintomi sappia se è infetto o meno.
Ciò a seguito della rivelazione secondo la quale milioni di articoli DPI erano stati consegnati al personale sanitario in tutta l’Inghilterra nei giorni precedenti.
Mentre la lettera dava atto di questo annuncio, il sindacato degli infermieri affermava che avrebbe “monitorato attentamente la situazione per assicurarsi che questi stock stessero raggiungendo i posti giusti”.
Scritta dall’amministratrice delegata e segretaria generale Dame Donna Kinnair, la lettera sottolineava la “dedizione e professionalità” del personale nel proteggere la salute e il benessere della nazione.
“Ti scrivo per esprimere le serie preoccupazioni dei nostri membri – e della più ampia forza lavoro per la salute e l’assistenza – per quanto riguarda la mancanza di DPI e test Covid-19 per il personale”, ha detto Dame Donna nella lettera.
“Durante il fine settimana, ci sono state segnalazioni crescenti di mancanza di DPI disponibili per il personale in prima linea – non solo negli ospedali, ma negli ambulatori GP, nelle case di cura e nelle infermiere della comunità che visitano le persone nelle loro case”.
Ha spiegato che gli infermieri hanno detto al sindacato che “semplicemente non potevano ottenere abbastanza attrezzature” e ha sottolineato che questo era un problema riguardante in particolare le maschere per il viso che offrivano un livello più alto di protezione respiratoria – le maschere FFP3.
“Mentre accogliamo con favore l’annuncio della distribuzione di ulteriori scorte alle strutture sanitarie, seguiremo da vicino la situazione per assicurarci che queste scorte raggiungano i posti giusti”, ha affermato Dame Donna.
Inoltre, la lettera parla dei test del coronavirus per il personale in prima linea.
Dame Donna ha sottolineato che “i test prioritari Covid-19 per gli operatori sanitari e per gli assistenti sociali sono un dovere assoluto”.
“I nostri membri hanno bisogno di questo per fare il loro lavoro mantenendo sé stessi e i loro pazienti, al sicuro”, ha scritto.
La scorsa settimana il governo si è impegnato a dare la priorità ai test del personale sanitario in prima linea in Inghilterra per Covid-19 non appena avesse avuto la capacità di farlo.
La Public Health England (un’agenzia esecutiva del Dipartimento della sanità e dell’assistenza sociale nel Regno Unito, ndr.) è stata incaricata di stabilire “test mirati per il personale” per i principali lavoratori del NHS (il sistema sanitario inglese, ndr.) con sintomi di coronavirus che altrimenti avrebbero bisogno di autoisolarsi.
Concludendo la lettera, Dame Donna ha dichiarato: “Il personale infermieristico in tutto il paese sta affrontando la sfida di questa situazione senza precedenti”.
“I nostri membri stanno tornando dalla pensione, gli studenti stanno interrompendo gli studi e il personale infermieristico si sta schierando da contesti non clinici, tutti per supportare la prima linea nella battaglia contro COVID-19”.
“Vi chiediamo di intervenire personalmente e di agire per garantire una fornitura sufficiente di DPI e test per COVID-19 disponibili per tutto il personale infermieristico e i nostri colleghi attraverso il sistema sanitario e assistenziale”.
Fonte
Rispetto alla situazione nel Regno Unito abbiamo trovato un articolo sulla situazione degli ospedali e delle richieste che l’RFN (Royal College of Nursing, sindacato e associazione degli infermieri e degli operatori sanitari) fa al governo per garantire il minimo di condizioni di sicurezza su uno dei luoghi di lavoro maggiormente a rischio contagio
Di seguito riportiamo la traduzione dell’articolo.
*****
Sono state fatte nuove chiamate al primo ministro per garantire una fornitura sufficiente di dispositivi di protezione individuale (DPI) per quelli in prima linea e per dare priorità agli infermieri per i test di Covid-19.
In una lettera indirizzata al numero 10 (il numero 10 di Downing Street è la residenza e la sede del Primo Ministro del Regno Unito, ndr.), il Royal College of Nursing (sindacato e associazione degli infermieri e degli operatori sanitari, ndr.) ha esortato Boris Johnson a “intervenire personalmente” e ad agire per garantire a infermieri e colleghi l’accesso a DPI sufficienti.
Il sindacato ha anche invitato il sig. Johnson ad aumentare il numero di test Covid-19 per infermieri in modo che il personale con possibili sintomi sappia se è infetto o meno.
Ciò a seguito della rivelazione secondo la quale milioni di articoli DPI erano stati consegnati al personale sanitario in tutta l’Inghilterra nei giorni precedenti.
Mentre la lettera dava atto di questo annuncio, il sindacato degli infermieri affermava che avrebbe “monitorato attentamente la situazione per assicurarsi che questi stock stessero raggiungendo i posti giusti”.
Scritta dall’amministratrice delegata e segretaria generale Dame Donna Kinnair, la lettera sottolineava la “dedizione e professionalità” del personale nel proteggere la salute e il benessere della nazione.
“Ti scrivo per esprimere le serie preoccupazioni dei nostri membri – e della più ampia forza lavoro per la salute e l’assistenza – per quanto riguarda la mancanza di DPI e test Covid-19 per il personale”, ha detto Dame Donna nella lettera.
“Durante il fine settimana, ci sono state segnalazioni crescenti di mancanza di DPI disponibili per il personale in prima linea – non solo negli ospedali, ma negli ambulatori GP, nelle case di cura e nelle infermiere della comunità che visitano le persone nelle loro case”.
Ha spiegato che gli infermieri hanno detto al sindacato che “semplicemente non potevano ottenere abbastanza attrezzature” e ha sottolineato che questo era un problema riguardante in particolare le maschere per il viso che offrivano un livello più alto di protezione respiratoria – le maschere FFP3.
“Mentre accogliamo con favore l’annuncio della distribuzione di ulteriori scorte alle strutture sanitarie, seguiremo da vicino la situazione per assicurarci che queste scorte raggiungano i posti giusti”, ha affermato Dame Donna.
Inoltre, la lettera parla dei test del coronavirus per il personale in prima linea.
Dame Donna ha sottolineato che “i test prioritari Covid-19 per gli operatori sanitari e per gli assistenti sociali sono un dovere assoluto”.
“I nostri membri hanno bisogno di questo per fare il loro lavoro mantenendo sé stessi e i loro pazienti, al sicuro”, ha scritto.
La scorsa settimana il governo si è impegnato a dare la priorità ai test del personale sanitario in prima linea in Inghilterra per Covid-19 non appena avesse avuto la capacità di farlo.
La Public Health England (un’agenzia esecutiva del Dipartimento della sanità e dell’assistenza sociale nel Regno Unito, ndr.) è stata incaricata di stabilire “test mirati per il personale” per i principali lavoratori del NHS (il sistema sanitario inglese, ndr.) con sintomi di coronavirus che altrimenti avrebbero bisogno di autoisolarsi.
Concludendo la lettera, Dame Donna ha dichiarato: “Il personale infermieristico in tutto il paese sta affrontando la sfida di questa situazione senza precedenti”.
“I nostri membri stanno tornando dalla pensione, gli studenti stanno interrompendo gli studi e il personale infermieristico si sta schierando da contesti non clinici, tutti per supportare la prima linea nella battaglia contro COVID-19”.
“Vi chiediamo di intervenire personalmente e di agire per garantire una fornitura sufficiente di DPI e test per COVID-19 disponibili per tutto il personale infermieristico e i nostri colleghi attraverso il sistema sanitario e assistenziale”.
Fonte
USA - Morto infermiere a New York, si lavora senza protezioni
Dal New York Times, pubblichiamo questo articolo di Somini Sengupta che denuncia la drammatica condizione degli infermieri di New York, dove la sanità è ben oltre la crisi, dove i dispositivi di sicurezza non vengono forniti adeguatamente, e dove il sistema sanitario privatizzato si sta dimostrando non solo inefficace, ma estremamente pericoloso per tutti, clienti e lavoratori.
Somini Sengupta da: https://nyti.ms/2UCG7RT
“Sto bene, non dirlo a mamma e papà. Si preoccuperebbero”, scriveva a sua sorella. Potrebbe essere il primo infermiere di New York a morire a causa del coronavirus.
Kious Kelly, un infermiere nell’ospedale di Manhattan, ha scritto a sua sorella il 18 marzo dandole delle notizie devastanti: era risultato positivo al test per il coronavirus ed era attaccato ad un respiratore nel reparto di terapia intensiva. Le ha detto di poterle scrivere, ma non parlare.
“Sto bene. Non dirlo a mamma e papà. Si preoccuperebbero”, ha scritto a sua sorella, Marya Patrice Sherron.
È stato questo il suo ultimo messaggio.
Al messaggio successivo della sorella non c’è stata nessuna risposta. In meno di una settimana era morto.
Kious Kelly, infermiere quarantottenne al Mount Sinai West, potrebbe essere il primo infermiere a New York ad essere morto di Coronavirus.
Sua sorella ha detto che Kious soffriva d’asma, ma per il resto stava bene.
“La sua morte poteva essere evitata”, scrive la sorella in un post di mercoledì su facebook. Dopo ha aggiunto “Sono furiosa. Lui stava bene”.
L’ira c’è anche tra i colleghi di Kious in ospedale. Qualcuno si è lamentato tramite i social media che non avevano un numero sufficiente di mascherine e dispositivi di protezione.
Un’infermiera che lavorava con il quarantottene ha detto che l'ospedale aveva fornito agli infermieri un solo camice protettivo in plastica per un intero turno, mentre il normale protocollo richiede un cambio di camice ad ogni interazione con i pazienti infetti.
L’infermiera, che ha parlato sotto anonimato in quanto l’ospedale non consentiva ai dipendenti di lasciare dichiarazioni alla stampa, ha affermato che Kious non aveva dispositivi di sicurezza, anche se aiutava i colleghi del suo team con le cure pratiche.
Appena il 10 marzo aveva aiutato un’infermiera a togliersi i suoi dispositivi di protezione dopo aver lavorato con un paziente che era risultato positivo al virus, ha detto l’intervistata.
Numerosi dipendenti del Mount Sinai West, contattati a proposito della vicenda, hanno detto che gli era stato comunicato dall'amministrazione della struttura sanitaria di non parlare con i giornalisti.
La morte di Kious Kelly è stata inizialmente riportata sul New York Post.
Gia Lisa Krahne, una consulente esterna che forniva cure aiurvediche ad un paziente del Mount Sinai West, ha detto di aver visto per l’ultima volta Kious Kelly la settimana del 9 marzo, ed interagiva regolarmente con i pazienti e lo staff ospedaliero, ma non indossava né una mascherina né un camice protettivo.
Bevon Bloise, infermiera al Mount Sinai West, si è lamentata su facebook che l’ospedale non aveva abbastanza dispositivi di protezione personale.
“Sono molto arrabbiata con il sistema sanitario del MSW per non averlo protetto. Non abbiamo abbastanza dispositivi di protezione, non abbiamo quelli giusti, e non c’è il personale adeguato per affrontare questa pandemia. E non apprezzo i rappresentanti di questo sistema sanitario che dicono il contrario sulla notizia.”
“Abbiamo perso un gran combattente in questa battaglia”, ha scritto una collega, Diana Torres, su facebook. Ha postato una foto di alcuni colleghi con una bandana sulla faccia usata per proteggersi. “NO, QUESTI NON SONO I DISPOSITIVI GIUSTI”, ha scritto.
Sulla sua pagina Facebook, l’ospedale MSW ha detto di essere “profondamente dispiaciuto per la perdita di un amato membro del nostro staff sanitario”, senza nominare Kious Kelly.
In una mail, la portavoce della struttura ospedaliera, Lucia Lee, ha contestato l’affermazione secondo cui l’ospedale non aveva fornito attrezzature di protezione al suo personale. “Questa crisi sta mettendo a dura prova le risorse di tutti gli ospedali di New York, mentre abbiamo – e abbiamo avuto – attrezzature di protezione sufficienti per il nostro personale, avremo tutti bisogno di un numero maggiore nelle prossime settimane,” ha detto Lee nella dichiarazione.
L’articolo del New York Post includeva una foto dello staff ospedaliero che indossava della spazzatura sopra quelli che sembravano essere camici.
Due infermiere, che hanno parlato solo a condizione dell’anonimato per paura di essere licenziate, hanno detto che erano camici monouso con un tessuto permeabile, per questo gli infermieri avevano dovuto coprirli con dei sacchi dell’immondizia.
La foto, hanno detto, è stata fatta il 17 marzo, in un momento in cui c’erano molti pazienti affetti da coronavirus nella struttura ed altri che dovevano ancora essere sottoposti al test ma presentavano i sintomi.
Nella dichiarazione, la Lee ha aggiunto che “la foto che circola sul web mostra infermieri con dispositivi appropriati sotto i sacchi della spazzatura”.
Ma non ha risposto alla domanda che chiedeva di spiegare perché lo staff sanitario indossava sacchi della spazzatura.
Kious Kelly viveva a qualche isolato dall’ospedale, ed è descritto dai collegi come un uomo appassionato al proprio lavoro.
“Portava con sé sempre un portablocco in cui teneva cioccolate e caramelle in modo da averle sottomano per i colleghi imbronciati”, ha scritto Joanne Loe, infermiera del Mount Sinai West, mercoledì su facebook.
Ma fare l’infermiere non era la sua prima vocazione. Nato a Lansing, nel Michigan, si era trasferito a New York più di 20 anni fa per intraprendere la carriera di ballerino, ha detto la sorella. Ha poi studiato infermieristica e ha lavorato come infermiere al Mount Sinai West, per poi essere promosso al ruolo di assistente-manager nel reparto di telemetria.
La sua famiglia sta provando a riportare la salma in Michigan.
“Sappiamo che non succederà a breve, ma lo vogliamo a casa. È morto da solo. Adesso lo vogliamo a casa.”
Fonte
*****
Somini Sengupta da: https://nyti.ms/2UCG7RT
“Sto bene, non dirlo a mamma e papà. Si preoccuperebbero”, scriveva a sua sorella. Potrebbe essere il primo infermiere di New York a morire a causa del coronavirus.
Kious Kelly, un infermiere nell’ospedale di Manhattan, ha scritto a sua sorella il 18 marzo dandole delle notizie devastanti: era risultato positivo al test per il coronavirus ed era attaccato ad un respiratore nel reparto di terapia intensiva. Le ha detto di poterle scrivere, ma non parlare.
“Sto bene. Non dirlo a mamma e papà. Si preoccuperebbero”, ha scritto a sua sorella, Marya Patrice Sherron.
È stato questo il suo ultimo messaggio.
Al messaggio successivo della sorella non c’è stata nessuna risposta. In meno di una settimana era morto.
Kious Kelly, infermiere quarantottenne al Mount Sinai West, potrebbe essere il primo infermiere a New York ad essere morto di Coronavirus.
Sua sorella ha detto che Kious soffriva d’asma, ma per il resto stava bene.
“La sua morte poteva essere evitata”, scrive la sorella in un post di mercoledì su facebook. Dopo ha aggiunto “Sono furiosa. Lui stava bene”.
L’ira c’è anche tra i colleghi di Kious in ospedale. Qualcuno si è lamentato tramite i social media che non avevano un numero sufficiente di mascherine e dispositivi di protezione.
Un’infermiera che lavorava con il quarantottene ha detto che l'ospedale aveva fornito agli infermieri un solo camice protettivo in plastica per un intero turno, mentre il normale protocollo richiede un cambio di camice ad ogni interazione con i pazienti infetti.
L’infermiera, che ha parlato sotto anonimato in quanto l’ospedale non consentiva ai dipendenti di lasciare dichiarazioni alla stampa, ha affermato che Kious non aveva dispositivi di sicurezza, anche se aiutava i colleghi del suo team con le cure pratiche.
Appena il 10 marzo aveva aiutato un’infermiera a togliersi i suoi dispositivi di protezione dopo aver lavorato con un paziente che era risultato positivo al virus, ha detto l’intervistata.
Numerosi dipendenti del Mount Sinai West, contattati a proposito della vicenda, hanno detto che gli era stato comunicato dall'amministrazione della struttura sanitaria di non parlare con i giornalisti.
La morte di Kious Kelly è stata inizialmente riportata sul New York Post.
Gia Lisa Krahne, una consulente esterna che forniva cure aiurvediche ad un paziente del Mount Sinai West, ha detto di aver visto per l’ultima volta Kious Kelly la settimana del 9 marzo, ed interagiva regolarmente con i pazienti e lo staff ospedaliero, ma non indossava né una mascherina né un camice protettivo.
Bevon Bloise, infermiera al Mount Sinai West, si è lamentata su facebook che l’ospedale non aveva abbastanza dispositivi di protezione personale.
“Sono molto arrabbiata con il sistema sanitario del MSW per non averlo protetto. Non abbiamo abbastanza dispositivi di protezione, non abbiamo quelli giusti, e non c’è il personale adeguato per affrontare questa pandemia. E non apprezzo i rappresentanti di questo sistema sanitario che dicono il contrario sulla notizia.”
“Abbiamo perso un gran combattente in questa battaglia”, ha scritto una collega, Diana Torres, su facebook. Ha postato una foto di alcuni colleghi con una bandana sulla faccia usata per proteggersi. “NO, QUESTI NON SONO I DISPOSITIVI GIUSTI”, ha scritto.
Sulla sua pagina Facebook, l’ospedale MSW ha detto di essere “profondamente dispiaciuto per la perdita di un amato membro del nostro staff sanitario”, senza nominare Kious Kelly.
In una mail, la portavoce della struttura ospedaliera, Lucia Lee, ha contestato l’affermazione secondo cui l’ospedale non aveva fornito attrezzature di protezione al suo personale. “Questa crisi sta mettendo a dura prova le risorse di tutti gli ospedali di New York, mentre abbiamo – e abbiamo avuto – attrezzature di protezione sufficienti per il nostro personale, avremo tutti bisogno di un numero maggiore nelle prossime settimane,” ha detto Lee nella dichiarazione.
L’articolo del New York Post includeva una foto dello staff ospedaliero che indossava della spazzatura sopra quelli che sembravano essere camici.
Due infermiere, che hanno parlato solo a condizione dell’anonimato per paura di essere licenziate, hanno detto che erano camici monouso con un tessuto permeabile, per questo gli infermieri avevano dovuto coprirli con dei sacchi dell’immondizia.
La foto, hanno detto, è stata fatta il 17 marzo, in un momento in cui c’erano molti pazienti affetti da coronavirus nella struttura ed altri che dovevano ancora essere sottoposti al test ma presentavano i sintomi.
Nella dichiarazione, la Lee ha aggiunto che “la foto che circola sul web mostra infermieri con dispositivi appropriati sotto i sacchi della spazzatura”.
Ma non ha risposto alla domanda che chiedeva di spiegare perché lo staff sanitario indossava sacchi della spazzatura.
Kious Kelly viveva a qualche isolato dall’ospedale, ed è descritto dai collegi come un uomo appassionato al proprio lavoro.
“Portava con sé sempre un portablocco in cui teneva cioccolate e caramelle in modo da averle sottomano per i colleghi imbronciati”, ha scritto Joanne Loe, infermiera del Mount Sinai West, mercoledì su facebook.
Ma fare l’infermiere non era la sua prima vocazione. Nato a Lansing, nel Michigan, si era trasferito a New York più di 20 anni fa per intraprendere la carriera di ballerino, ha detto la sorella. Ha poi studiato infermieristica e ha lavorato come infermiere al Mount Sinai West, per poi essere promosso al ruolo di assistente-manager nel reparto di telemetria.
La sua famiglia sta provando a riportare la salma in Michigan.
“Sappiamo che non succederà a breve, ma lo vogliamo a casa. È morto da solo. Adesso lo vogliamo a casa.”
Fonte
Spagna - Produzione in “letargo”, ma la misura non convince
Da oggi il Regno di Spagna implementa un altro tassello del famigerato “modello Italia” che tanti disastri sta provocando nel nostro paese: stiamo parlando della chiusura di tutte le attività non essenziali proclamata in un discorso alla nazione dal premier socialista Pedro Sanchez sabato sera, e confermata nella terza videoconferenza coi presidenti delle regioni autonome tenutasi ieri mattina.
Abbiamo fatto appositamente riferimento al nostro paese perché anche nella penisola iberica la decisione arriva con estremo ritardo rispetto alla dinamica dell’espansione del coronavirus, è osteggiata dalle rappresentanze datoriali e conservatrici e lascia in realtà un ampio numero di lavoratori al proprio posto. Ma andiamo con ordine.
María Jesús Montero, ministro delle Finanze dell’esecutivo Psoe-Podemos, ha definito la manovra del governo come un «aiuto al sistema produttivo per entrare in una sorta di letargo» fino alla fine della pandemia. L’esecutivo aveva cercato di evitare questa misura, definita da Sanchez come di «straordinaria durezza», mentre era richiesta con sempre maggiore insistente da una molteplicità di voce nel paese, dagli ambienti medici a quelli indipendentisti della sinistra basca, catalana e galiziana.
Evidentemente l’escalation di decessi e le crescenti pressioni hanno avuto la meglio, nonostante il portavoce del ministro abbia respinto le critiche secondo cui la decisione sia stata presa solo a seguito dei sempre peggiori dati sul contagio. «Non c’è stata alcuna situazione di allarme aggiuntiva sollevata dagli esperti», ha dichiarato, ma è difficile crederlo, anche solo dando uno sguardo al dibattito in corso nel paese.
La misura infatti viene accompagna da un nugolo di polemiche, in particolar modo per le tempistiche con cui è avvenuta. Al momento in cui scriviamo infatti, il Regno soffre di quasi 79mila contagi ufficiali, 6.528 decessi e poco meno di 15mila dimessi, concentrati soprattutto nella Comunità autonoma di Madrid.
Ma i dati già drammatici di per sé non raccontano che una parte della verità, perché al numero dei contagiati certamente inferiori rispetto a quello effettivo – mancanza di tamponi, di personale necessario a un eventuale copertura massiva di test sul territorio e “occorrenza politica” nel non ingrassare troppo il numero degli effettivi – si sommano i numerosi malati lasciati al loro destino nelle rispettive abitazioni e nelle case di riposo (tema che sta salendo alle cronache anche in Italia).
Tuttavia l’azione del governo non scontenta solo chi pone la salute della collettività davanti alle necessità della produzione, ma anche, da una parte, chi porta avanti gli interessi opposti, come la Ceoe (la Confindustria spagnola) che ha dichiarato che «le nuove misure impediranno di gettare le basi della necessaria ripresa economica in Spagna e porteranno, in ultima analisi, ad un aumento del tasso di disoccupazione», facendo già intendere cosa aspetterà i lavoratori.
Dall’altra, i presidenti delle varie comunità autonome, i quali da punti di vista anche opposti – Iñigo Urkullu per i Paesi Baschi, rappresentante della borghesia locale, boccia la chiusura delle industrie, mentre Quim Torra, president catalano, continua a chiedere il totale isolamento della regione – lamentano all’esecutivo la messa in disparte di qualsiasi loro richiesta in nome di una omogeneizzazione delle autonomie in considerazione del fatto che, parole del premier, «non ha senso fare differenze, il virus non capisce i confini, non è il momento della divisione».
Tutti scontenti insomma, con Sanchez, seguito qui a ruota anche da Podemos, che non perde occasione nel richiamare ai suoi “doveri comunitari” quell’Unione europea che nell’ultimo vertice di premier e presidenti ha conosciuto una spaccatura interna mai così profonda. Un segnale di debolezza, s’intende, così come quello di alcuni giorni fa di chieder supporto alla Nato per la fornitura di materiale medico. Ue e alleanza atlantica, non proprio le due istituzioni su cui ci sentiremmo di scommettere in questo preciso momento storico...
Ma cosa prevede la nuova misura? Il Decreto reale che ha imposto lo stato di emergenza elencava già una serie di attività che potevano rimanere operative, come la vendita al dettaglio di prodotti alimentari, bevande, prodotti e generi di prima necessità, prodotti farmaceutici, medici, ottici, ortopedici e prodotti per l’igiene, stampa e cancelleria, carburanti per autotrazione, tabaccherie, attrezzature tecnologiche e per telecomunicazioni, alimenti per animali domestici, commercio via internet, telefono o per corrispondenza, lavaggio a secco e lavanderia.
A queste vanno aggiunte i settori che impiegano i lavoratori della catena di fornitura del mercato e la gestione dei servizi nei centri di produzione di beni di prima necessità, delle aziende che devono garantire la manutenzione dei mezzi di trasporto, forze armate, le forze di sicurezza e i lavoratori delle società di sicurezza private, delle agenzie per il lavoro, dei centri sanitari e dei centri per l’assistenza agli anziani e alle persone non autosufficienti, che forniscono servizi nei media pubblici e privati, dei servizi finanziari ad eccezione di quelli assicurativi, dei servizi relativi alla protezione e alla cura delle vittime di violenza di genere.
E ancora, coloro che forniscono servizi in attività essenziali per la gestione di benefici pubblici, che prestano servizi in agenzie di gestione, società di consulenza, studi professionali, servizi di prevenzione dei rischi esterni e propri e, in generale, quelli dedicati all’attività di consulenza aziendale e agli addetti delle pulizie che operano in società di servizi essenziali. Questo senza contare tutti i lavoratori e le lavoratrici già impiegati tramite telelavoro.
Le società che operano per fornire questi servizi sono le uniche che potranno continuare a operare fino al 9 aprile. Per gli altri, il ministro del Lavoro Yolanda Díaz ha spiegato che durante questi giorni si applicherà un «congedo retribuito», misura che si affianca all’“Erte” (Expediente de Regulacion Temporal de Empleo, sorta di “Cassa integrazione” del Regno), con cui i lavoratori continueranno a ricevere normalmente il loro stipendio. «Quando tutto questo sarà finito – ha detto il ministro – le aziende e i lavoratori negozieranno per recuperare questi giorni non lavorati in modo flessibile entro il 31 dicembre 2020».
Insomma, di “fermo” c'è ben poco, così come nel nostro paese sono ancora 12 milioni i lavoratori e lavoratrici alle prese tutt’oggi con un impiego consentito. Inoltre, come denuncia la Cup, la possibilità di negoziare il recupero di queste ore pone un nuovo strumento in mano alle imprese per utilizzare in maniera flessibile, ossia secondo le necessità del datore di lavoro, la forza-lavoro non appena la situazione lo permetterà (o magari anche un po’ prima). «Non sono vacanze forzate», sottolinea il ministro, ma il fatto che non lo siano non significa che la situazione sia rosea, tutt’altro.
La Pasqua si avvicina, il picco di contagi con tutto quel che di drammatico si porta dietro – ospedali al collasso, aumenti delle vittime, scarsità di materiali, dolore per la popolazione – anche. Le suddette misure aiuteranno ben poco gli abitanti delle comunità autonome della penisola, lo stiamo sperimentando in Italia, non sarà diverso nel Regno.
Per ora, oltre la tragedia umanitaria e la confusione in cui è piombato l’esecutivo, ben poco.
Fonte
Abbiamo fatto appositamente riferimento al nostro paese perché anche nella penisola iberica la decisione arriva con estremo ritardo rispetto alla dinamica dell’espansione del coronavirus, è osteggiata dalle rappresentanze datoriali e conservatrici e lascia in realtà un ampio numero di lavoratori al proprio posto. Ma andiamo con ordine.
María Jesús Montero, ministro delle Finanze dell’esecutivo Psoe-Podemos, ha definito la manovra del governo come un «aiuto al sistema produttivo per entrare in una sorta di letargo» fino alla fine della pandemia. L’esecutivo aveva cercato di evitare questa misura, definita da Sanchez come di «straordinaria durezza», mentre era richiesta con sempre maggiore insistente da una molteplicità di voce nel paese, dagli ambienti medici a quelli indipendentisti della sinistra basca, catalana e galiziana.
Evidentemente l’escalation di decessi e le crescenti pressioni hanno avuto la meglio, nonostante il portavoce del ministro abbia respinto le critiche secondo cui la decisione sia stata presa solo a seguito dei sempre peggiori dati sul contagio. «Non c’è stata alcuna situazione di allarme aggiuntiva sollevata dagli esperti», ha dichiarato, ma è difficile crederlo, anche solo dando uno sguardo al dibattito in corso nel paese.
La misura infatti viene accompagna da un nugolo di polemiche, in particolar modo per le tempistiche con cui è avvenuta. Al momento in cui scriviamo infatti, il Regno soffre di quasi 79mila contagi ufficiali, 6.528 decessi e poco meno di 15mila dimessi, concentrati soprattutto nella Comunità autonoma di Madrid.
Ma i dati già drammatici di per sé non raccontano che una parte della verità, perché al numero dei contagiati certamente inferiori rispetto a quello effettivo – mancanza di tamponi, di personale necessario a un eventuale copertura massiva di test sul territorio e “occorrenza politica” nel non ingrassare troppo il numero degli effettivi – si sommano i numerosi malati lasciati al loro destino nelle rispettive abitazioni e nelle case di riposo (tema che sta salendo alle cronache anche in Italia).
Tuttavia l’azione del governo non scontenta solo chi pone la salute della collettività davanti alle necessità della produzione, ma anche, da una parte, chi porta avanti gli interessi opposti, come la Ceoe (la Confindustria spagnola) che ha dichiarato che «le nuove misure impediranno di gettare le basi della necessaria ripresa economica in Spagna e porteranno, in ultima analisi, ad un aumento del tasso di disoccupazione», facendo già intendere cosa aspetterà i lavoratori.
Dall’altra, i presidenti delle varie comunità autonome, i quali da punti di vista anche opposti – Iñigo Urkullu per i Paesi Baschi, rappresentante della borghesia locale, boccia la chiusura delle industrie, mentre Quim Torra, president catalano, continua a chiedere il totale isolamento della regione – lamentano all’esecutivo la messa in disparte di qualsiasi loro richiesta in nome di una omogeneizzazione delle autonomie in considerazione del fatto che, parole del premier, «non ha senso fare differenze, il virus non capisce i confini, non è il momento della divisione».
Tutti scontenti insomma, con Sanchez, seguito qui a ruota anche da Podemos, che non perde occasione nel richiamare ai suoi “doveri comunitari” quell’Unione europea che nell’ultimo vertice di premier e presidenti ha conosciuto una spaccatura interna mai così profonda. Un segnale di debolezza, s’intende, così come quello di alcuni giorni fa di chieder supporto alla Nato per la fornitura di materiale medico. Ue e alleanza atlantica, non proprio le due istituzioni su cui ci sentiremmo di scommettere in questo preciso momento storico...
Ma cosa prevede la nuova misura? Il Decreto reale che ha imposto lo stato di emergenza elencava già una serie di attività che potevano rimanere operative, come la vendita al dettaglio di prodotti alimentari, bevande, prodotti e generi di prima necessità, prodotti farmaceutici, medici, ottici, ortopedici e prodotti per l’igiene, stampa e cancelleria, carburanti per autotrazione, tabaccherie, attrezzature tecnologiche e per telecomunicazioni, alimenti per animali domestici, commercio via internet, telefono o per corrispondenza, lavaggio a secco e lavanderia.
A queste vanno aggiunte i settori che impiegano i lavoratori della catena di fornitura del mercato e la gestione dei servizi nei centri di produzione di beni di prima necessità, delle aziende che devono garantire la manutenzione dei mezzi di trasporto, forze armate, le forze di sicurezza e i lavoratori delle società di sicurezza private, delle agenzie per il lavoro, dei centri sanitari e dei centri per l’assistenza agli anziani e alle persone non autosufficienti, che forniscono servizi nei media pubblici e privati, dei servizi finanziari ad eccezione di quelli assicurativi, dei servizi relativi alla protezione e alla cura delle vittime di violenza di genere.
E ancora, coloro che forniscono servizi in attività essenziali per la gestione di benefici pubblici, che prestano servizi in agenzie di gestione, società di consulenza, studi professionali, servizi di prevenzione dei rischi esterni e propri e, in generale, quelli dedicati all’attività di consulenza aziendale e agli addetti delle pulizie che operano in società di servizi essenziali. Questo senza contare tutti i lavoratori e le lavoratrici già impiegati tramite telelavoro.
Le società che operano per fornire questi servizi sono le uniche che potranno continuare a operare fino al 9 aprile. Per gli altri, il ministro del Lavoro Yolanda Díaz ha spiegato che durante questi giorni si applicherà un «congedo retribuito», misura che si affianca all’“Erte” (Expediente de Regulacion Temporal de Empleo, sorta di “Cassa integrazione” del Regno), con cui i lavoratori continueranno a ricevere normalmente il loro stipendio. «Quando tutto questo sarà finito – ha detto il ministro – le aziende e i lavoratori negozieranno per recuperare questi giorni non lavorati in modo flessibile entro il 31 dicembre 2020».
Insomma, di “fermo” c'è ben poco, così come nel nostro paese sono ancora 12 milioni i lavoratori e lavoratrici alle prese tutt’oggi con un impiego consentito. Inoltre, come denuncia la Cup, la possibilità di negoziare il recupero di queste ore pone un nuovo strumento in mano alle imprese per utilizzare in maniera flessibile, ossia secondo le necessità del datore di lavoro, la forza-lavoro non appena la situazione lo permetterà (o magari anche un po’ prima). «Non sono vacanze forzate», sottolinea il ministro, ma il fatto che non lo siano non significa che la situazione sia rosea, tutt’altro.
La Pasqua si avvicina, il picco di contagi con tutto quel che di drammatico si porta dietro – ospedali al collasso, aumenti delle vittime, scarsità di materiali, dolore per la popolazione – anche. Le suddette misure aiuteranno ben poco gli abitanti delle comunità autonome della penisola, lo stiamo sperimentando in Italia, non sarà diverso nel Regno.
Per ora, oltre la tragedia umanitaria e la confusione in cui è piombato l’esecutivo, ben poco.
Fonte
Mentre si muore, i padroni ordinano di “riaprire”
Come un solo uomo, dietro Repubblica e IlSole24Ore, i grandi media italiani, con le tv ovviamente al seguito, hanno aperto la campagna “riprendiamo le attività produttive”.
Non sono passati neanche due giorni dall’editoriale con cui il direttore, Carlo Verdelli, chiedeva di dichiarare tutta Lombardia “zona rossa”, con le conseguenze logiche sul piano del fermo produttivo. Stamattina Repubblica titola invece “A casa fino a dopo Pasqua” nell’edizione cartacea, e “Quando riaprire? Parte da fabbriche e cantieri il piano per riaccendere il Paese già entro aprile” su quella online.
Il giornale di casa Agnelli – questo ora è – detta la linea confindustriale: finita o no l’epidemica bisogna riaprire anche quelle poche fabbriche che erano state bloccate perché producono beni “non essenziali”.
Stessa linea per il Corriere della Sera (gruppo Cairo-Rcs), che sempre sull’online dà grande evidenza a un’intervista del quotidiano spagnolo El Pais a Giuseppe Conte: «La serrata delle attività produttive non può durare troppo, ma riapertura sarà graduale».
Potremmo andare avanti a lungo, la lista è lunga e monotona. Dicono tutti la stessa cosa. Che, nella pratica, è questa: si deve lavorare anche se l’epidemia è in questo momento al suo massimo e non si vede assolutamente quando possa almeno rallentare, se non proprio finire.
Abbiamo dunque un doppio binario che solo le ragioni del profitto a tutti i costi possono spiegare, a rischio di una strage di proporzioni bibliche (siamo già oltre i 100.000 contagiati e gli 11.000 morti “ufficiali”, e tutti dicono che questi numeri sono solo una frazione della platea reale).
Da un lato c’è il coprifuoco per chi esce di casa senza un “valido motivo”, fosse anche in completa solitudine. Dall’altra si pretende di continuare a stipare negli autobus e sui treni, oltre che nelle fabbriche, milioni di persone (lavoratori con ogni tipo di contratto).
Ma di quale “distanziamento” stanno parlando?
È assolutamente evidente che la continua circolazione di milioni di persone è in totale contraddizione con la possibilità di “confinare” la diffusione del virus e con le stesse sanzioni abnormi che, giorno dopo giorno, governo e presidenti di Regione emanano.
Ed è altrettanto evidente che Confindustria ha totalmente in mano il governo, e gli ordina di fare il contrario di quanto sarebbe sanitariamente logico perseguire.
È la stessa situazione che ha prodotto il disastro nazionale quando bisognava “chiudere” la Val Seriana (Alzano, Nembro, ecc.) come era stato fatto con Codgno e altri comuni “focolaio”. Per evitarlo, su pressing confindustriale e leghista (e del Pd), l’8 marzo si inventò una “zona arancione” così larga da rendere impossibile qualsiasi chiusura. Salvo poi prendersela – anche giustamente – con quanti “scapparono” dalla Lombardia e altre 14 province nella notte stessa e nei giorni successivi, diffondendo il contagio in altre Regioni fin lì quasi esenti.
È l’antico, infame, modo di governare “all’italiana”: creare o far marcire i problemi, e poi colpevolizzare la popolazione.
I media ora si dilettano in ipotesi sul “cosa” riaprire prima (i negozi di abbigliamento piuttosto che i bar, le cartolerie piuttosto che i ristoranti e a maggior ragion le discoteche, ecc.). E fantasie sul “come” applicare regole di distanziamento in spazi limitati, senza alcun pensiero per i trasporti pubblici o privati... con altri milioni di lavoratori obbligati a recarsi in “ditta” e altri milioni di “consumatori” (ad ore alterne della giornata tutti sono entrambe le cose) che ampliano man mano il proprio giro quotidiano... mentre il virus è tra noi.
Produrre è importante, lo capisce anche un deficiente.
Un paese fermo per mesi è un paese che non sopravvive anche per difficoltà nei rifornimenti, oltre che per l’epidemia. E già ora ci sono segnalazioni di speculazioni sui prezzi dei generi alimentari (come sulle mascherine e l’amuchina, nei primi giorni), al limite delle pratiche da “borsa nera” in tempi di guerra.
Ma un Paese che rinuncia a fermare l’epidemia per la fregola di un pugno di imprenditori senza scrupoli è un Paese che si auto condanna alla rovina, perché in questo modo non se ne uscirà MAI.
O comunque con perdite enormemente più alte di quelle che si vogliono in questo momento evitare.
Lo capisce anche un deficiente.
Prima di questa crisi occorreva una certa dose di cultura per comprendere a fondo questa relazione contraddittoria tra produzione capitalistica e distruzione della vita. Oggi basta affacciarsi alla finestra e rendersene conto.
Guarda caso, soltanto un paese che si definisce “socialista”, anche se “con caratteristiche cinesi”, ci sta in qualche misura riuscendo. Provate a chiedervi perché (senza stronzate sulla “dittatura”, visto che qui – in tutto l’Occidente – si dispiegano eserciti contro la propria popolazione).
Del resto, dopo il nulla di fatto dell’ultimo vertice dei primi ministri europei, e le sprezzanti dichiarazioni della presidente della Commissione Europea, Ursula Von der Leyen (“i coronabond sono solo uno slogan“, insomma: non se ne parla nemmeno), tutta la nostra “classe dirigente” ha capito che dall’Unione Europea non verrà nessuna decisione utile. Dunque scelgono la solita linea: massacriamo la nostra popolazione, qualcuno di noi (imprenditori) forse sopravviverà...
Stupisce, si fa per dire, che “esperti” sottomettano le loro conoscenze scientifiche agli interessi delle imprese. Mentre non stupisce affatto, come sempre, la classe politica (di maggioranza e di opposizione) più indecente che questo disgraziato Paese – e tutta Europa – abbia mai avuto.
Fonte
Non sono passati neanche due giorni dall’editoriale con cui il direttore, Carlo Verdelli, chiedeva di dichiarare tutta Lombardia “zona rossa”, con le conseguenze logiche sul piano del fermo produttivo. Stamattina Repubblica titola invece “A casa fino a dopo Pasqua” nell’edizione cartacea, e “Quando riaprire? Parte da fabbriche e cantieri il piano per riaccendere il Paese già entro aprile” su quella online.
Il giornale di casa Agnelli – questo ora è – detta la linea confindustriale: finita o no l’epidemica bisogna riaprire anche quelle poche fabbriche che erano state bloccate perché producono beni “non essenziali”.
Stessa linea per il Corriere della Sera (gruppo Cairo-Rcs), che sempre sull’online dà grande evidenza a un’intervista del quotidiano spagnolo El Pais a Giuseppe Conte: «La serrata delle attività produttive non può durare troppo, ma riapertura sarà graduale».
Potremmo andare avanti a lungo, la lista è lunga e monotona. Dicono tutti la stessa cosa. Che, nella pratica, è questa: si deve lavorare anche se l’epidemia è in questo momento al suo massimo e non si vede assolutamente quando possa almeno rallentare, se non proprio finire.
Abbiamo dunque un doppio binario che solo le ragioni del profitto a tutti i costi possono spiegare, a rischio di una strage di proporzioni bibliche (siamo già oltre i 100.000 contagiati e gli 11.000 morti “ufficiali”, e tutti dicono che questi numeri sono solo una frazione della platea reale).
Da un lato c’è il coprifuoco per chi esce di casa senza un “valido motivo”, fosse anche in completa solitudine. Dall’altra si pretende di continuare a stipare negli autobus e sui treni, oltre che nelle fabbriche, milioni di persone (lavoratori con ogni tipo di contratto).
Ma di quale “distanziamento” stanno parlando?
È assolutamente evidente che la continua circolazione di milioni di persone è in totale contraddizione con la possibilità di “confinare” la diffusione del virus e con le stesse sanzioni abnormi che, giorno dopo giorno, governo e presidenti di Regione emanano.
Ed è altrettanto evidente che Confindustria ha totalmente in mano il governo, e gli ordina di fare il contrario di quanto sarebbe sanitariamente logico perseguire.
È la stessa situazione che ha prodotto il disastro nazionale quando bisognava “chiudere” la Val Seriana (Alzano, Nembro, ecc.) come era stato fatto con Codgno e altri comuni “focolaio”. Per evitarlo, su pressing confindustriale e leghista (e del Pd), l’8 marzo si inventò una “zona arancione” così larga da rendere impossibile qualsiasi chiusura. Salvo poi prendersela – anche giustamente – con quanti “scapparono” dalla Lombardia e altre 14 province nella notte stessa e nei giorni successivi, diffondendo il contagio in altre Regioni fin lì quasi esenti.
È l’antico, infame, modo di governare “all’italiana”: creare o far marcire i problemi, e poi colpevolizzare la popolazione.
I media ora si dilettano in ipotesi sul “cosa” riaprire prima (i negozi di abbigliamento piuttosto che i bar, le cartolerie piuttosto che i ristoranti e a maggior ragion le discoteche, ecc.). E fantasie sul “come” applicare regole di distanziamento in spazi limitati, senza alcun pensiero per i trasporti pubblici o privati... con altri milioni di lavoratori obbligati a recarsi in “ditta” e altri milioni di “consumatori” (ad ore alterne della giornata tutti sono entrambe le cose) che ampliano man mano il proprio giro quotidiano... mentre il virus è tra noi.
Produrre è importante, lo capisce anche un deficiente.
Un paese fermo per mesi è un paese che non sopravvive anche per difficoltà nei rifornimenti, oltre che per l’epidemia. E già ora ci sono segnalazioni di speculazioni sui prezzi dei generi alimentari (come sulle mascherine e l’amuchina, nei primi giorni), al limite delle pratiche da “borsa nera” in tempi di guerra.
Ma un Paese che rinuncia a fermare l’epidemia per la fregola di un pugno di imprenditori senza scrupoli è un Paese che si auto condanna alla rovina, perché in questo modo non se ne uscirà MAI.
O comunque con perdite enormemente più alte di quelle che si vogliono in questo momento evitare.
Lo capisce anche un deficiente.
Prima di questa crisi occorreva una certa dose di cultura per comprendere a fondo questa relazione contraddittoria tra produzione capitalistica e distruzione della vita. Oggi basta affacciarsi alla finestra e rendersene conto.
Guarda caso, soltanto un paese che si definisce “socialista”, anche se “con caratteristiche cinesi”, ci sta in qualche misura riuscendo. Provate a chiedervi perché (senza stronzate sulla “dittatura”, visto che qui – in tutto l’Occidente – si dispiegano eserciti contro la propria popolazione).
Del resto, dopo il nulla di fatto dell’ultimo vertice dei primi ministri europei, e le sprezzanti dichiarazioni della presidente della Commissione Europea, Ursula Von der Leyen (“i coronabond sono solo uno slogan“, insomma: non se ne parla nemmeno), tutta la nostra “classe dirigente” ha capito che dall’Unione Europea non verrà nessuna decisione utile. Dunque scelgono la solita linea: massacriamo la nostra popolazione, qualcuno di noi (imprenditori) forse sopravviverà...
Stupisce, si fa per dire, che “esperti” sottomettano le loro conoscenze scientifiche agli interessi delle imprese. Mentre non stupisce affatto, come sempre, la classe politica (di maggioranza e di opposizione) più indecente che questo disgraziato Paese – e tutta Europa – abbia mai avuto.
Fonte
Iscriviti a:
Post (Atom)

