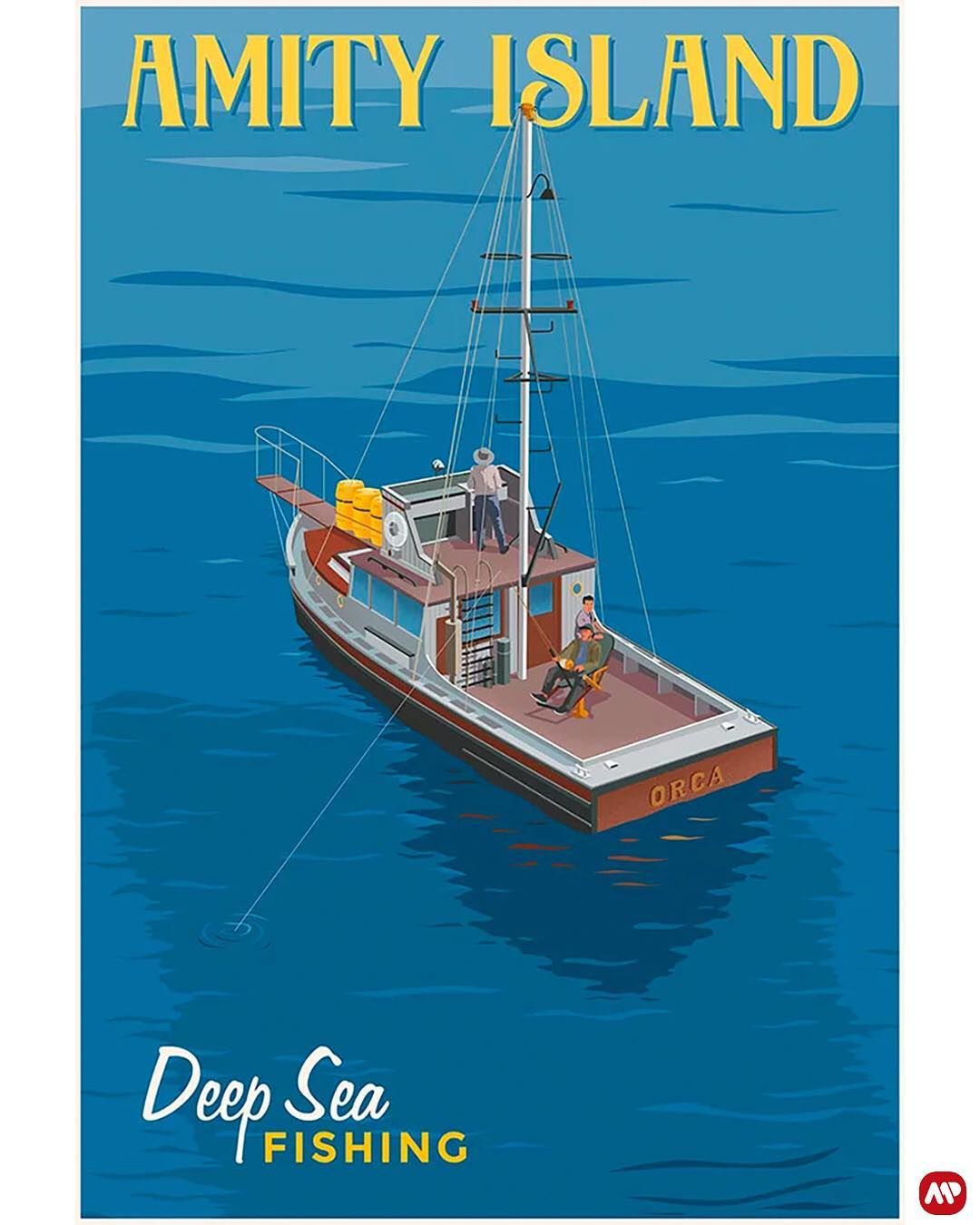Presentazione
Analisi, opinioni, fatti e (più di rado) arte da una prospettiva di classe.
29/02/2020
“Memorie di un assassino”: il normale inferno quotidiano prima di “Parasite”
Se a proposito di Parasite (2019), l’ultimo film di Bong Joon-ho, si era parlato di una quotidianità quasi distorta in forma distopica, come se la vita di tutti i giorni facesse parte di un devastato mondo futuro (qui la recensione La distopia quotidiana di “Parasite”), in un suo precedente lungometraggio, Memorie di un assassino (Memories of Murder, 2003), uscito in questi giorni al cinema in Italia, quella stessa quotidianità si rapprende in un inferno dai tratti apocalittici. Gli stessi crimini e la loro efferatezza sembrano generati da una quotidianità che è divenuta insostenibile, una routine immersa nei falcidianti rituali di vite scontate. Le sequenze iniziali del film, prima del ritrovamento di una delle molte vittime, giovani donne torturate e uccise da un misterioso assassino, mostrano immagini solari e quasi felici di una campagna percorsa da ragazzini festanti. Il ritrovamento del cadavere segnerà invece il lento precipitare in un baratro infernale. Arrivano i funzionari di polizia e la zona viene recintata, intrappolata nei meccanismi distorti di un potere che sovrasta le vite degli abitanti della piccola cittadina di campagna. Sono proprio le logiche oscure del potere a rendere un inferno la vita di tutti i giorni: se le indagini e i metodi spiccioli della polizia ne sono le estreme e più tangibili appendici, il meccanismo che ad esso è sotteso si nasconde in modo tentacolare e intangibile nello spazio dove gli abitanti del paese conducono la loro vita. Gli sfondi sono costituiti da industrie sporche e fatiscenti, discariche da cui si elevano i miasmi dell’incenerimento dei rifiuti, squallide baraccopoli dove viene vissuta un’esistenza ai limiti della sopportazione. Questo scenario infernale e apocalittico sembra però essere stato introiettato dalle persone e trasformato nella normalità dell’esistenza, proprio come nei quartieri poveri della grande città di Parasite. Se qui il livellamento delle coscienze e della materialità dell’esistenza è offerto da un oggetto di consumo come lo smartphone, in Memorie di un assassino, che si svolge nel 1986, quindi in un’epoca ancora lontana dalla digitalizzazione della quotidianità, quello stesso livellamento è dato dalla cieca e disperata assuefazione ai meccanismi del potere.
Si tratta di un potere che ingloba tutto nel sistema di una imposta normalità e che, fuor di metafora, uccide. La normalità, infatti, uccide con le discariche e gli inceneritori, con le fabbriche, con la povertà, con la violenza delle repressioni delle manifestazioni. Durante un inseguimento a un presunto assassino, i poliziotti penetrano all’interno di una fabbrica dove gli uomini sono sottoposti ai ritmi massacranti di un lavoro che li rende simili a automi; quelle discariche e quegli inceneritori inquinano e annientano la campagna; la stessa polizia non dispiega un numero sufficiente di agenti per dare la caccia all’assassino per poterli impiegare nella repressione di manifestazioni di protesta. Lo stesso rude e violento ispettore Park (che, notiamo, ha lo stesso nome della famiglia ricca di Parasite) è una vittima di questo sottile e perfetto ingranaggio: perduto nelle spire della violenza e dell’abbrutimento delle indagini (i poliziotti costringono alla confessione diversi innocenti per mezzo delle torture, come una nuova Inquisizione) forse solo alla fine si renderà conto del baratro infernale nel quale lentamente è precipitato. La violenza dei delitti, perciò, rappresenta quasi la metafora della violenza nella quale la quotidianità della vita è precipitata: una quotidianità imprigionata nella macina di una mostruosa normalità. Emblematica, in questo senso, è la frase della bambina nelle sequenze finali del film. Park, nel 2003, in un tempo ormai lontano dal mestiere di poliziotto e dall’orrore di quei giorni, si recherà nel prato (mostrato in immagini solari simili a quelle iniziali) dove era stato ritrovato uno dei cadaveri e incontra una bambina che lo informa che il giorno prima un altro uomo si era recato lì per vedere il luogo dove “aveva fatto qualcosa”. Alla domanda di Park (insospettito dal fatto che potrebbe trattarsi proprio dell’assassino) sull’aspetto fisico di quell’uomo, la bambina risponde che aveva una faccia normale. Quella faccia normale è l’emblema della normalità che uccide: una normalità infernale che è penetrata nei più sottili interstizi della vita delle persone. Una normalità imposta da sottili, invisibili e assurde logiche di potere.
Quello stesso potere che, già nella metà degli anni Ottanta in cui è ambientato il film, cominciava a nascondere la dimensione sociale del dolore, occultandolo e introiettandolo nei risvolti di una insostenibile quotidianità. Come scrive il filosofo coreano Byung-Chul Han, “la strategia del potere consiste oggi nel privatizzare la sofferenza e l’angoscia, e nel nasconderne così la dimensione sociale, impedendone in tal modo la socializzazione e la politicizzazione. Politicizzazione significa tradurre il privato in pubblico. Oggi accade invece che il pubblico venga dissolto nel privato. La dimensione pubblica si disgrega in spazi privati” (B.-C. Han, L’espulsione dell’Altro, trad. it. Nottetempo, Milano, 2017, p. 97). Quello stesso potere che livella e imprigiona negli spazi intimi, privati e digitali le famiglie di Parasite, sembra cominciare ad agire ai tempi in cui si svolge Memorie di un assassino. Allontanati dagli spazi sociali, i poveri di Parasite hanno introiettato in sé l’ideologia del lavoro e del trasformismo sociale; rinchiusi nei loro spazi privati e racchiusi nel silenzio e nell’impossibilità di esprimersi, i personaggi di Memorie di un assassino sono condannati a una normalità (anche legata alle dinamiche di un lavoro che è matericamente presente, al contrario di quello di Parasite) che lentamente li uccide. Se la violenza, nel film del 2003, è il marchio stesso della vita quotidiana degli individui, in Parasite quella stessa violenza esplode alla fine in una dimensione iperbolica.
Gli unici momenti in cui viene rotto il silenzio, nell’abbrutita provincia sudcoreana, sembrano quelli in cui si eleva il balbettio delle confessioni che altre vittime condannate al silenzio della follia, dell’emarginazione e della diversità (il giovane ritardato e il pervertito padre di famiglia) sono costrette a intonare di fronte alle torture di un inceppato e malfunzionante meccanismo di controllo e di sorveglianza. Anche l’apparente razionalità esibita dal giovane investigatore giunto da Seul si dissolverà alla fine in una esplosione di violenza nei confronti di un ennesimo sospettato di omicidio: il sottile potere che condanna al silenzio sembra aver vinto, dissolvendo e annientando i sogni e le aspirazioni di tutti i personaggi, anche quelli della ragazza che Park e il suo assistente credevano fuggita dalla provincia verso una vita migliore e che invece giaceva cadavere in un prato, ennesima vittima della generalizzata violenza della normalità. Perché quella violenza – come il potere che incarna e che lentamente, alla stregua di un serial killer, uccide con le industrie, il lavoro, gli inceneritori, le repressioni – ha una faccia normale, troppo normale per essere riconosciuta.
Fonte
C'è un particolare che sfugge in questa bellissima analisi/recensione che collega in modo molto acuto le due pellicole di Bong Joon-ho, si tratta del marxiano "modo di produzione".
È la struttura – capitalistica – di quest'ultimo a dare forma tanto alla società distopicamente sclerotizzata quando al potere repressivamente violento deputato a governarla.
Senza rimarca questo dato, diventa virtualmente impossibile giungere a una conclusione razionale dello "stato di cose presenti" messo su grande schermo da Bong Joon-ho.
Italia - Lo "spettacolo" del coronavirus
di Geraldina Colotti
“Ma cosa sta succedendo davvero in Italia?”, chiedono i compagni argentini. E parlano di italiani messi in quarantena, video di scaffali vuoti che gareggiano con le panzane diffuse dall’opposizione venezuelana, paesaggi post-atomici e un terzo posto nei contagi che quasi evoca la peste descritta dal Manzoni. Abbiamo ricapitolato un po’ di dati per Resumen Latinoamericano, tralasciando le interpretazioni complottistiche a cui chiunque può attingere ampiamente sul web.
In Italia, l’epidemia del Coronavirus Covid-19 sta invadendo talk show e telegiornali. Si moltiplicano i pareri degli esperti, veri o presunti che siano, trasformando tutto in una chiacchiera da bar in cui è difficile raccapezzarsi. Funziona così da molti anni, da quando il conflitto di classe è stato espunto dalle analisi e da un’informazione che costruisce mostri pur di fare ascolti e riprodurre sempre le stesse perversioni.
Anche in questo caso, scattano i riflessi tipici della società disciplinare, che ruota intorno al proliferare di “emergenze” e della paura, che in questo caso sta raggiungendo preoccupanti picchi di isteria: strade deserte, corsa all’acquisto di mascherine e disinfettanti, ulteriore diffondersi della xenofobia, alimentata anche in questo caso da una destra che ne ha fatto da anni il suo principale cavallo di battaglia.
A parte rare eccezioni, la polemica politica evita di andare a fondo, leggendo i dati scientifici in termini di critica strutturale a un modello di sviluppo, devastante e predatore, che fa saltare tutti gli equilibri in nome del profitto e che ora mostra tutta la sua ingovernabile criticità.
Gli scienziati seri dicono che alcuni virus che risiedono negli organismi di alcune specie di animali selvatici, come in questo caso i pipistrelli, senza provocare loro alcun danno, prendono a migrare negli esseri umani più velocemente. Un fenomeno che esiste dalla notte dei tempi, ma che, dalla metà del secolo scorso, si va accelerando per diverse ragioni: a causa dell’eccessiva prossimità tra questi animali, il cui habitat è stato distrutto dai processi di deforestazione e cementificazione, e gli umani; a causa del gigantesco aumento demografico, della velocità alla quale si spostano da un continente all’altro masse di persone; a causa del cambio climatico e degli allevamenti intensivi.
Nel caso del coronavirus si è parlato di una zuppa di pipistrello ingerita in una remota regione della Cina, Wuhan. Ai pipistrelli si era attribuito anche il contagio dal virus dell’Ebola, scoppiato nell’Africa Occidentale, e quello provocato dalla Sars, che si è trasmesso alla specie umana attraverso lo zibetto, venduto in Cina nei mercati. La vendita, illegale o consentita, di animali selvatici, è infatti un altro dei fattori di diffusione di questi agenti patogeni.
Secondo le statistiche, l’Italia è al terzo posto dopo la Cina e la Corea del Sud per estensione del virus, anche se le vittime del contagio risultano in numero infinitamente minore di quelle provocate da altre precedenti pandemie. Inoltre, gli indici di mortalità non sono minimamente comparabili a quelli dovuti alla malnutrizione in Africa o a malattie che sarebbe facile debellare se i poveri del sud globale rappresentassero un mercato ghiotto per il capitale internazionale.
Intanto, in Italia, questa nuova emergenza pesa sulle strutture carenti della sanità pubblica e sui lavoratori sottopagati e precarizzati. Con la sistematica distruzione del welfare state, conquistato dalle classi popolari nel ciclo di lotta avviatosi dopo il 1968-69 e terminato negli anni ’80 con la sconfitta e l’arresto delle avanguardie di lotta, il settore sanitario è stato uno dei più colpiti dal taglio delle politiche pubbliche.
Ancora una volta, i capitalisti italiani cercheranno di far pagare le perdite dovute all’emergenza virus, alle classi popolari. È ancora presto per valutare la portata delle misure di contenimento del contagio in una globalizzazione capitalista nella quale il ruolo dell’economia cinese è sempre più determinante, anche per l’Italia. Gli effetti, però, già si fanno sentire, sia sulla produzione sia sul turismo.
Ma, intanto, quanto ai livelli di prevenzione, nulla ci si può di certo aspettare dal negazionismo dei falchi del Pentagono, sia rispetto al cambio climatico, sia rispetto alle imprese, che hanno carta bianca per sfruttare senza controllo operai e ambiente. Trump ha anche deciso di tagliare di oltre il 50% il suo contributo all’Organizzazione Mondiale della Sanità, preferendo destinare i fondi di prevenzione scientifica della USAID alla destabilizzazione di Cuba, Venezuela e Nicaragua.
Fonte
“Ma cosa sta succedendo davvero in Italia?”, chiedono i compagni argentini. E parlano di italiani messi in quarantena, video di scaffali vuoti che gareggiano con le panzane diffuse dall’opposizione venezuelana, paesaggi post-atomici e un terzo posto nei contagi che quasi evoca la peste descritta dal Manzoni. Abbiamo ricapitolato un po’ di dati per Resumen Latinoamericano, tralasciando le interpretazioni complottistiche a cui chiunque può attingere ampiamente sul web.
In Italia, l’epidemia del Coronavirus Covid-19 sta invadendo talk show e telegiornali. Si moltiplicano i pareri degli esperti, veri o presunti che siano, trasformando tutto in una chiacchiera da bar in cui è difficile raccapezzarsi. Funziona così da molti anni, da quando il conflitto di classe è stato espunto dalle analisi e da un’informazione che costruisce mostri pur di fare ascolti e riprodurre sempre le stesse perversioni.
Anche in questo caso, scattano i riflessi tipici della società disciplinare, che ruota intorno al proliferare di “emergenze” e della paura, che in questo caso sta raggiungendo preoccupanti picchi di isteria: strade deserte, corsa all’acquisto di mascherine e disinfettanti, ulteriore diffondersi della xenofobia, alimentata anche in questo caso da una destra che ne ha fatto da anni il suo principale cavallo di battaglia.
A parte rare eccezioni, la polemica politica evita di andare a fondo, leggendo i dati scientifici in termini di critica strutturale a un modello di sviluppo, devastante e predatore, che fa saltare tutti gli equilibri in nome del profitto e che ora mostra tutta la sua ingovernabile criticità.
Gli scienziati seri dicono che alcuni virus che risiedono negli organismi di alcune specie di animali selvatici, come in questo caso i pipistrelli, senza provocare loro alcun danno, prendono a migrare negli esseri umani più velocemente. Un fenomeno che esiste dalla notte dei tempi, ma che, dalla metà del secolo scorso, si va accelerando per diverse ragioni: a causa dell’eccessiva prossimità tra questi animali, il cui habitat è stato distrutto dai processi di deforestazione e cementificazione, e gli umani; a causa del gigantesco aumento demografico, della velocità alla quale si spostano da un continente all’altro masse di persone; a causa del cambio climatico e degli allevamenti intensivi.
Nel caso del coronavirus si è parlato di una zuppa di pipistrello ingerita in una remota regione della Cina, Wuhan. Ai pipistrelli si era attribuito anche il contagio dal virus dell’Ebola, scoppiato nell’Africa Occidentale, e quello provocato dalla Sars, che si è trasmesso alla specie umana attraverso lo zibetto, venduto in Cina nei mercati. La vendita, illegale o consentita, di animali selvatici, è infatti un altro dei fattori di diffusione di questi agenti patogeni.
Secondo le statistiche, l’Italia è al terzo posto dopo la Cina e la Corea del Sud per estensione del virus, anche se le vittime del contagio risultano in numero infinitamente minore di quelle provocate da altre precedenti pandemie. Inoltre, gli indici di mortalità non sono minimamente comparabili a quelli dovuti alla malnutrizione in Africa o a malattie che sarebbe facile debellare se i poveri del sud globale rappresentassero un mercato ghiotto per il capitale internazionale.
Intanto, in Italia, questa nuova emergenza pesa sulle strutture carenti della sanità pubblica e sui lavoratori sottopagati e precarizzati. Con la sistematica distruzione del welfare state, conquistato dalle classi popolari nel ciclo di lotta avviatosi dopo il 1968-69 e terminato negli anni ’80 con la sconfitta e l’arresto delle avanguardie di lotta, il settore sanitario è stato uno dei più colpiti dal taglio delle politiche pubbliche.
Ancora una volta, i capitalisti italiani cercheranno di far pagare le perdite dovute all’emergenza virus, alle classi popolari. È ancora presto per valutare la portata delle misure di contenimento del contagio in una globalizzazione capitalista nella quale il ruolo dell’economia cinese è sempre più determinante, anche per l’Italia. Gli effetti, però, già si fanno sentire, sia sulla produzione sia sul turismo.
Ma, intanto, quanto ai livelli di prevenzione, nulla ci si può di certo aspettare dal negazionismo dei falchi del Pentagono, sia rispetto al cambio climatico, sia rispetto alle imprese, che hanno carta bianca per sfruttare senza controllo operai e ambiente. Trump ha anche deciso di tagliare di oltre il 50% il suo contributo all’Organizzazione Mondiale della Sanità, preferendo destinare i fondi di prevenzione scientifica della USAID alla destabilizzazione di Cuba, Venezuela e Nicaragua.
Fonte
28 febbraio 1978. I fascisti uccidono Roberto Scialabba
Noi non dimentichiamo. Ci sono tanti di questi anniversari, ma per tutti dobbiamo ricordare che “il fascismo non è un’opinione, ma un crimine contro l’umanità”. E che, perciò, “con i fascisti non si parla, li si combatte”.
Nell’omicidio di Roberto Scialabba, “grazie” alle confessioni del fascista “pentito” Cristiano Fioravanti, abbiamo appreso con quale “cura” i Nar andassero in cerca dei propri obiettivi.
La descrizione dell’omicidio figura anche nella richiesta di archiviazione (!) presentata dalla Procura di Roma per l’omicidio di Valerio Verbano.
Qui di seguito uno dei volantini dedicati a Roberto dal Movimento d’allora.
28 febbraio bandiere Rosse al vento, è morto un Partigiano, ne nascono altri cento
Nei giorni precedenti all’anniversario della morte di Mantakas, Fioravanti e i suoi accoliti discutono molto su quale azione mettere in atto per ricordare il camerata ucciso, fino a quando un neofascista appena uscito dal carcere riporta la notizia che a sparare ad Acca Larentia, il 7 gennaio, sono stati quelli del centro sociale di Via Calpurnio Fiamma. Detto, fatto: quella sera in otto salgono su tre macchine e si dirigono verso il quartiere Tuscolano. Arrivano davanti all’edificio occupato, ma lo trovano chiuso, perché la mattina stessa è stato sgomberato da un’operazione di polizia.
Il gruppetto comincia a perlustrare la zona, entra in un parchetto e vede un gruppo di ragazzi, che dal vestiario sembrano appartenere alla sinistra extraparlamentare. I neofascisti scendono da una delle macchine, e cominciano subito a sparare. Le pistole però si inceppano, ma per terra rimane, ferito, Roberto Scialabba, colpito al torace, mentre gli altri ragazzi, alcuni feriti, riescono ad allontanarsi. L’agguato potrebbe concludersi senza vittime, ma Valerio Fioravanti salta addosso a Roberto e gli spara: uno, due colpi alla testa. È il primo omicidio di Valerio Fioravanti, ma lui stesso si rende conto che i ragazzi di Piazza San Giovanni Bosco non avevano nulla a che fare con Acca Larentia.
Alcune ore dopo, una telefonata all’Ansa rivendica l’omicidio: “La gioventù nazional rivoluzionaria colpisce dove la giustizia borghese non vuole. Abbiamo scoperto noi chi ha ucciso Ciavatta e Bigonzetti. Onore ai camerati caduti.” Ci vorranno però quattro anni, dopo le dichiarazioni del pentito Cristiano Fioravanti, perché la magistratura riconosca la matrice politica del delitto, che fino allora era stato considerato un “regolamento di conti tra piccoli spacciatori”.
In una scritta, quando il 30 settembre di un anno prima era stato ucciso Walter Rossi, Roberto, pur non conoscendolo direttamente, lo aveva così ricordato: «Una lacrima scivola sul viso, una lacrima che non doveva uscire, il cuore si stringe, si ribella, i suoi tonfi accompagnano slogan che si alzano verso il cielo “non basta il lutto pagherete caro pagherete tutto”». Così, all’indomani della morte, i compagni di Cinecittà lo ricordavano: «Roberto era un compagno che lottava, come tutti noi, contro un’emarginazione che Stato e polizia gli imponevano. È caduto da partigiano sotto il fuoco fascista».
Fonte
Nell’omicidio di Roberto Scialabba, “grazie” alle confessioni del fascista “pentito” Cristiano Fioravanti, abbiamo appreso con quale “cura” i Nar andassero in cerca dei propri obiettivi.
La descrizione dell’omicidio figura anche nella richiesta di archiviazione (!) presentata dalla Procura di Roma per l’omicidio di Valerio Verbano.
“Quel 28 febbraio 1978, come confessato da Fioravanti Giuseppe Valerio nell’interrogatorio del 5 aprile 1986, e riportato nella citata sentenza della 5^ sezione della Corte d’Assise di Roma, ‘L’azione di ritorsione doveva avvenire (…) contro gli occupanti abusivi, forse attivisti di Democrazia Proletaria, di una casa in via Calpurnio Fiamma, ma giunti sul posto constatarono [constatammo] che il fabbricato era stato sgomberato dalle forze dell’ordine’.Da ricordare sempre – per capire la contiguità strettissima tra fascisti con la pistola e quelli in doppiopetto – che l’autista di una delle auto usate per l’omicidio di Roberto, tal Francesco Bianco, fu poi fatto assumere all’Atac durante la sindacatura di Gianni Alemanno.
‘I componenti dei Nar fecero allora un giro del quartiere e videro in piazza Don Bosco tre o quattro ragazzi vestiti da compagni’ 53
La Corte rileva inoltre che l’evento ‘non esplose improvvisamente (…) ma fu freddamente preparato, e si raggiunse un luogo distante da quello abitualmente frequentato non per difendersi con le armi, ma per porre in essere con le armi l’evento-morte’
A uccidere materialmente Roberto Scialabba fu Fioravanti Giuseppe Valerio, che ‘ferì con la propria rivoltella, una 38 Franchi Llama 6 pollici, un giovane (Roberto Scialabba) che cadde a terra: si pose a cavalcioni del corpo e gli sparò in testa una o due volte; si girò in direzione di un altro ragazzo che scappava esplodendo contro di lui altri colpi, senza però attingerlo’55
Inoltre nella sentenza veniva anche precisato che ‘Valerio Fioravanti aveva preteso che Alibrandi non sparasse perché non gli stava bene che questi avesse già ucciso un compagno, cioè Walter Rossi, mentre lui ancora non poteva vantarsi di un simile gesto’ 56
A svolgere l’azione di fuoco, mentre altri militanti effettuavano una cornice di sicurezza a distanza variabile su due altre autovetture, furono Fioravanti Giuseppe Valerio, Fioravanti Cristiano e Anselmi Franco.
L’omicidio di Roberto Scialabba venne rivendicato con la sigla ‘Giustizia nazionale rivoluzionaria o qualcosa di simile’.
Qui di seguito uno dei volantini dedicati a Roberto dal Movimento d’allora.
*****
28 febbraio bandiere Rosse al vento, è morto un Partigiano, ne nascono altri cento
Nei giorni precedenti all’anniversario della morte di Mantakas, Fioravanti e i suoi accoliti discutono molto su quale azione mettere in atto per ricordare il camerata ucciso, fino a quando un neofascista appena uscito dal carcere riporta la notizia che a sparare ad Acca Larentia, il 7 gennaio, sono stati quelli del centro sociale di Via Calpurnio Fiamma. Detto, fatto: quella sera in otto salgono su tre macchine e si dirigono verso il quartiere Tuscolano. Arrivano davanti all’edificio occupato, ma lo trovano chiuso, perché la mattina stessa è stato sgomberato da un’operazione di polizia.
Il gruppetto comincia a perlustrare la zona, entra in un parchetto e vede un gruppo di ragazzi, che dal vestiario sembrano appartenere alla sinistra extraparlamentare. I neofascisti scendono da una delle macchine, e cominciano subito a sparare. Le pistole però si inceppano, ma per terra rimane, ferito, Roberto Scialabba, colpito al torace, mentre gli altri ragazzi, alcuni feriti, riescono ad allontanarsi. L’agguato potrebbe concludersi senza vittime, ma Valerio Fioravanti salta addosso a Roberto e gli spara: uno, due colpi alla testa. È il primo omicidio di Valerio Fioravanti, ma lui stesso si rende conto che i ragazzi di Piazza San Giovanni Bosco non avevano nulla a che fare con Acca Larentia.
Alcune ore dopo, una telefonata all’Ansa rivendica l’omicidio: “La gioventù nazional rivoluzionaria colpisce dove la giustizia borghese non vuole. Abbiamo scoperto noi chi ha ucciso Ciavatta e Bigonzetti. Onore ai camerati caduti.” Ci vorranno però quattro anni, dopo le dichiarazioni del pentito Cristiano Fioravanti, perché la magistratura riconosca la matrice politica del delitto, che fino allora era stato considerato un “regolamento di conti tra piccoli spacciatori”.
In una scritta, quando il 30 settembre di un anno prima era stato ucciso Walter Rossi, Roberto, pur non conoscendolo direttamente, lo aveva così ricordato: «Una lacrima scivola sul viso, una lacrima che non doveva uscire, il cuore si stringe, si ribella, i suoi tonfi accompagnano slogan che si alzano verso il cielo “non basta il lutto pagherete caro pagherete tutto”». Così, all’indomani della morte, i compagni di Cinecittà lo ricordavano: «Roberto era un compagno che lottava, come tutti noi, contro un’emarginazione che Stato e polizia gli imponevano. È caduto da partigiano sotto il fuoco fascista».
Fonte
Zaia, lo “scienziato” razzista, spiega la “svolta” verso la minimizzazione
Quali sono le basi scientifiche della svolta repentina dal panico alla minimizzazione che è stata impressa dai politici e dai mass-media sulla questione coronavirus?
Il governatore del Veneto, Zaia, ha una spiegazione. Il problema dei cinesi è che mangiano i topi vivi e per questo lì il virus ha colpito forte, noi veneti invece ci laviamo le mani e per questo il virus ha colpito meno forte.
No, non state leggendo Lercio: lo ha detto davvero!
Ecco il testo dell’intervista rilasciata da Zaia alla televisione Antenna 3 Veneto la sera di giovedì 27 febbraio.
«Sa perché noi dopo una settimana abbiamo 116 positivi di cui 63 non hanno sintomi, stanno bene, e ne abbiamo solo 28 in ospedale, sa perché? Perché l’igiene che ha il nostro popolo, i Veneti, i cittadini italiani, la formazione culturale che abbiamo che è quella di farsi la doccia, di lavarsi, di lavarsi spesso le mani, di un regime di pulizia personale che è particolare, anche l’alimentazione, la pulizia, le norme igieniche, il frigorifero, le scadenza degli alimenti. Lei dice “Ma cosa c’entra?” C’entra perché è un fatto culturale. Io penso che la Cina abbia pagato un grande conto di questa epidemia che ha avuto, perché comunque li abbiamo visti tutti MANGIARE TOPI VIVI o altre robe del genere. Sa, è anche un fatto di corredo [sic!], perché il virus non deve trovare un ambiente che diventa un substrato [sic!], il virus deve trovare pulizia, quasi un ospedale. E noi siamo un po’ maniaci per questo, infatti i bambini ormai non mangiano più le cose che cascano per terra.”»
Aldo Romaro, Padova
*****
Penso che il presidente del Veneto ZAIA sia un politicante spregevole, disgustoso persino per gli standard del partito di Salvini.
Nella crisi #coronavirus ha mostrato tutta la sua vergognosa bassezza prima reclamando di bloccare tutto, poi lamentandosi di come i veneti, sì solo i veneti, venivano trattati all’estero, infine chiedendo di riaprire tutto.
Zaia ha dato colpa ai prefetti e allo Stato per ogni problema e si è preso il merito per ogni risultato. Infine la battuta razzista sui cinesi che farebbe schifo in qualsiasi consesso di persone civili, anzi di persone. Non sapevo molto del presidente leghista del Veneto prima d’ora, ma adesso so tutto di lui: è umanamente da vomito e politicamente rappresenta il degrado morale e civile del paese. Ogni veneto ogni italiano dovrebbe vergognarsi di lui.
Amici cinesi scusateci, purtroppo trent’anni di selezione a rovescio nella politica hanno prodotto da noi questi mostri, ma alla fine ci libereremo da questa infezione.
Giorgio Cremaschi, portavoce nazionale di Potere al Popolo!
*****
Cari imprenditori veneti che certamente esportate qualcosa verso la Cina. Se per caso non venderete mai più nulla da quelle parti, saprete certamente con chi prendervela.
Soltanto un dettaglio, che peraltro conoscete benissimo: economicamente parlando, tutto il Veneto, rispetto alla Cina, vale quando una piccola città da quelle parti.
E nessuno che abbia quelle dimensioni si fa insultare impunemente da una formica.
Come minimo – ed è davvero il minimo, in tempi così tecnologici – chiederanno a Zaia, e a voi imprenditori veneti, almeno qualche video che comprovi quanto blaterato dal vostro “governatore”.
Se “tutti hanno visto”, insomma, qualcuno avrà anche filmato!
A meno che il vostro governatore non sia abituato ad aprire impunemente bocca e dargli fiato...
Ma nelle relazioni internazionali non funziona come nelle campagne elettorali italiche. Stronzate, falsità e insulti si pagano. E molto caro.
Naturalmente il conto arriverà quanto prima a voi, cari imprenditori veneti.
In fondo Zaia mica deve vendere niente da quelle parti. Gli basta coglionare ancora un po’ chi lo elegge dalle vostre parti...
Fonte
Il circolo vizioso tra bassa istruzione e povertà
Se nasci povero e da genitori senza titolo di studio, morirai povero e senza titolo di studio.
In questo nuovo articolo della rubrica di Equilibrio Precario vogliamo occuparci della connessione tra disuguaglianze sociali ed istruzione andando a decostruire una narrazione dominante che presenta il mondo della formazione come fondato su una brillante meritocrazia che premia sempre i più bravi e “giustamente” lascia indietro chi non ha le “skills” per affrontare un mondo del lavoro flessibile che richiede giovani lavoratori sempre più "smart" e competitivi.
Riferendoci, al di là dell’ideologia, alla realtà vediamo una situazione ben diversa: chi non ha le competenze adatte non è un incapace ma viene da una condizione economica svantaggiata che non gli permette di frequentare scuole di qualità e la meritocrazia diventa un modo per giustificare le enormi disuguaglianze economiche e sociali.
Da sempre sottolineiamo come il modello economico capitalistico genera uno sviluppo ineguale di diverse aree geopolitiche, il quale a sua volta viene rafforzato dalla “controrivoluzione” neoliberale, iniziata negli anni ‘80, che ha visto l’introduzione di una serie di leggi in materia di lavoro, istruzione, previdenza sociale, sanitaria ecc., aventi l’obiettivo di piegare i diritti sociali al profitto e promuovere l’interesse privato a discapito di quello pubblico.
Questo sviluppo ineguale, imposto dall’Unione Europea soprattutto per la gestione, con l’austerity, della crisi economica, emerge chiaramente dai dati e dall’analisi del quadro generale, tant’è che ormai anche i giornali mainstream non riescono più a nasconderla, nonostante il goffo tentativo di mostrare il fenomeno come marginale.
In Italia, nello specifico, sono usciti una serie di articoli sul tema che sottolineano come la disuguaglianza e la povertà siano molto più sentite al Centro-Sud, ma che al tempo stesso l’impatto è diverso all’interno degli stessi territori a seconda della classe di appartenenza e dell’età, risultando ancora più feroce nei confronti dei giovani, della classe dei salariati e dei subalterni, nonché per le fasce sociali più deboli.
Con lo scopo di avere una fotografia più chiara del fenomeno, smascherando gli effetti di un modello economico e sociale insostenibile, ne presentiamo una descrizione per cercare di cogliere i trend più rilevanti e soprattutto per mostrare l’assenza totale di mobilità sociale, le relazioni centro-periferia che si stanno sempre più rafforzando e l’attacco fortissimo perpetrato nei confronti delle nuove generazioni che, tra le fasce di popolazione, sono quelle che soffrono di più questo modello.
I dati Istat sulla povertà in Italia[1] indicano un aumento del numero di poveri assoluti, persone che non possono permettersi le spese essenziali per condurre uno standard di vita minimamente accettabile. Nel 2017 e nel 2018, il dato si attesta su 5 milioni di persone, ovvero l’8,4% dei residenti in Italia. In particolare, il dato è tragico per le bambine e i bambini: un povero assoluto su 4 ha meno di 18 anni.
Con la crisi, infatti, i minori sono la fascia demografica che ha visto peggiorare di più la propria condizione: se nel 2005 si trovava in povertà assoluta il 3,9% dei giovani con meno di 18 anni, nell’ultimo decennio questa percentuale è più che triplicata (12,6% nel 2018). La situazione più grave riguarda i bambini tra 7 e 13 anni: il 13,4% è povero.
Questi dati allarmanti mostrano anche un circolo vizioso tra bassa istruzione e povertà: nelle famiglie senza diploma la povertà assoluta è quasi 3 volte più frequente di quelle dove la persona di riferimento è diplomata o laureata. La tendenza è aggravata da una scarsissima mobilità sociale. Nel nostro paese i figli di chi non è diplomato, tendono a loro volta a non diplomarsi, instaurando così un circolo vizioso tra condizione economica ed educativa: chi nasce in una famiglia povera ha a disposizione meno strumenti per sottrarsi a questa condizione. Un problema sociale, perché rende la povertà ereditaria e finisce con l’aggravare la situazione dei territori già deprivati.
Questo legame è visibile anche a livello territoriale. Il Mezzogiorno ad esempio si caratterizza per livelli di povertà assoluta più elevati (11,4% di persone povere, contro il 6,9% del nord e il 6,6% del centro Italia), ed è anche l’area del paese con i livelli d’istruzione più bassi. Infatti, agli ultimi posti per percentuale di adulti diplomati figurano tutte le regioni meridionali più popolose: Puglia, Sicilia, Sardegna, Campania e Calabria.
I dati Almalaurea, elaborati dal Sole24Ore, confermano chiaramente come chi parte svantaggiato in termini economici, resta nella medesima situazione. Abbiamo bassissimi tassi di giovani laureati rispetto al resto d’Europa (la quota di 25-64enni che posseggono un titolo di studio secondario superiore è stimato al 61,7% nel 2018, ben al di sotto della media europea che è pari al 78,1%[2]), soprattutto fra le fasce meno abbienti, anche perché nel nostro paese si aggiunge il gap della scelta della scuola superiore.
Nell’anno scolastico in corso il 55% dei ragazzi frequenta il primo anno di un liceo, il 30% un istituto tecnico e il 15% un istituto professionale, ma già questa prima scelta produce un divario di classe importante: solo un iscritto a un liceo classico o scientifico su 10 è figlio di operai o impiegati, il 17% dei diplomati professionali sceglie di andare all’università, e solo uno su tre di coloro che prima del diploma intendeva iscriversi all’università, l’ha effettivamente fatto.
Chi proviene da famiglie più svantaggiate, non solo in termini economici, ma anche di titolo di studio dei genitori, di fatto studia di meno e quando anche arriva a iscriversi all’università, sceglie corsi di laurea più brevi. Anche nel tasso di abbandono scolastico incide la provenienza sociale e quella territoriale[3]. In media, in Italia, poco meno di 15 giovani su 100 hanno abbandonato gli studi prima di arrivare al diploma o a una qualifica professionale di almeno 2 anni. In 3 regioni meridionali, Sardegna, Sicilia e Calabria, la percentuale supera il 20%. In Campania e Puglia oscilla tra il 18 e il 19%. Ma i divari, nel nostro paese, non emergono solo dal confronto tra le regioni, ma dentro le stesse regioni possono coesistere divari molto ampi. La Liguria è quella con i divari interni più ampi: al dato di La Spezia (4,8% di abbandoni nel 2017) si contrappone quello di Imperia (22,2%). Un gap interno che quindi è pari a 17,4 punti percentuali.
I divari risultano particolarmente ampi anche in Toscana e Sardegna. Nella prima, la quota di abbandoni di Arezzo (22%) supera di quasi 16 punti quella di Firenze (6,4%). L’analisi per province, del resto, mostra che anche nelle regioni del Nord ci sono realtà dove l’abbandono è diffuso ai livelli del Mezzogiorno. È il caso ad esempio di Liguria e Piemonte, dove si trovano le 2 province con il maggior abbandono scolastico dell’Italia settentrionale: Imperia e Novara. Due casi interessanti, visto che in entrambe le regioni la quota di abbandoni è inferiore alla media nazionale, sebbene si collochi al di sopra della soglia europea del 10%.
Tali disuguaglianze si perpetuano nel mondo del lavoro o meglio del “non lavoro”. Infatti, spostandoci nel settore occupazionale i dati ci confermano che queste tendenze si riverberano nell’occupabilità, dove vediamo un Sud sempre più arretrato in cui negli ultimi due trimestri del 2018 e nel primo del 2019 gli occupati sono calati di 107 mila unità (-1,7%), mentre nel centro Nord sono cresciuti di 48 mila unità (+0,3%) nello stesso periodo[4].
Per di più, l’Italia si aggiudica il primato rispetto agli altri paesi europei riguardo ai Neet: nel 2018 i Neet (Not in Education, Employment or Training) sono 2.189.000, confermando il problema strutturale dell’inclusione e della partecipazione dei giovani all’interno del mercato del lavoro e dei percorsi formativi. Nel Mezzogiorno, però, l’incidenza dei Neet è più che doppia (33,8%) rispetto al Nord (15,6%), mentre al Centro è del 19,6%[5].
Gli effetti delle disuguaglianze che si riflettono quindi sulle scelte dei giovani non sono solo legate all’istruzione bensì anche al lavoro e questo comporterà un inasprimento in termini di migrazioni interne in primo luogo e verso i paesi core dell’UE in secondo luogo. Il rapporto Svimez[6] ci offre un quadro entro il quale l’Italia si muoverà, tenendo a mente un progressivo rallentamento dell’economia italiana.
Chi verrà leso maggiormente da questa situazione è ancora una volta il Sud. Continuando a citare la fonte Svimez, gli emigrati dal Sud tra il 2002 e il 2017 sono stati già oltre 2 milioni, di cui 132.187 solo nel 2017. Di questi ultimi 66.557 sono giovani (50,04%, di cui il 33% laureati). Il saldo migratorio interno al netto è negativo per 852 mila unità. Nel 2017 sono emigrati dal Meridione 132 mila persone, con un saldo negativo di circa 70 mila unità.
Conclusione: se nasci povero e da genitori senza titoli di studio morirai povero e senza titoli di studio. Fin dalla scuola superiore inizia la selezione di classe soprattutto con la maggiore polarizzazione tra scuole di serie A e di serie B che negli ultimi anni è ulteriormente aumentata con l’introduzione dell’Alternanza Scuola Lavoro (Legge 107) che sarà “buona alternanza” nelle scuole di alto livello dove le famiglie ricche possono addirittura spendere soldi per un’alternanza scuola lavoro all’estero, e significherà friggere patatine al McDonald’s nelle scuole dequalificate di fasce periferiche.
Come abbiamo visto, all’università neanche ci arrivano i figli di genitori poveri e senza titoli di studio, tanto che il sistema universitario italiano sta avendo una regressione da università di massa ad università d’élite a causa delle tasse altissime e dei finanziamenti statali che non vengono utilizzati per il diritto allo studio o distribuiti in maniera equa tra gli atenei per evitare disuguaglianze, ma per creare poli d’eccellenza e favorire l’ingresso di aziende private nella ricerca.
Le disuguaglianze economiche e sociali imposte dal modello di produzione capitalistico soprattutto a partire dalla gestione della crisi da parte dell’Unione Europea vengono accentuate dal sistema formativo che al posto di essere una possibilità di emancipazione diventa vera e proprio scuola di classe. Per capire fino in fondo le differenze di classe fomentate dal sistema scolastico e per fare chiarezza sugli interessi che stanno dietro, occorre far riferimento al piano europeo.
La costruzione dell’Unione Europea come polo competitivo a livello globale è fondata su uno sviluppo ineguale ossia su un’Europa a due velocità: da un lato i paesi del centro e del nord con economie forti ed industrializzate, dall’altro i paesi del sud e dell’est che hanno la funzione di essere mercati di sbocco e di fornire materie prime per le merci prodotte nel centro e soprattutto fonte di manodopera a basso costo ai paesi del centro.
In questo contesto, il nostro paese, con le poche università ad alto livello formativo che possiede (per esempio poli di serie A quali l’Università di Bologna, il Politecnico di Milano e alcuni atenei privati) esprime una ristretta élite di giovani (provenienti di solito da famiglie già economicamente avvantaggiate, come abbiamo mostrato sopra) che, non trovando lavoro in Italia, emigrano nei paesi del centro e, molto probabilmente, andranno a far parte dall’alta classe dirigente dell’Unione Europea.
Per tutti gli altri giovani studenti con una condizione di partenza più svantaggiata le strade sono due: o rimanere in Italia ad ingrossare le file dei disoccupati o dei precari (seppur siano riusciti ad ottenere anche un’alta preparazione formativa), oppure tentare la via dell’emigrazione in Germania, Francia ed Inghilterra finendo spesso a fare i lavapiatti o altri lavori estremamente dequalificati e comunque pagati pochissimo.
Quindi, allargando lo sguardo, le disuguaglianze che notiamo a livello della scuola e dell’università italiana derivano in realtà da un assetto europeo fondato su uno sviluppo diseguale in cui il nostro paese ha il ruolo di fornire manodopera qualificata ai paesi del centro e del nord.
Per riuscire a primeggiare nella competizione globale è fondamentale, per la dirigenza dell’Unione Europea, avere un cosiddetto “capitale umano” molto qualificato capace di lavorare in ambiti come quello dello sviluppo e dell’innovazione tecnologica e industriale. Nei documenti riguardanti gli obiettivi strategici dell’Unione Europea viene spesso scritto che l’Unione Europea punta a diventare una delle economie della conoscenza più forti al mondo. Così diventa chiara l’importanza della formazione e dell’alta ricerca tanto che l’ultimo Programma Quadro sulla formazione a livello europeo è il più alto finanziamento mai stato stanziato dell’UE dalla sua nascita all’inizio degli anni ’90.
Dietro alla costruzione di una formazione classista sia a livello nazionale sia a livello europeo stanno gli interessi dei grandi gruppi industriali e dirigenti dell’Unione Europea che, attraverso lo sfruttamento dei risultati dell’alta ricerca, cercano di competere con le altre potenze globali. Pensiamo che il primo passo per ribaltare questo sistema sia quello di individuare i responsabili e creare strumenti d’analisi che ci aiutino a distinguere tra narrazione ideologica e realtà e tra interessi di pochi e interessi di molti.
Note:
[1] https://www.openpolis.it/il-legame-tra-bassa-istruzione-e-poverta-va-considerato-unemergenza/
[2] https://www.infodata.ilsole24ore.com/2019/08/08/37865/
[3] https://www.openpolis.it/divari-ampi-sullabbandono-scolastico-anche-dentro-la-stessa-regione/
[4] https://www.ilsole24ore.com/art/svimez-2019-pil-sotto-zero-spettro-recessione-sud-ACqAIdc
[5]http://scuola24.ilsole24ore.com/art/scuola/2019-07-15/istat-italia-istruzione-sotto-media-ue-i-diplomati-25percento-neet-174213.php?uuid=ACse5xY&fromSearch
[6] https://www.ilsole24ore.com/art/svimez-2019-pil-sotto-zero-spettro-recessione-sud-ACqAIdc
Fonte
In questo nuovo articolo della rubrica di Equilibrio Precario vogliamo occuparci della connessione tra disuguaglianze sociali ed istruzione andando a decostruire una narrazione dominante che presenta il mondo della formazione come fondato su una brillante meritocrazia che premia sempre i più bravi e “giustamente” lascia indietro chi non ha le “skills” per affrontare un mondo del lavoro flessibile che richiede giovani lavoratori sempre più "smart" e competitivi.
Riferendoci, al di là dell’ideologia, alla realtà vediamo una situazione ben diversa: chi non ha le competenze adatte non è un incapace ma viene da una condizione economica svantaggiata che non gli permette di frequentare scuole di qualità e la meritocrazia diventa un modo per giustificare le enormi disuguaglianze economiche e sociali.
Da sempre sottolineiamo come il modello economico capitalistico genera uno sviluppo ineguale di diverse aree geopolitiche, il quale a sua volta viene rafforzato dalla “controrivoluzione” neoliberale, iniziata negli anni ‘80, che ha visto l’introduzione di una serie di leggi in materia di lavoro, istruzione, previdenza sociale, sanitaria ecc., aventi l’obiettivo di piegare i diritti sociali al profitto e promuovere l’interesse privato a discapito di quello pubblico.
Questo sviluppo ineguale, imposto dall’Unione Europea soprattutto per la gestione, con l’austerity, della crisi economica, emerge chiaramente dai dati e dall’analisi del quadro generale, tant’è che ormai anche i giornali mainstream non riescono più a nasconderla, nonostante il goffo tentativo di mostrare il fenomeno come marginale.
In Italia, nello specifico, sono usciti una serie di articoli sul tema che sottolineano come la disuguaglianza e la povertà siano molto più sentite al Centro-Sud, ma che al tempo stesso l’impatto è diverso all’interno degli stessi territori a seconda della classe di appartenenza e dell’età, risultando ancora più feroce nei confronti dei giovani, della classe dei salariati e dei subalterni, nonché per le fasce sociali più deboli.
Con lo scopo di avere una fotografia più chiara del fenomeno, smascherando gli effetti di un modello economico e sociale insostenibile, ne presentiamo una descrizione per cercare di cogliere i trend più rilevanti e soprattutto per mostrare l’assenza totale di mobilità sociale, le relazioni centro-periferia che si stanno sempre più rafforzando e l’attacco fortissimo perpetrato nei confronti delle nuove generazioni che, tra le fasce di popolazione, sono quelle che soffrono di più questo modello.
I dati Istat sulla povertà in Italia[1] indicano un aumento del numero di poveri assoluti, persone che non possono permettersi le spese essenziali per condurre uno standard di vita minimamente accettabile. Nel 2017 e nel 2018, il dato si attesta su 5 milioni di persone, ovvero l’8,4% dei residenti in Italia. In particolare, il dato è tragico per le bambine e i bambini: un povero assoluto su 4 ha meno di 18 anni.
Con la crisi, infatti, i minori sono la fascia demografica che ha visto peggiorare di più la propria condizione: se nel 2005 si trovava in povertà assoluta il 3,9% dei giovani con meno di 18 anni, nell’ultimo decennio questa percentuale è più che triplicata (12,6% nel 2018). La situazione più grave riguarda i bambini tra 7 e 13 anni: il 13,4% è povero.
Questi dati allarmanti mostrano anche un circolo vizioso tra bassa istruzione e povertà: nelle famiglie senza diploma la povertà assoluta è quasi 3 volte più frequente di quelle dove la persona di riferimento è diplomata o laureata. La tendenza è aggravata da una scarsissima mobilità sociale. Nel nostro paese i figli di chi non è diplomato, tendono a loro volta a non diplomarsi, instaurando così un circolo vizioso tra condizione economica ed educativa: chi nasce in una famiglia povera ha a disposizione meno strumenti per sottrarsi a questa condizione. Un problema sociale, perché rende la povertà ereditaria e finisce con l’aggravare la situazione dei territori già deprivati.
Questo legame è visibile anche a livello territoriale. Il Mezzogiorno ad esempio si caratterizza per livelli di povertà assoluta più elevati (11,4% di persone povere, contro il 6,9% del nord e il 6,6% del centro Italia), ed è anche l’area del paese con i livelli d’istruzione più bassi. Infatti, agli ultimi posti per percentuale di adulti diplomati figurano tutte le regioni meridionali più popolose: Puglia, Sicilia, Sardegna, Campania e Calabria.
I dati Almalaurea, elaborati dal Sole24Ore, confermano chiaramente come chi parte svantaggiato in termini economici, resta nella medesima situazione. Abbiamo bassissimi tassi di giovani laureati rispetto al resto d’Europa (la quota di 25-64enni che posseggono un titolo di studio secondario superiore è stimato al 61,7% nel 2018, ben al di sotto della media europea che è pari al 78,1%[2]), soprattutto fra le fasce meno abbienti, anche perché nel nostro paese si aggiunge il gap della scelta della scuola superiore.
Nell’anno scolastico in corso il 55% dei ragazzi frequenta il primo anno di un liceo, il 30% un istituto tecnico e il 15% un istituto professionale, ma già questa prima scelta produce un divario di classe importante: solo un iscritto a un liceo classico o scientifico su 10 è figlio di operai o impiegati, il 17% dei diplomati professionali sceglie di andare all’università, e solo uno su tre di coloro che prima del diploma intendeva iscriversi all’università, l’ha effettivamente fatto.
Chi proviene da famiglie più svantaggiate, non solo in termini economici, ma anche di titolo di studio dei genitori, di fatto studia di meno e quando anche arriva a iscriversi all’università, sceglie corsi di laurea più brevi. Anche nel tasso di abbandono scolastico incide la provenienza sociale e quella territoriale[3]. In media, in Italia, poco meno di 15 giovani su 100 hanno abbandonato gli studi prima di arrivare al diploma o a una qualifica professionale di almeno 2 anni. In 3 regioni meridionali, Sardegna, Sicilia e Calabria, la percentuale supera il 20%. In Campania e Puglia oscilla tra il 18 e il 19%. Ma i divari, nel nostro paese, non emergono solo dal confronto tra le regioni, ma dentro le stesse regioni possono coesistere divari molto ampi. La Liguria è quella con i divari interni più ampi: al dato di La Spezia (4,8% di abbandoni nel 2017) si contrappone quello di Imperia (22,2%). Un gap interno che quindi è pari a 17,4 punti percentuali.
I divari risultano particolarmente ampi anche in Toscana e Sardegna. Nella prima, la quota di abbandoni di Arezzo (22%) supera di quasi 16 punti quella di Firenze (6,4%). L’analisi per province, del resto, mostra che anche nelle regioni del Nord ci sono realtà dove l’abbandono è diffuso ai livelli del Mezzogiorno. È il caso ad esempio di Liguria e Piemonte, dove si trovano le 2 province con il maggior abbandono scolastico dell’Italia settentrionale: Imperia e Novara. Due casi interessanti, visto che in entrambe le regioni la quota di abbandoni è inferiore alla media nazionale, sebbene si collochi al di sopra della soglia europea del 10%.
Tali disuguaglianze si perpetuano nel mondo del lavoro o meglio del “non lavoro”. Infatti, spostandoci nel settore occupazionale i dati ci confermano che queste tendenze si riverberano nell’occupabilità, dove vediamo un Sud sempre più arretrato in cui negli ultimi due trimestri del 2018 e nel primo del 2019 gli occupati sono calati di 107 mila unità (-1,7%), mentre nel centro Nord sono cresciuti di 48 mila unità (+0,3%) nello stesso periodo[4].
Per di più, l’Italia si aggiudica il primato rispetto agli altri paesi europei riguardo ai Neet: nel 2018 i Neet (Not in Education, Employment or Training) sono 2.189.000, confermando il problema strutturale dell’inclusione e della partecipazione dei giovani all’interno del mercato del lavoro e dei percorsi formativi. Nel Mezzogiorno, però, l’incidenza dei Neet è più che doppia (33,8%) rispetto al Nord (15,6%), mentre al Centro è del 19,6%[5].
Gli effetti delle disuguaglianze che si riflettono quindi sulle scelte dei giovani non sono solo legate all’istruzione bensì anche al lavoro e questo comporterà un inasprimento in termini di migrazioni interne in primo luogo e verso i paesi core dell’UE in secondo luogo. Il rapporto Svimez[6] ci offre un quadro entro il quale l’Italia si muoverà, tenendo a mente un progressivo rallentamento dell’economia italiana.
Chi verrà leso maggiormente da questa situazione è ancora una volta il Sud. Continuando a citare la fonte Svimez, gli emigrati dal Sud tra il 2002 e il 2017 sono stati già oltre 2 milioni, di cui 132.187 solo nel 2017. Di questi ultimi 66.557 sono giovani (50,04%, di cui il 33% laureati). Il saldo migratorio interno al netto è negativo per 852 mila unità. Nel 2017 sono emigrati dal Meridione 132 mila persone, con un saldo negativo di circa 70 mila unità.
Conclusione: se nasci povero e da genitori senza titoli di studio morirai povero e senza titoli di studio. Fin dalla scuola superiore inizia la selezione di classe soprattutto con la maggiore polarizzazione tra scuole di serie A e di serie B che negli ultimi anni è ulteriormente aumentata con l’introduzione dell’Alternanza Scuola Lavoro (Legge 107) che sarà “buona alternanza” nelle scuole di alto livello dove le famiglie ricche possono addirittura spendere soldi per un’alternanza scuola lavoro all’estero, e significherà friggere patatine al McDonald’s nelle scuole dequalificate di fasce periferiche.
Come abbiamo visto, all’università neanche ci arrivano i figli di genitori poveri e senza titoli di studio, tanto che il sistema universitario italiano sta avendo una regressione da università di massa ad università d’élite a causa delle tasse altissime e dei finanziamenti statali che non vengono utilizzati per il diritto allo studio o distribuiti in maniera equa tra gli atenei per evitare disuguaglianze, ma per creare poli d’eccellenza e favorire l’ingresso di aziende private nella ricerca.
Le disuguaglianze economiche e sociali imposte dal modello di produzione capitalistico soprattutto a partire dalla gestione della crisi da parte dell’Unione Europea vengono accentuate dal sistema formativo che al posto di essere una possibilità di emancipazione diventa vera e proprio scuola di classe. Per capire fino in fondo le differenze di classe fomentate dal sistema scolastico e per fare chiarezza sugli interessi che stanno dietro, occorre far riferimento al piano europeo.
La costruzione dell’Unione Europea come polo competitivo a livello globale è fondata su uno sviluppo ineguale ossia su un’Europa a due velocità: da un lato i paesi del centro e del nord con economie forti ed industrializzate, dall’altro i paesi del sud e dell’est che hanno la funzione di essere mercati di sbocco e di fornire materie prime per le merci prodotte nel centro e soprattutto fonte di manodopera a basso costo ai paesi del centro.
In questo contesto, il nostro paese, con le poche università ad alto livello formativo che possiede (per esempio poli di serie A quali l’Università di Bologna, il Politecnico di Milano e alcuni atenei privati) esprime una ristretta élite di giovani (provenienti di solito da famiglie già economicamente avvantaggiate, come abbiamo mostrato sopra) che, non trovando lavoro in Italia, emigrano nei paesi del centro e, molto probabilmente, andranno a far parte dall’alta classe dirigente dell’Unione Europea.
Per tutti gli altri giovani studenti con una condizione di partenza più svantaggiata le strade sono due: o rimanere in Italia ad ingrossare le file dei disoccupati o dei precari (seppur siano riusciti ad ottenere anche un’alta preparazione formativa), oppure tentare la via dell’emigrazione in Germania, Francia ed Inghilterra finendo spesso a fare i lavapiatti o altri lavori estremamente dequalificati e comunque pagati pochissimo.
Quindi, allargando lo sguardo, le disuguaglianze che notiamo a livello della scuola e dell’università italiana derivano in realtà da un assetto europeo fondato su uno sviluppo diseguale in cui il nostro paese ha il ruolo di fornire manodopera qualificata ai paesi del centro e del nord.
Per riuscire a primeggiare nella competizione globale è fondamentale, per la dirigenza dell’Unione Europea, avere un cosiddetto “capitale umano” molto qualificato capace di lavorare in ambiti come quello dello sviluppo e dell’innovazione tecnologica e industriale. Nei documenti riguardanti gli obiettivi strategici dell’Unione Europea viene spesso scritto che l’Unione Europea punta a diventare una delle economie della conoscenza più forti al mondo. Così diventa chiara l’importanza della formazione e dell’alta ricerca tanto che l’ultimo Programma Quadro sulla formazione a livello europeo è il più alto finanziamento mai stato stanziato dell’UE dalla sua nascita all’inizio degli anni ’90.
Dietro alla costruzione di una formazione classista sia a livello nazionale sia a livello europeo stanno gli interessi dei grandi gruppi industriali e dirigenti dell’Unione Europea che, attraverso lo sfruttamento dei risultati dell’alta ricerca, cercano di competere con le altre potenze globali. Pensiamo che il primo passo per ribaltare questo sistema sia quello di individuare i responsabili e creare strumenti d’analisi che ci aiutino a distinguere tra narrazione ideologica e realtà e tra interessi di pochi e interessi di molti.
Note:
[1] https://www.openpolis.it/il-legame-tra-bassa-istruzione-e-poverta-va-considerato-unemergenza/
[2] https://www.infodata.ilsole24ore.com/2019/08/08/37865/
[3] https://www.openpolis.it/divari-ampi-sullabbandono-scolastico-anche-dentro-la-stessa-regione/
[4] https://www.ilsole24ore.com/art/svimez-2019-pil-sotto-zero-spettro-recessione-sud-ACqAIdc
[5]http://scuola24.ilsole24ore.com/art/scuola/2019-07-15/istat-italia-istruzione-sotto-media-ue-i-diplomati-25percento-neet-174213.php?uuid=ACse5xY&fromSearch
[6] https://www.ilsole24ore.com/art/svimez-2019-pil-sotto-zero-spettro-recessione-sud-ACqAIdc
Fonte
Consigli (o sconsigli) per gli acquisti: La linea del fuoco, di Manolo Morlacchi, Mimesis 2019
È una storia di militanti e di guerrieri, di donne e uomini che hanno combattuto per liberarsi di una dittatura e che hanno combattuto perché
credevano nel socialismo: due attitudini non sovrapponibili, ma
collegate. È anche una storia complicata, chiaramente, perché si tratta
di vicende latinoamericane, con il portato di variabili che, noi vecchi
europei, fatichiamo a comprendere.
La questione del peronismo, innanzi tutto, vale a dire la “secca” su cui facilmente si incagliano tante riflessioni dei compagni e delle compagne europee sulla politica latino americana del secondo dopoguerra. Sarebbe facile fare spallucce, banalizzando la questione secondo il buon vecchio adagio per cui “tanto sono chiacchiere”. La storia e la lotta di classe la fanno coloro che la vivono, non chi la commenta, evidentemente, ma l’affaire del peronismo è emblematico dello stordimento che caratterizza la sinistra “occidentale” – e quella italiana in particolare – quando si trova ad affrontare variabili poco praticate dalle sue parti. Il peronismo ieri, il populismo oggi, per dire, ma anche i movimenti di liberazione nazionale, la decolonizzazione, l’indigenismo e l’antimperialismo. Manolo Morlacchi, che de La linea del fuoco è l’autore, è ben consapevole di questo problema e non svicola sotto l’ostacolo, tanto che il suo saggio è anche un utile e raro esempio di lettura marxista – quindi secondo i paradigmi della scienza della classe – di Perón e del peronismo senza Perón. Non viene negato, quindi, né l’iniziale posizionamento del Generale argentino al fianco nel nazifascismo, durante la II Guerra mondiale (in coerenza con la precoce fascinazione dello stesso Perón per Mussolini), né il successivo riallineamento in funzione filo statunitense e palesemente anti-sovietica, ivi compreso un fetido corteggiamento al Fondo monetario internazionale e alla Banca mondiale. Corteggiamento non corrisposto, peraltro, tanto da suggerire un inevitabile “ripensamento”, che consigliò al Generale un’inversione nazionalista non inedita, in Latino America. Sia chiaro, onde evitare accuse di “rossobrunismo” che oggi vengono diffuse con sconcertante serenità, che: Morlacchi esprime con nitore la sua posizione politica sul peronismo, sin dal primo capitolo: “Il fatto che Juan Domingo Perón sia stata una figura compromessa sin dall’inizio con gli interessi del grande capitale e che contribuì attivamente all’organizzazione della repressione appare storicamente incontestabile” (p. 32) ma, allo stesso tempo, suggerisce come sarebbe riduttivo leggere il legame tra classe operaia e Perón semplicemente alla luce dell’aura antimperialista di quest’ultimo, dimenticando come l’organizzazione stessa delle strutture di difesa e rivendicazione operaia sia stata plasmata proprio da Perón, che sostituì i vertici socialisti e comunisti della Confederazione Generale del Lavoro, mettendovi i suoi uomini e aumentandone notevolmente i tesserati.
È difficilmente confutabile quanto afferma, a tal proposito, Julio Santucho nell’Introduzione: “Il fatto è che la costituzione del proletariato come classe nazionale avvenne in condizioni di chiara subordinazione ideologica, politica e organizzativa al progetto nazionalista borghese di Perón” (p. 14). Qui è insita la spiegazione del perché, da un lato, il peronismo sopravvisse anche all’interruzione – lunga ben diciassette anni – della presidenza Perón e, dall’altro, perché la classe operaia argentina debba essere definita “peronista”, ma non “peroniana” in senso stretto. Che il lascito più cospicuo del “bonapartista” Perón verso i lavoratori argentini sia stato un netto (ma ahinoi effimero) miglioramento della qualità della vita oppure la struttura organizzativa di una solida forza laburista diventa, a questo punto, quasi secondario: che sia stato il pane oppure le rose, fatto sta che proprio durante la prima presidenza Perón la forza lavoro argentina si rende conto della possibilità di edificare una società diversa da quella dominata da quel capitalismo assassino e rapace che il Latino America conosce dal primo contatto con l’Occidente e che l’Europa sta incominciando a conoscere solo nell’ultimo decennio. È altrettanto secondario che ciò sia avvenuto per una sincera (ma assai improbabile) vocazione progressista del Generale o per quel misto di casualità, di contingenza internazionale e di “costrizione” politica interna, oltre che di evidenti doti soggettive, che caratterizzarono il secondo dopoguerra argentino. Fatto sta che accadde, in un processo storico che si rivelò permeabile – e qui c’è il “cuore” del lavoro di Manolo Morlacchi (o quantomeno la parte che più scalda il nostro, di cuore) – alle istanze rivoluzionarie, simboleggiate (ma non esaurite) dalle vicende della famiglia Santucho, quasi una copia anastatica, ma in versione rivoluzionaria, dei Perón. Straordinario laboratorio di teoria e di prassi politica, i Santucho hanno rappresentato la dimostrazione vivente di come le particolari condizioni del contesto argentino spingessero anche una parte di borghesia illuminata e benestante a sposare la causa dei diseredati e degli sfruttati, organizzandoli in un partito e in una compagine militare, arrivando a pagare un prezzo altissimo, per quanto “giustificato” dal livello della sfida lanciata al sistema politico argentino, che era quello – non dimentichiamolo – dei militari, del potere clericale, dei latifondisti, degli interessi economici nordamericani. Per questo motivo il libro di Manolo si pone come una “restituzione” nei confronti dei militanti coinvolti nella mattanza argentina, nel dissanguamento di un’intera generazione, nell’ineffabile capacità occidentale di guardare da un’altra parte, di non rinunciare ai Mondiali di calcio oppure di limitare il proprio dissenso da Pinochet alle magliette rosse dei tennisti di Coppa Davis, mentre il Latino America degli anni Settanta organizzava i pogrom e provava ad azzerare geneticamente l’idea stessa di Rivoluzione. Non solo i giovani, ma persino i loro figli, strappati alle famiglie dei desaparecidos con una scientificità che va oltre il “pragmatismo del male” e pare quasi un monito biblico: ‘Maledetto sia tu, i tuoi figli e i figli dei tuoi figli’. Eppure La linea del fuoco (qui sta uno dei più meritati motivi di vanto del volume) è attento a evitare la narrazione dominante, rispetto a uno dei periodi più oscuri del XX secolo, vale a dire il ricordo frammentato dei singoli e delle singole, che finiscono di default – in questo modo – nella categoria delle “vittime”, soffrendo una seconda e nuova “scomparsa”: quella della dimensione di consapevole militante rivoluzionario. Manolo Morlacchi non si presta alla narrazione per schegge (quebrantos, come da titolo di un peraltro suggestivo volume per Nova Delphi, a cura di Delia Ana Fanego) e riconduce a unitarietà la storia dell’Argentina sovversiva del secondo dopoguerra, ribadendo l’organicità di un percorso pure dipanatosi tra tanti rivoli e molteplici tentativi, vittorie, sconfitte, errori. Senza mai abbandonare, però, una stentorea coscienza di classe e una irriducibilità ad accettare lo stato di cose del tempo, come testimoniato dal cartellino di prigioniero di Mario “Indio” Paz, militante dell’ERP e comandante della Compagna del Monte, quando era recluso a Campo de Mayo: ‘Irrecuperabile’.
La storia del Partito Rivoluzionario dei Lavoratori (PRT) e della sua ala militare, l’Esercito Rivoluzionario del Popolo (ERP), è una storia collettiva, come è inevitabile che sia per la storia di un partito e di un’organizzazione combattente: non è retorica da nobili perdenti, ma parte di quella “restituzione” di cui sopra, citare una canzone dedicata ad Ana María Lanzilotto, Domingo Menna, Benito Urteaga e Liliana Delfino, riportata a p. 199: “Non cercate la mia tomba perché non la troverete. Le mie mani sono quelle che vanno in altre mani sparando. La mia voce è quella che sta gridando, in una rivoluzione, quando è vera, o si trionfa o si muore. Il sogno è sempre intero. E sappiate che morirò solo se voi mollerete, perché chi è morto combattendo vive in ogni compagno”.
Il libro di Manolo non si ferma qui: si pone anche come insegnamento per chi voglia fare ricerca su un contesto o un periodo storico lontano dal proprio, senza per questo dover scegliere tra rigore scientifico e passione militante. L’Autore vi è riuscito partendo dai fili della sua memoria familiare, dal suo essere dentro la storia del movimento rivoluzionario, dalla sua consapevolezza di costituire solo un ingranaggio di quest’ultima. Per questo motivo La linea del fuoco è anche un archivio da aggiornare quotidianamente e da moltiplicare, rifiutando non solo il paradigma dei diritti umani (inevitabilmente allergico a qualsiasi politicità, anche solo progressista), ma anche quella vittimologia che, pur trovandosi spesso a essere la migliore delle narrazioni mainstream possibili, non rende giustizia alla forza delle idee e riduce all’incomprensibilità la frase meravigliosa che chiude la nota dell’Autore, a firma di Lucia Volpi, militante di Lotta Continua, impegnata ad accogliere gli esuli argentini in Italia insieme al marito (Vito) e sorpresa nel sapere che quest’ultimo avesse ricevuto la proposta di andare a combattere in Nicaragua con l’ultimo gruppo sostanzioso di militanti del PRT/ERP. Vito declinò l’offerta, per motivi familiari. “Gli chiesero di partire perché – anche se distanti migliaia di chilometri dall’Argentina – per quello che avevamo fatto ci consideravano parte del Partito”.
Fonte
La questione del peronismo, innanzi tutto, vale a dire la “secca” su cui facilmente si incagliano tante riflessioni dei compagni e delle compagne europee sulla politica latino americana del secondo dopoguerra. Sarebbe facile fare spallucce, banalizzando la questione secondo il buon vecchio adagio per cui “tanto sono chiacchiere”. La storia e la lotta di classe la fanno coloro che la vivono, non chi la commenta, evidentemente, ma l’affaire del peronismo è emblematico dello stordimento che caratterizza la sinistra “occidentale” – e quella italiana in particolare – quando si trova ad affrontare variabili poco praticate dalle sue parti. Il peronismo ieri, il populismo oggi, per dire, ma anche i movimenti di liberazione nazionale, la decolonizzazione, l’indigenismo e l’antimperialismo. Manolo Morlacchi, che de La linea del fuoco è l’autore, è ben consapevole di questo problema e non svicola sotto l’ostacolo, tanto che il suo saggio è anche un utile e raro esempio di lettura marxista – quindi secondo i paradigmi della scienza della classe – di Perón e del peronismo senza Perón. Non viene negato, quindi, né l’iniziale posizionamento del Generale argentino al fianco nel nazifascismo, durante la II Guerra mondiale (in coerenza con la precoce fascinazione dello stesso Perón per Mussolini), né il successivo riallineamento in funzione filo statunitense e palesemente anti-sovietica, ivi compreso un fetido corteggiamento al Fondo monetario internazionale e alla Banca mondiale. Corteggiamento non corrisposto, peraltro, tanto da suggerire un inevitabile “ripensamento”, che consigliò al Generale un’inversione nazionalista non inedita, in Latino America. Sia chiaro, onde evitare accuse di “rossobrunismo” che oggi vengono diffuse con sconcertante serenità, che: Morlacchi esprime con nitore la sua posizione politica sul peronismo, sin dal primo capitolo: “Il fatto che Juan Domingo Perón sia stata una figura compromessa sin dall’inizio con gli interessi del grande capitale e che contribuì attivamente all’organizzazione della repressione appare storicamente incontestabile” (p. 32) ma, allo stesso tempo, suggerisce come sarebbe riduttivo leggere il legame tra classe operaia e Perón semplicemente alla luce dell’aura antimperialista di quest’ultimo, dimenticando come l’organizzazione stessa delle strutture di difesa e rivendicazione operaia sia stata plasmata proprio da Perón, che sostituì i vertici socialisti e comunisti della Confederazione Generale del Lavoro, mettendovi i suoi uomini e aumentandone notevolmente i tesserati.
È difficilmente confutabile quanto afferma, a tal proposito, Julio Santucho nell’Introduzione: “Il fatto è che la costituzione del proletariato come classe nazionale avvenne in condizioni di chiara subordinazione ideologica, politica e organizzativa al progetto nazionalista borghese di Perón” (p. 14). Qui è insita la spiegazione del perché, da un lato, il peronismo sopravvisse anche all’interruzione – lunga ben diciassette anni – della presidenza Perón e, dall’altro, perché la classe operaia argentina debba essere definita “peronista”, ma non “peroniana” in senso stretto. Che il lascito più cospicuo del “bonapartista” Perón verso i lavoratori argentini sia stato un netto (ma ahinoi effimero) miglioramento della qualità della vita oppure la struttura organizzativa di una solida forza laburista diventa, a questo punto, quasi secondario: che sia stato il pane oppure le rose, fatto sta che proprio durante la prima presidenza Perón la forza lavoro argentina si rende conto della possibilità di edificare una società diversa da quella dominata da quel capitalismo assassino e rapace che il Latino America conosce dal primo contatto con l’Occidente e che l’Europa sta incominciando a conoscere solo nell’ultimo decennio. È altrettanto secondario che ciò sia avvenuto per una sincera (ma assai improbabile) vocazione progressista del Generale o per quel misto di casualità, di contingenza internazionale e di “costrizione” politica interna, oltre che di evidenti doti soggettive, che caratterizzarono il secondo dopoguerra argentino. Fatto sta che accadde, in un processo storico che si rivelò permeabile – e qui c’è il “cuore” del lavoro di Manolo Morlacchi (o quantomeno la parte che più scalda il nostro, di cuore) – alle istanze rivoluzionarie, simboleggiate (ma non esaurite) dalle vicende della famiglia Santucho, quasi una copia anastatica, ma in versione rivoluzionaria, dei Perón. Straordinario laboratorio di teoria e di prassi politica, i Santucho hanno rappresentato la dimostrazione vivente di come le particolari condizioni del contesto argentino spingessero anche una parte di borghesia illuminata e benestante a sposare la causa dei diseredati e degli sfruttati, organizzandoli in un partito e in una compagine militare, arrivando a pagare un prezzo altissimo, per quanto “giustificato” dal livello della sfida lanciata al sistema politico argentino, che era quello – non dimentichiamolo – dei militari, del potere clericale, dei latifondisti, degli interessi economici nordamericani. Per questo motivo il libro di Manolo si pone come una “restituzione” nei confronti dei militanti coinvolti nella mattanza argentina, nel dissanguamento di un’intera generazione, nell’ineffabile capacità occidentale di guardare da un’altra parte, di non rinunciare ai Mondiali di calcio oppure di limitare il proprio dissenso da Pinochet alle magliette rosse dei tennisti di Coppa Davis, mentre il Latino America degli anni Settanta organizzava i pogrom e provava ad azzerare geneticamente l’idea stessa di Rivoluzione. Non solo i giovani, ma persino i loro figli, strappati alle famiglie dei desaparecidos con una scientificità che va oltre il “pragmatismo del male” e pare quasi un monito biblico: ‘Maledetto sia tu, i tuoi figli e i figli dei tuoi figli’. Eppure La linea del fuoco (qui sta uno dei più meritati motivi di vanto del volume) è attento a evitare la narrazione dominante, rispetto a uno dei periodi più oscuri del XX secolo, vale a dire il ricordo frammentato dei singoli e delle singole, che finiscono di default – in questo modo – nella categoria delle “vittime”, soffrendo una seconda e nuova “scomparsa”: quella della dimensione di consapevole militante rivoluzionario. Manolo Morlacchi non si presta alla narrazione per schegge (quebrantos, come da titolo di un peraltro suggestivo volume per Nova Delphi, a cura di Delia Ana Fanego) e riconduce a unitarietà la storia dell’Argentina sovversiva del secondo dopoguerra, ribadendo l’organicità di un percorso pure dipanatosi tra tanti rivoli e molteplici tentativi, vittorie, sconfitte, errori. Senza mai abbandonare, però, una stentorea coscienza di classe e una irriducibilità ad accettare lo stato di cose del tempo, come testimoniato dal cartellino di prigioniero di Mario “Indio” Paz, militante dell’ERP e comandante della Compagna del Monte, quando era recluso a Campo de Mayo: ‘Irrecuperabile’.
La storia del Partito Rivoluzionario dei Lavoratori (PRT) e della sua ala militare, l’Esercito Rivoluzionario del Popolo (ERP), è una storia collettiva, come è inevitabile che sia per la storia di un partito e di un’organizzazione combattente: non è retorica da nobili perdenti, ma parte di quella “restituzione” di cui sopra, citare una canzone dedicata ad Ana María Lanzilotto, Domingo Menna, Benito Urteaga e Liliana Delfino, riportata a p. 199: “Non cercate la mia tomba perché non la troverete. Le mie mani sono quelle che vanno in altre mani sparando. La mia voce è quella che sta gridando, in una rivoluzione, quando è vera, o si trionfa o si muore. Il sogno è sempre intero. E sappiate che morirò solo se voi mollerete, perché chi è morto combattendo vive in ogni compagno”.
Il libro di Manolo non si ferma qui: si pone anche come insegnamento per chi voglia fare ricerca su un contesto o un periodo storico lontano dal proprio, senza per questo dover scegliere tra rigore scientifico e passione militante. L’Autore vi è riuscito partendo dai fili della sua memoria familiare, dal suo essere dentro la storia del movimento rivoluzionario, dalla sua consapevolezza di costituire solo un ingranaggio di quest’ultima. Per questo motivo La linea del fuoco è anche un archivio da aggiornare quotidianamente e da moltiplicare, rifiutando non solo il paradigma dei diritti umani (inevitabilmente allergico a qualsiasi politicità, anche solo progressista), ma anche quella vittimologia che, pur trovandosi spesso a essere la migliore delle narrazioni mainstream possibili, non rende giustizia alla forza delle idee e riduce all’incomprensibilità la frase meravigliosa che chiude la nota dell’Autore, a firma di Lucia Volpi, militante di Lotta Continua, impegnata ad accogliere gli esuli argentini in Italia insieme al marito (Vito) e sorpresa nel sapere che quest’ultimo avesse ricevuto la proposta di andare a combattere in Nicaragua con l’ultimo gruppo sostanzioso di militanti del PRT/ERP. Vito declinò l’offerta, per motivi familiari. “Gli chiesero di partire perché – anche se distanti migliaia di chilometri dall’Argentina – per quello che avevamo fatto ci consideravano parte del Partito”.
Fonte
Coronavirus, occasione per attaccare lotte e diritti dei lavoratori
L’Italia è interessata ormai da molte settimane da una forte pressione mediatica intorno alla cosiddetta epidemia da Coronavirus. Il Governo ha emesso numerose disposizioni per affrontare lo sviluppo dell’epidemia nonostante molti autorevoli ricercatori italiani sostengano non si tratti di una epidemia ma di una normale influenza che non produrrà un numero maggiore di decessi di quelli registrati ogni anno.
In queste settimane sono apparse evidenti in particolare due questioni rilevanti in tema di tutela della salute:
1) la sanità pubblica è stata investita da un grande numero di richieste di intervento e di ricoveri a cui non riesce a fare fronte a causa della chiusura di numerosi ospedali e della riduzione dei posti letto e del personale medico e paramedico che sono stati realizzati nel corso degli anni per favorire la crescita della sanità privata. In questa occasione è diventata evidente a tutti la completa inutilità della sanità privata nel fronteggiare delle emergenze nonostante abbia ricevuto enormi finanziamenti che invece si sottraevano alla sanità pubblica.
2) Il decentramento a livello regionale della sanità pubblica, per favorirne la privatizzazione, ha impedito che ci fosse una regia nazionale di risposta al fenomeno coronavirus ed ha creato confusione e ritardi nel soccorso.
In questo clima vanno registrati due fatti: sono i ricercatori precari, di cui l’USB chiede da anni la stabilizzazione, ad aver dato il maggior contributo nella individuazione del virus e degli strumenti per aggredirlo; i lavoratori della pubblica amministrazione in generale, ma della sanità in particolare, hanno consentito di affrontare la situazione di criticità sociale nonostante da anni siano ferme le assunzioni, non sia stato realizzato il turn over necessario, vivano perennemente in emergenza con salari veramente indecenti.
Gravi però sono le disposizioni emanate dal Governo italiano sotto forma di decreti immediatamente operativi che hanno:
- bloccato ed impedito scioperi, manifestazioni, assemblee, perfino le riunioni ed ogni altra forma di iniziativa politica e sindacale;
- militarizzato completamente il territorio attraverso l’utilizzo dell’esercito per garantire il rispetto delle ordinanze;
- chiuso le scuole e le università praticamente in tutto il nord Italia;
- imposto a migliaia di lavoratori delle zone più esposte al contagio di lavorare da casa, svincolando così l’introduzione dello smart working da ogni contrattazione sindacale e riducendo la possibilità di tutelare i diritti dei lavoratori allontanati dai luoghi di lavoro e realizzando con questo cospicui risparmi per le aziende;
- accelerato le procedure di licenziamenti collettivi e di cassa integrazione, vedi Alitalia e altre aziende strategiche, confidando nella disattenzione e nell’impossibilità di lottare per contrastarle;
- bloccato le importazioni di merci dalla Cina così costringendo molte aziende alla chiusura temporanea per mancanza di approvvigionamenti di materiali e condannando alla cig milioni di lavoratori.
Gli appelli congiunti di queste ore dei padroni e dei sindacati complici a unire le forze lasciando da parte critiche e distinguo non sono altro che il segnale di via libera al governo per proseguire su questa strada, che vede il Paese investito da una ventata reazionaria che rischia di stabilizzare un clima di normalizzazione complessiva della società e quindi di criminalizzazione dei conflitti sociali e lavorativi che respingiamo con forza chiamando i lavoratori alla massima vigilanza e determinazione per impedire il consolidamento di questa evidente tendenza.
Fonte
In queste settimane sono apparse evidenti in particolare due questioni rilevanti in tema di tutela della salute:
1) la sanità pubblica è stata investita da un grande numero di richieste di intervento e di ricoveri a cui non riesce a fare fronte a causa della chiusura di numerosi ospedali e della riduzione dei posti letto e del personale medico e paramedico che sono stati realizzati nel corso degli anni per favorire la crescita della sanità privata. In questa occasione è diventata evidente a tutti la completa inutilità della sanità privata nel fronteggiare delle emergenze nonostante abbia ricevuto enormi finanziamenti che invece si sottraevano alla sanità pubblica.
2) Il decentramento a livello regionale della sanità pubblica, per favorirne la privatizzazione, ha impedito che ci fosse una regia nazionale di risposta al fenomeno coronavirus ed ha creato confusione e ritardi nel soccorso.
In questo clima vanno registrati due fatti: sono i ricercatori precari, di cui l’USB chiede da anni la stabilizzazione, ad aver dato il maggior contributo nella individuazione del virus e degli strumenti per aggredirlo; i lavoratori della pubblica amministrazione in generale, ma della sanità in particolare, hanno consentito di affrontare la situazione di criticità sociale nonostante da anni siano ferme le assunzioni, non sia stato realizzato il turn over necessario, vivano perennemente in emergenza con salari veramente indecenti.
Gravi però sono le disposizioni emanate dal Governo italiano sotto forma di decreti immediatamente operativi che hanno:
- bloccato ed impedito scioperi, manifestazioni, assemblee, perfino le riunioni ed ogni altra forma di iniziativa politica e sindacale;
- militarizzato completamente il territorio attraverso l’utilizzo dell’esercito per garantire il rispetto delle ordinanze;
- chiuso le scuole e le università praticamente in tutto il nord Italia;
- imposto a migliaia di lavoratori delle zone più esposte al contagio di lavorare da casa, svincolando così l’introduzione dello smart working da ogni contrattazione sindacale e riducendo la possibilità di tutelare i diritti dei lavoratori allontanati dai luoghi di lavoro e realizzando con questo cospicui risparmi per le aziende;
- accelerato le procedure di licenziamenti collettivi e di cassa integrazione, vedi Alitalia e altre aziende strategiche, confidando nella disattenzione e nell’impossibilità di lottare per contrastarle;
- bloccato le importazioni di merci dalla Cina così costringendo molte aziende alla chiusura temporanea per mancanza di approvvigionamenti di materiali e condannando alla cig milioni di lavoratori.
Gli appelli congiunti di queste ore dei padroni e dei sindacati complici a unire le forze lasciando da parte critiche e distinguo non sono altro che il segnale di via libera al governo per proseguire su questa strada, che vede il Paese investito da una ventata reazionaria che rischia di stabilizzare un clima di normalizzazione complessiva della società e quindi di criminalizzazione dei conflitti sociali e lavorativi che respingiamo con forza chiamando i lavoratori alla massima vigilanza e determinazione per impedire il consolidamento di questa evidente tendenza.
Fonte
Siria - Erdogan chiede la tregue a Putin
di Chiara Cruciati – il Manifesto
L’attacco aereo che giovedì in tarda serata ha ucciso almeno 33 soldati turchi nella provincia siriana di Idlib ha una tempistica precisa. Appena 24 ore prima il presidente turco Recep Tayyip Erdogan aveva ribadito il suo ultimatum: Damasco deve ritirarsi dalle zone di de-escalation – previste dall’accordo tra Turchia e Russia, siglato a Sochi nell’autunno 2018 – o le truppe turche avanzeranno.
La risposta è stata il bombardamento. Per mano siriana, forse anche russa. Mosca ha precisato ieri che la responsabilità è tutta della Turchia che non aveva informato della presenza di sue truppe tra i miliziani islamisti. Il ministro degli Esteri Lavrov ha addirittura offerto le sue condoglianze.
Ma è difficile pensare che il comando russo non ne fosse a conoscenza. Probabile che abbia voluto ricordare a Erdogan i termini dell’accordo di de-escalation: le 12 postazioni turche in territorio siriano (la maggior parte circondate oggi dall’esercito governativo) erano ben accette in cambio del travaso di islamisti dalla provincia nord-ovest siriana, l’unica ancora fuori dal controllo damasceno.
Erdogan si ritrova con il cerino in mano, dopo il lento ma proficuo lavoro ai fianchi che gli ha fatto l’omologo Putin. Lo ha allontanato da Nato e Stati Uniti, lo ha fatto entrare nella propria orbita e ora lo mette all’angolo a Idlib, l’enorme contraddizione siriana, dove il secondo esercito della Nato protegge qaedisti (l’ex Fronte al-Nusra, apice della piramide di gruppi più o meno ampi e più o meno islamisti) e che tenta di ritagliarsi il suo posto al sole in un paese disastrato.
Il gioco della parti lo sconta la popolazione civile, tre milioni di persone – almeno la metà sfollati da altre zone della Siria – che tentano da mesi la fuga in massa dagli attacchi aerei delle aviazioni governativa e russa. Non tutti ne hanno i mezzi. Un milione di persone (di cui la metà bambini) è riuscito a scappare per ammassarsi a nord, verso il Rojava per metà occupato dai turchi e verso il confine con la Turchia. Le loro condizioni sono terribili, denunciano le organizzazioni umanitarie: mancano rifugi, tende, coperte, medicinali, mentre l’inverno fa scendere le temperature e uccide.
Il governo turco li usa. Ordina di aprire le frontiere per salvarli dai bombardamenti, quando l’obiettivo è un altro, fare pressioni sulla fortezza-Europa perché lo appoggi. Ieri, dopo l’annuncio della morte dei 33 soldati, Ankara ha promesso di rispondere «in ogni modo» con attacchi mirati «a tutte le postazioni note» del governo siriano.
Poco dopo il ministro della difesa Akar rivendicava l’uccisione in 200 attacchi di «309 truppe del regime» (non confermate da altre fonti) e la distruzione di «cinque elicotteri siriani, 23 carri armati, 10 veicoli blindati, 23 cannoni, due sistemi di difesa aerea e tre depositi di armi». Tutto in poche ore, a sentire Ankara, numeri rivolti più alla propria opinione pubblica che al presidente siriano Assad.
Intanto la Russia spostava due fregate da Sebastopoli alle coste siriane. E così ieri, a 12 ore dal bombardamento, Ankara chiedeva alla delegazione russa nella capitale turca un cessate il fuoco immediato mentre Erdogan e Putin si sentivano al telefono.
Un incontro faccia a faccia sarà organizzato al più presto, fa sapere l’ufficio stampa della presidenza turca, per ristabilire il cessate il fuoco (mai realmente entrato in vigore) e fermare la corsa a una fase nuova e devastante del conflitto. Il Cremlino indica una data, il 5 o il 6 marzo, lasciando così intendere il rinvio (o la cancellazione) del vertice a quattro – Erdogan, Putin, Merkel, Macron – previsto (ma mai ufficialmente confermato) del 5 marzo.
I due si sono detti concordi, aggiunge in una nota il Cremlino, sulla necessità di nuove misure per normalizzare la situazione. Mosca pretende da Ankara un passo indietro, vuole che si dissoci dai gruppi islamisti, che li porti via dalle zone di de-escalation e che gli impedisca di colpire l’esercito siriano impegnato nella reconquista.
Prima di chiamare il Cremlino il presidente turco si è rivolto alla Nato, probabilmente per invocare l’applicazione dell’articolo 5 del Trattato atlantico, la difesa di un paese membro. A rispondere è il segretario generale Stoltenberg che ieri ha chiesto a Russia e Siria di fermare l’offensiva su Idlib e «gli attacchi indiscriminati».
Ma non ha parlato affatto di intervento: è la Turchia con gli stivali in un altro paese, difficile parlare di auto-difesa. Senza dimenticare che a quel punto la Nato dovrebbe intervenire contro la Russia e a sostegno – indiretto – della galassia qaedista arroccata da anni a Idlib.
Poi Erdogan ha telefonato alla Casa bianca. Al presidente Trump ha chiesto fatti e non parole. Ma l’amministrazione Usa non pare intenzionata a rigettarsi nel conflitto, in un periodo in cui le relazioni con Ankara sono al minimo storico. Né lo sono gli europei: ieri Erdogan ha raccolto «solidarietà» da Francia, Germania, Gran Bretagna, ma nessun reale sostegno.
Fonte
L’attacco aereo che giovedì in tarda serata ha ucciso almeno 33 soldati turchi nella provincia siriana di Idlib ha una tempistica precisa. Appena 24 ore prima il presidente turco Recep Tayyip Erdogan aveva ribadito il suo ultimatum: Damasco deve ritirarsi dalle zone di de-escalation – previste dall’accordo tra Turchia e Russia, siglato a Sochi nell’autunno 2018 – o le truppe turche avanzeranno.
La risposta è stata il bombardamento. Per mano siriana, forse anche russa. Mosca ha precisato ieri che la responsabilità è tutta della Turchia che non aveva informato della presenza di sue truppe tra i miliziani islamisti. Il ministro degli Esteri Lavrov ha addirittura offerto le sue condoglianze.
Ma è difficile pensare che il comando russo non ne fosse a conoscenza. Probabile che abbia voluto ricordare a Erdogan i termini dell’accordo di de-escalation: le 12 postazioni turche in territorio siriano (la maggior parte circondate oggi dall’esercito governativo) erano ben accette in cambio del travaso di islamisti dalla provincia nord-ovest siriana, l’unica ancora fuori dal controllo damasceno.
Erdogan si ritrova con il cerino in mano, dopo il lento ma proficuo lavoro ai fianchi che gli ha fatto l’omologo Putin. Lo ha allontanato da Nato e Stati Uniti, lo ha fatto entrare nella propria orbita e ora lo mette all’angolo a Idlib, l’enorme contraddizione siriana, dove il secondo esercito della Nato protegge qaedisti (l’ex Fronte al-Nusra, apice della piramide di gruppi più o meno ampi e più o meno islamisti) e che tenta di ritagliarsi il suo posto al sole in un paese disastrato.
Il gioco della parti lo sconta la popolazione civile, tre milioni di persone – almeno la metà sfollati da altre zone della Siria – che tentano da mesi la fuga in massa dagli attacchi aerei delle aviazioni governativa e russa. Non tutti ne hanno i mezzi. Un milione di persone (di cui la metà bambini) è riuscito a scappare per ammassarsi a nord, verso il Rojava per metà occupato dai turchi e verso il confine con la Turchia. Le loro condizioni sono terribili, denunciano le organizzazioni umanitarie: mancano rifugi, tende, coperte, medicinali, mentre l’inverno fa scendere le temperature e uccide.
Il governo turco li usa. Ordina di aprire le frontiere per salvarli dai bombardamenti, quando l’obiettivo è un altro, fare pressioni sulla fortezza-Europa perché lo appoggi. Ieri, dopo l’annuncio della morte dei 33 soldati, Ankara ha promesso di rispondere «in ogni modo» con attacchi mirati «a tutte le postazioni note» del governo siriano.
Poco dopo il ministro della difesa Akar rivendicava l’uccisione in 200 attacchi di «309 truppe del regime» (non confermate da altre fonti) e la distruzione di «cinque elicotteri siriani, 23 carri armati, 10 veicoli blindati, 23 cannoni, due sistemi di difesa aerea e tre depositi di armi». Tutto in poche ore, a sentire Ankara, numeri rivolti più alla propria opinione pubblica che al presidente siriano Assad.
Intanto la Russia spostava due fregate da Sebastopoli alle coste siriane. E così ieri, a 12 ore dal bombardamento, Ankara chiedeva alla delegazione russa nella capitale turca un cessate il fuoco immediato mentre Erdogan e Putin si sentivano al telefono.
Un incontro faccia a faccia sarà organizzato al più presto, fa sapere l’ufficio stampa della presidenza turca, per ristabilire il cessate il fuoco (mai realmente entrato in vigore) e fermare la corsa a una fase nuova e devastante del conflitto. Il Cremlino indica una data, il 5 o il 6 marzo, lasciando così intendere il rinvio (o la cancellazione) del vertice a quattro – Erdogan, Putin, Merkel, Macron – previsto (ma mai ufficialmente confermato) del 5 marzo.
I due si sono detti concordi, aggiunge in una nota il Cremlino, sulla necessità di nuove misure per normalizzare la situazione. Mosca pretende da Ankara un passo indietro, vuole che si dissoci dai gruppi islamisti, che li porti via dalle zone di de-escalation e che gli impedisca di colpire l’esercito siriano impegnato nella reconquista.
Prima di chiamare il Cremlino il presidente turco si è rivolto alla Nato, probabilmente per invocare l’applicazione dell’articolo 5 del Trattato atlantico, la difesa di un paese membro. A rispondere è il segretario generale Stoltenberg che ieri ha chiesto a Russia e Siria di fermare l’offensiva su Idlib e «gli attacchi indiscriminati».
Ma non ha parlato affatto di intervento: è la Turchia con gli stivali in un altro paese, difficile parlare di auto-difesa. Senza dimenticare che a quel punto la Nato dovrebbe intervenire contro la Russia e a sostegno – indiretto – della galassia qaedista arroccata da anni a Idlib.
Poi Erdogan ha telefonato alla Casa bianca. Al presidente Trump ha chiesto fatti e non parole. Ma l’amministrazione Usa non pare intenzionata a rigettarsi nel conflitto, in un periodo in cui le relazioni con Ankara sono al minimo storico. Né lo sono gli europei: ieri Erdogan ha raccolto «solidarietà» da Francia, Germania, Gran Bretagna, ma nessun reale sostegno.
Fonte
Saramago in “Cecità” ha anticipato la psicosi del coronavirus
La psicosi per il coronavirus al momento sembra aver trasformato Milano nel luogo di un romanzo distopico. Gli scaffali vuoti di molti supermercati, la gente in fila per accaparrarsi beni di prima necessità, lo sciacallaggio e gli episodi di sopraffazione e razzismo: stiamo vivendo in uno scenario post-apocalittico in assenza dell’apocalisse. La letteratura, come sappiamo, tratta da secoli il tema dell’epidemia – quella vera, irreparabile e catastrofica – ma il romanzo che più di tutti sembra raccontarci le dinamiche sociali che stiamo affrontando oggi potrebbe essere Cecità di José Saramago.
Un uomo è fermo al semaforo con la sua auto, quando all’improvviso non vede più nulla. È questo l’incipit di Cecità, romanzo uscito nel 1995 con il titolo originale di Ensaio sobre a cegueira (“Saggio sulla cecità”). L’uomo viene accompagnato dal medico, che non riesce però a trovare una spiegazione per quella misteriosa malattia, fin quando non si rende conto di essere stato contagiato anche lui. Stesso destino per tutti i pazienti che sono nella sala d’attesa. Quando la cecità inizia a espandersi in maniera capillare, il governo decide di mettere i ciechi in quarantena. Divisi in gruppi e rinchiusi in edifici fatiscenti, i ciechi tornano a uno stato primitivo. È su queste basi che Saramago realizza una lucida analisi della natura umana, un ritratto che letto in questi giorni, inquieta, perché sembra parlare proprio di noi.
Un tratto distintivo dell’opera è quello di non dare nomi ai personaggi. Lo scrittore portoghese, infatti, identifica i protagonisti attraverso le loro caratteristiche, il mestiere o il ruolo sociale. C’è il medico, il primo malato o paziente zero, la moglie del medico, la ragazza con gli occhiali, il vecchio con la benda. L’epidemia rende l’uomo impersonale, rimuove le sue generalità. Il lettore si interroga su questa scelta, inizialmente la trova tanto originale quanto inverosimile, ma quello che stiamo vivendo in questi giorni è esattamente lo stesso: il paziente zero, il primario, la moglie del paziente zero, il corridore. Non abbiamo più un nome.
Il tema del contagio è stato affrontato da molti scrittori. Senza per forza tornare indietro ai tempi di Manzoni, il Novecento ha dipinto una nuova forma di peste, l’allegoria di qualcosa di più strisciante. Quella di Camus è ad esempio la rappresentazione del male, e nel caso specifico del nazismo. A differenza di Camus, Saramago trascende le implicazioni storiche e politiche, concentrandosi sull’uomo, scarno e nudo. La sua descrizione della quarantena è infatti un saggio antropologico su una specie, la nostra, che è naturalmente incline alla sopraffazione.
Quando il governo consegna il cibo ai ciechi nell’edificio, iniziano a crearsi le fazioni. Il cibo diventa motivo d’ossessione, e lo è anche fuori dal romanzo. Il principale pensiero dei cittadini in seguito ai primi casi del coronavirus è stato quello di razziare gli scaffali dei supermercati, arrivare prima degli altri per mettersi in salvo. Nel romanzo qualsiasi oggetto diventa potenzialmente un’arma di ricatto, di minaccia o di speculazione. I gruppi che detengono il potere lucrano sul cibo e sugli altri beni di necessità. La trasposizione odierna è l’Amuchina venduta su Internet a prezzi esorbitanti, la mascherina fatta passare per un bene di lusso, la commercializzazione della paura.
“È di questa pasta che siamo fatti: metà di indifferenza e metà di cattiveria”, scrive Saramago in un passaggio del romanzo. Le ultime settimane non hanno fatto altro che confermare questo pensiero. L’indifferenza è stato il sentimento iniziale: l’epidemia era in Cina, lontanissima, e le uniche preoccupazioni erano figlie dello sciacallaggio. I politici hanno sfruttato la paura per la personale propaganda, per fare qualche esempio: Salvini si è concentrato sui barconi, sui porti chiusi e sulla diffidenza verso lo straniero; Conte si è invece ripetutamente vantato per le disposizioni rigide del governo; e Renzi ha voluto fare l’eroe silenziando le sue polemiche contro il governo per qualche giorno.
Quando il virus è esploso in Italia, l’indifferenza si è spostata su altri fronti. L’attenzione sul virus e l’allarmismo che ne è derivato ha portato l’uomo a fossilizzarsi su un pericolo imminente ma di piccole dimensioni, dimenticando le emergenze a lungo termine, nettamente più catastrofiche. La vera cecità è non vedere l’Antartide senza neve e i suoi venti gradi, la morte dei bambini in Siria, i diritti umani che continuano a essere calpestati in tutto il mondo. Come scrive Saramago: “È una vecchia abitudine dell’umanità passare accanto ai morti e non vederli”.
La guerra uomo contro uomo che si crea in Cecità non è altro che il trionfo dell’homo homini lupus di Hobbes, della legge del più forte e delle dinamiche sociali che si creano all’interno di un’emergenza. Durante la quarantena un unico gruppo detiene il possesso del potere e tiene gli altri ciechi in una fame costante. È l’egoismo di pochi che ha la meglio sulla sofferenza di molti, nonché la rappresentazione dell’imperialismo e del capitalismo. Si crea inoltre una condizione di discriminazione.
L’uomo non guarda in faccia il dolore degli altri, ma lo usa per rafforzarsi e ferire. Gli episodi di razzismo che hanno colpito la comunità cinese in Italia sono all’ordine del giorno da un mese abbondante. Tra aggressioni fisiche e verbali, divieti immotivati e xenofobia una parte dell’Italia ha mostrato il suo lato più becero. Il monito di Saramago è: “Se non siamo capaci di vivere globalmente come persone, almeno facciamo di tutto per non vivere globalmente come animali”.
Lo sviluppo del romanzo porta i gruppi di ciechi agli inevitabili episodi di violenza, in cui gli uomini vengono picchiati e le donne stuprate. Qui ci si rende conto che la cecità non è una menomazione fisica, non riguarda gli occhi ma una condizione insita nella propria natura. “Secondo me non siamo diventati ciechi, secondo me lo siamo, ciechi che non vedono, ciechi che, pur vedendo, non vedono”. È quindi il buio della ragione, e si palesa ancor di più quando i ciechi abbandonano la quarantena e si ritrovano in uno scenario in cui la città è un tempio del male, con gli uomini a combattere per un tozzo di pane, a occupare abusivamente le case degli altri, a ingannare il prossimo.
L’inganno viene perpetrato in una condizione di instabilità, dove l’essere umano è indifeso, non può affidarsi a nulla se non al suo istinto di sopravvivenza. E così in questi giorni stiamo assistendo alle truffe legate al coronavirus: gente che propone di disinfettare i soldi, persone che si fingono operatori sanitari per entrare nelle case degli anziani, prodotti spacciati per cure miracolose. È più semplice fregare il prossimo quando c’è di mezzo la paura.
Cecità ha poi condotto Saramago, nel 1998, alla vittoria del premio Nobel per la Letteratura. L’eredità dello scrittore, morto nel 2010, è l’insegnamento sul seme della cattiveria, quello che è già presente nell’uomo anche prima della diffusione di un morbo. Se oggi i cinesi vengono presi a bottigliate è perché la violenza repressa degli uomini ha trovato libero sfogo in una situazione di emergenza, o presunta tale. L’uomo attende una giustificazione per esternare i suoi istinti peggiori. Non li crea sul momento, fanno già parte del suo essere.
Saramago è stato in grado di scarnificare l’individuo e mettere in evidenza tutti i suoi limiti, fino a capire che il virus più letale è quello che ci riconduce a uno stadio primitivo, al male inteso come dimora della nostra cecità, quella che non è collegata agli occhi. “Con l’andare del tempo, più le attività di convivenza e gli scambi genetici, abbiamo finito col ficcare la coscienza nel colore del sangue e nel sale delle lacrime, e, come se non bastasse, degli occhi abbiamo fatto una sorta di specchi rivolti all’interno, con il risultato che, spesso, ci mostrano senza riserva ciò che stavamo cercando di negare con la bocca”.
Il coronavirus, quindi, non ci ha reso persone peggiori, ma solo quelle che realmente siamo. L’avvelenatore di pozzi lo era già, così come il violento, lo sciacallo, il razzista o il truffatore. Siamo ciechi, e la speranza è quella di prendere come lezione questa esperienza e, finalmente, aprire gli occhi. Altrimenti la cecità proseguirà anche quando i contagi finiranno e il delirio apocalittico cederà campo alla vita di tutti i giorni, ovvero un’infinita quarantena in cui non riusciamo a vedere oltre il nostro naso.
Fonte
Un uomo è fermo al semaforo con la sua auto, quando all’improvviso non vede più nulla. È questo l’incipit di Cecità, romanzo uscito nel 1995 con il titolo originale di Ensaio sobre a cegueira (“Saggio sulla cecità”). L’uomo viene accompagnato dal medico, che non riesce però a trovare una spiegazione per quella misteriosa malattia, fin quando non si rende conto di essere stato contagiato anche lui. Stesso destino per tutti i pazienti che sono nella sala d’attesa. Quando la cecità inizia a espandersi in maniera capillare, il governo decide di mettere i ciechi in quarantena. Divisi in gruppi e rinchiusi in edifici fatiscenti, i ciechi tornano a uno stato primitivo. È su queste basi che Saramago realizza una lucida analisi della natura umana, un ritratto che letto in questi giorni, inquieta, perché sembra parlare proprio di noi.
Un tratto distintivo dell’opera è quello di non dare nomi ai personaggi. Lo scrittore portoghese, infatti, identifica i protagonisti attraverso le loro caratteristiche, il mestiere o il ruolo sociale. C’è il medico, il primo malato o paziente zero, la moglie del medico, la ragazza con gli occhiali, il vecchio con la benda. L’epidemia rende l’uomo impersonale, rimuove le sue generalità. Il lettore si interroga su questa scelta, inizialmente la trova tanto originale quanto inverosimile, ma quello che stiamo vivendo in questi giorni è esattamente lo stesso: il paziente zero, il primario, la moglie del paziente zero, il corridore. Non abbiamo più un nome.
Il tema del contagio è stato affrontato da molti scrittori. Senza per forza tornare indietro ai tempi di Manzoni, il Novecento ha dipinto una nuova forma di peste, l’allegoria di qualcosa di più strisciante. Quella di Camus è ad esempio la rappresentazione del male, e nel caso specifico del nazismo. A differenza di Camus, Saramago trascende le implicazioni storiche e politiche, concentrandosi sull’uomo, scarno e nudo. La sua descrizione della quarantena è infatti un saggio antropologico su una specie, la nostra, che è naturalmente incline alla sopraffazione.
Quando il governo consegna il cibo ai ciechi nell’edificio, iniziano a crearsi le fazioni. Il cibo diventa motivo d’ossessione, e lo è anche fuori dal romanzo. Il principale pensiero dei cittadini in seguito ai primi casi del coronavirus è stato quello di razziare gli scaffali dei supermercati, arrivare prima degli altri per mettersi in salvo. Nel romanzo qualsiasi oggetto diventa potenzialmente un’arma di ricatto, di minaccia o di speculazione. I gruppi che detengono il potere lucrano sul cibo e sugli altri beni di necessità. La trasposizione odierna è l’Amuchina venduta su Internet a prezzi esorbitanti, la mascherina fatta passare per un bene di lusso, la commercializzazione della paura.
“È di questa pasta che siamo fatti: metà di indifferenza e metà di cattiveria”, scrive Saramago in un passaggio del romanzo. Le ultime settimane non hanno fatto altro che confermare questo pensiero. L’indifferenza è stato il sentimento iniziale: l’epidemia era in Cina, lontanissima, e le uniche preoccupazioni erano figlie dello sciacallaggio. I politici hanno sfruttato la paura per la personale propaganda, per fare qualche esempio: Salvini si è concentrato sui barconi, sui porti chiusi e sulla diffidenza verso lo straniero; Conte si è invece ripetutamente vantato per le disposizioni rigide del governo; e Renzi ha voluto fare l’eroe silenziando le sue polemiche contro il governo per qualche giorno.
Quando il virus è esploso in Italia, l’indifferenza si è spostata su altri fronti. L’attenzione sul virus e l’allarmismo che ne è derivato ha portato l’uomo a fossilizzarsi su un pericolo imminente ma di piccole dimensioni, dimenticando le emergenze a lungo termine, nettamente più catastrofiche. La vera cecità è non vedere l’Antartide senza neve e i suoi venti gradi, la morte dei bambini in Siria, i diritti umani che continuano a essere calpestati in tutto il mondo. Come scrive Saramago: “È una vecchia abitudine dell’umanità passare accanto ai morti e non vederli”.
La guerra uomo contro uomo che si crea in Cecità non è altro che il trionfo dell’homo homini lupus di Hobbes, della legge del più forte e delle dinamiche sociali che si creano all’interno di un’emergenza. Durante la quarantena un unico gruppo detiene il possesso del potere e tiene gli altri ciechi in una fame costante. È l’egoismo di pochi che ha la meglio sulla sofferenza di molti, nonché la rappresentazione dell’imperialismo e del capitalismo. Si crea inoltre una condizione di discriminazione.
L’uomo non guarda in faccia il dolore degli altri, ma lo usa per rafforzarsi e ferire. Gli episodi di razzismo che hanno colpito la comunità cinese in Italia sono all’ordine del giorno da un mese abbondante. Tra aggressioni fisiche e verbali, divieti immotivati e xenofobia una parte dell’Italia ha mostrato il suo lato più becero. Il monito di Saramago è: “Se non siamo capaci di vivere globalmente come persone, almeno facciamo di tutto per non vivere globalmente come animali”.
Lo sviluppo del romanzo porta i gruppi di ciechi agli inevitabili episodi di violenza, in cui gli uomini vengono picchiati e le donne stuprate. Qui ci si rende conto che la cecità non è una menomazione fisica, non riguarda gli occhi ma una condizione insita nella propria natura. “Secondo me non siamo diventati ciechi, secondo me lo siamo, ciechi che non vedono, ciechi che, pur vedendo, non vedono”. È quindi il buio della ragione, e si palesa ancor di più quando i ciechi abbandonano la quarantena e si ritrovano in uno scenario in cui la città è un tempio del male, con gli uomini a combattere per un tozzo di pane, a occupare abusivamente le case degli altri, a ingannare il prossimo.
L’inganno viene perpetrato in una condizione di instabilità, dove l’essere umano è indifeso, non può affidarsi a nulla se non al suo istinto di sopravvivenza. E così in questi giorni stiamo assistendo alle truffe legate al coronavirus: gente che propone di disinfettare i soldi, persone che si fingono operatori sanitari per entrare nelle case degli anziani, prodotti spacciati per cure miracolose. È più semplice fregare il prossimo quando c’è di mezzo la paura.
Cecità ha poi condotto Saramago, nel 1998, alla vittoria del premio Nobel per la Letteratura. L’eredità dello scrittore, morto nel 2010, è l’insegnamento sul seme della cattiveria, quello che è già presente nell’uomo anche prima della diffusione di un morbo. Se oggi i cinesi vengono presi a bottigliate è perché la violenza repressa degli uomini ha trovato libero sfogo in una situazione di emergenza, o presunta tale. L’uomo attende una giustificazione per esternare i suoi istinti peggiori. Non li crea sul momento, fanno già parte del suo essere.
Saramago è stato in grado di scarnificare l’individuo e mettere in evidenza tutti i suoi limiti, fino a capire che il virus più letale è quello che ci riconduce a uno stadio primitivo, al male inteso come dimora della nostra cecità, quella che non è collegata agli occhi. “Con l’andare del tempo, più le attività di convivenza e gli scambi genetici, abbiamo finito col ficcare la coscienza nel colore del sangue e nel sale delle lacrime, e, come se non bastasse, degli occhi abbiamo fatto una sorta di specchi rivolti all’interno, con il risultato che, spesso, ci mostrano senza riserva ciò che stavamo cercando di negare con la bocca”.
Il coronavirus, quindi, non ci ha reso persone peggiori, ma solo quelle che realmente siamo. L’avvelenatore di pozzi lo era già, così come il violento, lo sciacallo, il razzista o il truffatore. Siamo ciechi, e la speranza è quella di prendere come lezione questa esperienza e, finalmente, aprire gli occhi. Altrimenti la cecità proseguirà anche quando i contagi finiranno e il delirio apocalittico cederà campo alla vita di tutti i giorni, ovvero un’infinita quarantena in cui non riusciamo a vedere oltre il nostro naso.
Fonte
La Turchia usa i profughi come arma di guerra
Il governo turco ha annunciato che non fermerà più i migranti che vogliono andare in Europa e il ministero degli esteri fa sapere che “alcuni migranti e richiedenti asilo hanno iniziato a muoversi verso i confini” con l’Ue.
La Grecia ha rafforzato i controlli ai propri confini, la Bulgaria ha dispiegato rinforzi della gendarmeria alle frontiere terrestri e marittime con la Turchia per contenere la pressione migratoria in arrivo, mentre la Ue e la Nato chiedono di “interrompere l’escalation a Idlib” ma sostanzialmente si schierano a sostegno della Turchia contro la Siria.
“Se si va a guardare bene chi combatte a Idlib e provincia, dove nel 2011 vivevano 1,2 milioni di persone e adesso almeno tre, con profughi e ribelli provenienti da ogni dove” – scrive oggi un osservatore autorevole come Alberto Negri – “un eventuale appoggio a Erdogan significa anche un aiuto alla coalizione jihadista di Hayat Tahir al Sham, l’ex fronte al Nusra affiliato ad al Qaeda. Gli stessi soldati turchi sono mescolati ai ribelli, e non è una novità perché Erdogan ha appoggiato in questi anni i jihadisti e fatto intese con l’Isis in funzione anti-curda e anti-Assad”.
Da settimane l’esercito siriano, con il supporto aereo e d'artiglieria della Russia, ha lanciato una vasta offensiva nella provincia di Idlib, ultima roccaforte ancora sotto il controllo delle milizie jihadiste sostenute da Ankara e da queste apertamente sostenute con armi, munizioni, appoggio logistico e una crescente presenza di militari e mezzi pesanti dell’esercito turco, riferisce il sito specializzato AnalisiDifesa.it.
“I militari turchi non dovrebbero stare fuori dalle loro postazioni di osservazione nella provincia siriana di Idlib”, ha sottolineato il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, avvallando di fatto quanto dichiarato dal governo siriano, il quale accusa le truppe di Ankara (altri 3 militari turchi erano stati uccisi il 26 febbraio in situazioni analoghe) di combattere al fianco delle milizie jihadiste a Idlib.
Alcuni paesi europei – e ancora una volta non tutti – in una dichiarazione antecedente l’inizio della riunione del Consiglio di Sicurezza dell’Onu scrivono che: “Condanniamo l’attacco ai soldati turchi. Non ci sarà soluzione militare al conflitto”.
“La Turchia ha il nostro pieno supporto nel rispondere per autodifesa ad un attacco ingiustificato”, ha detto l’ambasciatrice americana all’Onu, Kelly Craft, durante la riunione di emergenza del Consiglio di Sicurezza sulla Siria. “Gli Usa condannano nei termini più forti possibili l’attacco barbaro contro le forze turche”, ha aggiunto, chiedendo “un cessate fuoco immediato e duraturo”, e domandando “alla Russia di tenere a terra i suoi aerei da guerra”.
I presidenti di Russia e Turchia, Vladimir Putin e Recep Tayyip Erdogan, hanno avuto una conversazione telefonica sulla tesissima situazione in Siria “dedicata alla necessità di fare tutto per soddisfare l’accordo iniziale sulla zona di de-escalation di Idlib” riferisce il ministro degli Esteri russo, Serghiei Lavrov, ripreso dalle agenzie russe.
Fonte
La Grecia ha rafforzato i controlli ai propri confini, la Bulgaria ha dispiegato rinforzi della gendarmeria alle frontiere terrestri e marittime con la Turchia per contenere la pressione migratoria in arrivo, mentre la Ue e la Nato chiedono di “interrompere l’escalation a Idlib” ma sostanzialmente si schierano a sostegno della Turchia contro la Siria.
“Se si va a guardare bene chi combatte a Idlib e provincia, dove nel 2011 vivevano 1,2 milioni di persone e adesso almeno tre, con profughi e ribelli provenienti da ogni dove” – scrive oggi un osservatore autorevole come Alberto Negri – “un eventuale appoggio a Erdogan significa anche un aiuto alla coalizione jihadista di Hayat Tahir al Sham, l’ex fronte al Nusra affiliato ad al Qaeda. Gli stessi soldati turchi sono mescolati ai ribelli, e non è una novità perché Erdogan ha appoggiato in questi anni i jihadisti e fatto intese con l’Isis in funzione anti-curda e anti-Assad”.
Da settimane l’esercito siriano, con il supporto aereo e d'artiglieria della Russia, ha lanciato una vasta offensiva nella provincia di Idlib, ultima roccaforte ancora sotto il controllo delle milizie jihadiste sostenute da Ankara e da queste apertamente sostenute con armi, munizioni, appoggio logistico e una crescente presenza di militari e mezzi pesanti dell’esercito turco, riferisce il sito specializzato AnalisiDifesa.it.
“I militari turchi non dovrebbero stare fuori dalle loro postazioni di osservazione nella provincia siriana di Idlib”, ha sottolineato il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, avvallando di fatto quanto dichiarato dal governo siriano, il quale accusa le truppe di Ankara (altri 3 militari turchi erano stati uccisi il 26 febbraio in situazioni analoghe) di combattere al fianco delle milizie jihadiste a Idlib.
Alcuni paesi europei – e ancora una volta non tutti – in una dichiarazione antecedente l’inizio della riunione del Consiglio di Sicurezza dell’Onu scrivono che: “Condanniamo l’attacco ai soldati turchi. Non ci sarà soluzione militare al conflitto”.
“La Turchia ha il nostro pieno supporto nel rispondere per autodifesa ad un attacco ingiustificato”, ha detto l’ambasciatrice americana all’Onu, Kelly Craft, durante la riunione di emergenza del Consiglio di Sicurezza sulla Siria. “Gli Usa condannano nei termini più forti possibili l’attacco barbaro contro le forze turche”, ha aggiunto, chiedendo “un cessate fuoco immediato e duraturo”, e domandando “alla Russia di tenere a terra i suoi aerei da guerra”.
I presidenti di Russia e Turchia, Vladimir Putin e Recep Tayyip Erdogan, hanno avuto una conversazione telefonica sulla tesissima situazione in Siria “dedicata alla necessità di fare tutto per soddisfare l’accordo iniziale sulla zona di de-escalation di Idlib” riferisce il ministro degli Esteri russo, Serghiei Lavrov, ripreso dalle agenzie russe.
Fonte
28/02/2020
Algeria - La protesta compie un anno
di Karim Metref
Il 22 febbraio è l’anniversario della rivolta nonviolenta algerina. E oggi 21 febbraio è il 53esimo venerdì di mobilitazione popolare. Un anno intero! Un anno in cui ogni venerdì e ogni martedì, senza sosta, la gente è uscita per le strade: uomini, donne, vecchi e giovani... per chiedere una “Algeria libera e democratica”, per “uno Stato civile e non militare” e per la “partenza di tutti”. Dove «tutti» vuol dire che se ne deve andare l'intero apparato di Stato, generato da 60 anni di dominio dei militari e delle organizzazioni politiche a loro leali.
No al quinto mandato
Comincia tutto come una protesta contro l’annuncio della candidatura del vecchio presidente Abdelaziz Bouteflika per un quinto mandato consecutivo. Il presidente, ormai malato e in stato vegetativo, ha regnato per 20 anni. Andando persino a cambiare due volte la Costituzione algerina che prevedeva solo due mandati consecutivi, per permettersi prima un terzo mandato e poi un quarto. (“Boutef per gli amici” scritto nel 2005 per Peace reporter).
20 anni in cui il vecchio politico algerino, caduto in disgrazia alla fine degli anni '70, è rientrato nel 1999 dal suo esilio dorato negli Emirati Arabi dove era scappato con la cassa del ministero degli Esteri: è rientrato appoggiato dalla “comunità internazionale” per gestire la fine della guerra civile che aveva stremato il Paese negli anni '90, e sopratutto la spartizione dell’abbondante torta di petrolio e gas con le multinazionali. 20 anni in cui ha accumulato tutti i poteri nelle sue mani, e per fare ciò si è circondato di un clan di parenti, amici, complici, soci in affari... sporchi, che hanno saccheggiato l’Algeria.
I prezzi alti degli idrocarburi durante il primo decennio del 2000 hanno portato nelle casse pubbliche montagne di soldi facili che hanno generato un mercato dopato: innalzamento dei consumi interni, commesse miliardarie per infrastrutture, case, strade, ferrovie, ponti, aeroporti. Il Paese è un cantiere: un cantiere di appalti truccati, lavori strapagati e spesso mal eseguiti.
Nonostante lo spreco e la corruzione fossero alla luce del sole e conosciute da tutti, nei suoi primi mandati il presidente Bouteflika ha goduto di grande popolarità. La manna petrolifera serviva anche a comprare la pace sociale e a comprare o zittire ogni forma di opposizione.
Le 3 cause che hanno fatto traboccare il vaso
La misura colma che ha portato all’inizio delle proteste nel 2019 è dovuta a un insieme di cose.
Il primo elemento è il fatto che quel presidente forte, carismatico che ha saputo mettere in secondo piano i Generali e a concentrare nelle sue mani tanto potere, si è ammalato all’inizio del suo terzo mandato. Una serie di ictus l’hanno progressivamente ridotto a uno stato di totale indigenza.
Dal 2013, quella figura – che era onnipresente sui media e che girava il paese come una trottola in cerca di consensi – è scomparsa. A decidere e a parlare a nome suo sono subentrati personaggi della cerchia famigliare. Il suo clan, incapace di proporre un’altra figura così forte e carismatica, lo ha imposto, pur malato, per un quarto mandato. Ma coscienti dell’avvicinarsi della loro fine, hanno impiegato il quarto mandato per depredare il Paese, arraffando tutto sul loro passaggio.
Il secondo elemento che ha portato al malcontento generale è la diminuzione delle entrate generate dalla vendita di petrolio e gas. I giacimenti eccessivamente sfruttati cominciano a produrre di meno e nel contempo i prezzi sul mercato, per effetto della crisi globale del 2008, cominciano a scendere.
Le entrate diminuiscono ma il ritmo degli sprechi continua. In pochi anni il fondo sovrano di circa 200 miliardi di dollari accumulato durante gli anni di vacche grasse si scioglie come neve al sole. Per compensare le perdite, come si fa ovunque ormai, invece di ridurre le spese inutili – infrastrutture faraoniche, costi del governo, spese militari, malversazioni, corruzione ecc. – si va a tagliare le spese sociale, sanità, scuole... Lo Stato provvidenza non lo è più e la popolarità scende.
Il terzo elemento è l’emergere di una nuova generazione che non ha vissuto la guerra civile. Una delle basi della popolarità di Bouteflika è dovuta al fatto che è stato presentato all’opinione pubblica come colui che ha finalizzato gli accordi di pace tra l’esercito e i Gruppi Islamici Armati (Gia). Per anni le popolazioni delle zone che hanno conosciuto gli orrori della guerra senza nome negli anni '90 hanno sentito una specie di debito nei confronti di Bouteflika: aveva portato la pace e la prosperità.
I giovani che oggi hanno 20 anni sono nati all’inizio degli anni 2000 quindi alla fine della guerra. Non subiscono la paura di un ritorno a una situazione che non hanno conosciuto. E della «prosperità» di Bouteflika stanno oggi vedendo solo gli effetti distruttivi: casse dello Stato vuote; sanità, università, scuola disastrate; formazione di una classe arrogante di ladri oligarchi e pluri miliardari...
Inizia tutto da Kherrata, di nuovo
Tutti questi elementi messi insieme hanno portato a un malcontento generalizzato, che girava sui social network, nei caffè, negli stadi. Tutti – compresi molti riparti interni al regime algerino – vedono la possibilità di un quinto mandato del «presidente mummia» come un vero e proprio disastro.
La prima scintilla partì il 16 febbraio 2019 sotto forma di un corteo popolare che ha camminato per le strade della piccola località di Kherrata, in mezzo alle montagne, a 300 km a Est di Algeri. Una località molto conosciuta nonostante le sue modeste dimensioni. Kherrata, con Guelma e Setif era luogo delle manifestazioni per l’indipendenza nel 1945 che portarono a uno dei maggiori massacri compiuti dal colonialismo francese: decine di migliaia di morti, fra i 20 e i 40 mila secondo le varie stime. Quei massacri, compiuti dall’esercito francese e da milizie di coloni, furono il punto di svolta fra le popolazioni indigene algerine e il colonialismo francese: svolta che portò, 9 anni dopo, all’inizio della guerra di liberazione.
Ancora una volta la cittadina di Kherrata si trova a essere all’inizio di una rivolta nazionale. Questa volta non contro un nemico straniero ma contro un sistema di governo descritto come ladro, violento, bugiardo e incompetente.
Subito dopo quella marcia partono appelli di vari gruppi e persone sui social media per una grande mobilitazione nazionale contro il 5° mandato. La mobilitazione del 22 ha luogo in varie città del Paese. Ma è timida. I numeri sono piccoli e la parola d’ordine è solo «No al 5° mandato». Ma tutto si svolge nella calma e con buon umore. La polizia non carica e i manifestanti sono del tutto pacifici. La mobilitazione viene anche coperta da alcuni media privati, proprietà di persone vicine alle alte sfere. Si capisce che anche da dentro il regime si vuole accompagnare il vecchio presidente verso la porta.
Il venerdì seguente le manifestazioni cambiarono aspetto. L’assenza di repressione e la copertura mediatica portarono in strada molta più gente: uomini e donne, famiglie intere. I cortei diventano molto più imponenti, colorati, gioiosi: belli!
Un anno che ha sconvolto l’Algeria
La cosa dura da un anno. Ogni venerdì esce la popolazione prima a migliaia, poi a centinaia di migliaia, qualche volta a milioni. I martedì escono gli studenti di tutti gli atenei, spesso accompagnati da molti altri cittadini. Il regime ha accolto prima con uno sguardo compiacente queste manifestazioni. Erano per loro una ragione valida per sbarazzarsi del vecchio presidente e il suo stretto giro, diventati imbarazzanti un po’ per tutti. Ma poco a poco le rivendicazioni del hirak sono diventate più radicali ed è arrivata la repressione.
Di risultati ce ne sono stati parecchi. Bouteflika (o chi per lui) ha annunciato di non presentarsi alle prossime elezioni, poi ha presentato le dimissioni, prima dell’elezione. La magistratura ha aperto processi per corruzione, frodi e abusi vari e ha fatto arrestare il fratello del presidente, Said Bouteflika, vari oligarchi corrotti del loro giro, i responsabili dei servizi segreti e vari ministri, parlamentari e responsabili del regime.
Una vera e propria operazione «mani pulite» all’Algerina. Ma solo a metà – dice la strada – perché quando un clan della mafia se la prende con un altro non si chiama giustizia ma regolamento di conti. La giustizia è ancora “quella del telefono”, dicono, cioè che arresta e libera su chiamata di chi ha il potere civile o militare.
“Dobbiamo toglierli tutti!” è diventata la nuova parola d’ordine condivisa dal hirak, dopo la caduta di Bouteflika.
Dopo le dimissioni del presidente, al potere (almeno in apparenza) è rimasto un uomo solo: il Generale-maggiore Ahmed Gaid Salah, capo dello Stato Maggiore e vice-ministro della Difesa.
Procedendo con un colpo alla botte e uno al cerchio, ha continuato a lanciare messaggi favorevoli alla rivoluzione del popolo, promettendo di proteggere i manifestanti pacifici, e nello stesso tempo a reprimere in modo mirato cercando di dividere i manifestanti per appartenenza linguistica e culturale o fra laici e islamisti, arrestando alcune figure ritenute più attive e più carismatiche.
Come piano di uscita dalla crisi ha proposto un percorso che passa per la rielezione a breve di un nuovo presidente della repubblica, che avrebbe poi lavorato alla riscrittura della Costituzione e all’adozione di riforme che andrebbero nella direzione delle rivendicazioni del popolo.
Il hirak da parte sua ha rimandato al mittente le proposte del generale. Non basta un nuovo presidente eletto con le solite elezioni truccate. Ci vuole una Costituente, incaricata di scrivere una nuova Costituzione, nominare un governo di transizione e organizzare poi – secondo la nuova Costituzione – elezioni vere, trasparenti e libere.
Quella solidarietà internazionale che non è mai arrivata
A livello internazionale, la protesta algerina è del tutto ignorata. Gli stessi network arabi che negli anni delle cosiddette Primavere facevano dirette di 24 ore da Tunisi, Cairo, Bengasi e Aleppo... oggi a malapena ne parlano nei telegiornali.
Tutti fanno finta di niente, guardano dall’altra parte. O ancora peggio ne approfittano per mettere il regime alle strette e pretendere più concessioni per le multinazionali in cambio del silenzio.
Una delle prove di questa strategia adottata dalle potenze straniere è l’adozione in fretta e furia, in piena fase di transizione, da un Parlamento quasi dimezzato e che nessuno riconosce più, della nuova legge sugli idrocarburi che rompe la regola della soglia massima del 49% di partecipazione per le multinazionale nello sfruttamento dei giacimenti. Cioè fino a quest’anno, le multinazionali, in Algeria dovevano lavorare sempre in partenariato con la Sonatrach, la società pubblica nazionale. E la Sonatrach doveva sempre avere minimo 51% di quote societarie. Con la nuova legge, le multinazionali straniere possono sfruttare i giacimenti anche al 100%. È l’annullamento definitivo della nazionalizzazione delle risorse, decisa nel 1971.
Altro problema della nuova legge è che apre anche alla possibilità di sfruttare le risorse di gas non convenzionali, dette comunemente “gas di scisto“, con l’uso della discutibilissima tecnica della fratturazione idraulica o fracking.
L’introduzione di questa attività, richiesta a gran voce dalle multinazionali, Total in primis, è stata finora bloccata dalle proteste popolari degli abitanti del sud, preoccupati dall’alto rischio di inquinamento della falda acquifera fossile, un vero mare sotterraneo, che si trova tra le zone Sud dell’Algeria, Tunisia e Libia, e che è rimasta quasi come unica fonte di vita di quelle aree povere d'acqua di superficie.
Come altro effetto perverso delle pressioni internazionali sul regime Algerino, si può citare l’affaire appena scoppiato della raffineria di Augusta. Questa vecchia installazione, proprietà della Exxon, che si trova in Sicilia, ad Augusta, doveva chiudere e rischiava di lasciare a casa centinaia di lavoratori, mettendo in crisi la città siciliana.
Invece quella raffineria vecchia, arrugginita, fuori norma e non adatta a trattare il petrolio algerino è stata acquistata in una trattativa segreta dalla compagnia algerina di petrolio Sonatrach per la bellezza di 725 milioni di dollari.
L’intento dichiarato sarebbe far uscire l’Algeria dalla dipendenza dalla benzina di importazione. Il risultato è un impianto vecchio pagato come uno nuovo, che ha bisogno di altri investimenti per essere messo a norma e, colmo dei colmi, l’Algeria – che produce una delle qualità migliori di greggio al mondo – avrebbe bisogno di importare petrolio “pesante” dai Paesi del Golfo per farlo funzionare.
La verità è che la trattativa è stata fatta alla fine del 2018, quindi nel momento di massima fragilità del clan Bouteflika e l’ex amministratore delegato della Sonatrach Abdelmoumen Ould Kaddour, già immischiato in vari altri affari loschi, con questo regalo alla Exxon si è guadagnato un biglietto per andare a godere dell’impunità negli USA, in compagnia dell’ex ministro dell’energia Chakib Khellil anche lui indagato in vari affari gravi, tra i quali quello di Sonatrach-ENI-Saipem, e che vive tranquillo, protetto dai suoi amici petrolieri texani.
Tutto questo è un luminoso esempio dell’aiuto portato dai leader del «mondo libero», sempre pronti a bombardare per le buone cause, ai popoli in lotta che vogliono però decidere da soli del proprio destino.
Due strade parallele
Per tornare alla lotta politica, ancora oggi le due proposte di uscita dalla crisi, quella del Hirak e quella del regime, continuano il loro cammino in parallelo.
I militari si accaniscono a mettere in atto la loro proposta. Hanno indetto le elezioni per il 12 dicembre scorso. Non essendosi presentato nessun candidato serio, hanno messo 5 fantocci e mantenuto l’appuntamento elettorale nonostante la massiccia mobilitazione per il loro boicottaggio.
Il 12 dicembre i seggi erano vuoti e in molti Comuni, non sono stati proprio aperti. Centinaia di sindaci hanno rifiutato di organizzare il voto. Invece l’esercito ha mobilitato giovani della leva vestiti in civile, per dare una illusione di affluenza in alcuni seggi più visibili. Oltre ai militari, hanno costretto al voto tutti i funzionari della polizia e delle amministrazioni pubbliche.
In alcuni luoghi le vecchie reti di manipolazione hanno funzionato come da sempre, con centinaia di persone pagate per fare le comparse, in una messa in scena patetica, in una gara di cui tutti sapevano il risultato in anticipo.
Il risultato è una consultazione elettorale nella quale il numero di votanti dichiarato sarebbe di oltre il 39% ma in cui in verità partecipò un numero stimato a 8-9 per cento degli aventi diritto, secondo fonti ben informate. Un presidente «eletto» secondo le vecchie modalità delle elezioni preconfezionate ma che la popolazione non riconosce.
La più grande realizzazione è il Hirak stesso
Oggi, un anno dopo le prime manifestazioni del 2019, la mobilitazione resta alta pur mostrando segni di stanchezza qui e là. Del resto un anno intero è un tempo lunghissimo e molti movimenti muoiono dopo le prime settimane o cadono nell’impazienza e nella trappola della violenza. Il fatto che il Hirak algerino sia arrivato a questo traguardo mantenendo la propria unità, le sue parole d’ordine, il suo carattere combattivo ma non violento, è già una grande vittoria. Altra vittoria sono le migliaia di cittadini che si sono svegliati dall'apatia e che parlano e praticano politica, tutti i giorni, sulla piazza pubblica, per le strade nei caffè... Ovunque.
Le ultime mobilitazioni di queste dimensioni in Algeria risalgono a 30 anni fa. Ma era tutt’altra canzone. Allora centinaia di migliaia di militanti islamisti bloccavano le strade e gridavano “Dawla Islamiya”, Stato Islamico.
Portando milioni di algerini in piazza, con le loro differenze di generazione, di genere, di culture e di lingue, a gridare tutti all’unisono: Algeria libera democratica... ebbene questa già è una bella realizzazione.
Ma la strada verso quella Algeria libera e democratica che tanti vogliamo resta ancora lunga. Molto lunga. Ma di questo, credo che anche la gente del hirak sia molto cosciente.
Fonte
Il 22 febbraio è l’anniversario della rivolta nonviolenta algerina. E oggi 21 febbraio è il 53esimo venerdì di mobilitazione popolare. Un anno intero! Un anno in cui ogni venerdì e ogni martedì, senza sosta, la gente è uscita per le strade: uomini, donne, vecchi e giovani... per chiedere una “Algeria libera e democratica”, per “uno Stato civile e non militare” e per la “partenza di tutti”. Dove «tutti» vuol dire che se ne deve andare l'intero apparato di Stato, generato da 60 anni di dominio dei militari e delle organizzazioni politiche a loro leali.
No al quinto mandato
Comincia tutto come una protesta contro l’annuncio della candidatura del vecchio presidente Abdelaziz Bouteflika per un quinto mandato consecutivo. Il presidente, ormai malato e in stato vegetativo, ha regnato per 20 anni. Andando persino a cambiare due volte la Costituzione algerina che prevedeva solo due mandati consecutivi, per permettersi prima un terzo mandato e poi un quarto. (“Boutef per gli amici” scritto nel 2005 per Peace reporter).
20 anni in cui il vecchio politico algerino, caduto in disgrazia alla fine degli anni '70, è rientrato nel 1999 dal suo esilio dorato negli Emirati Arabi dove era scappato con la cassa del ministero degli Esteri: è rientrato appoggiato dalla “comunità internazionale” per gestire la fine della guerra civile che aveva stremato il Paese negli anni '90, e sopratutto la spartizione dell’abbondante torta di petrolio e gas con le multinazionali. 20 anni in cui ha accumulato tutti i poteri nelle sue mani, e per fare ciò si è circondato di un clan di parenti, amici, complici, soci in affari... sporchi, che hanno saccheggiato l’Algeria.
I prezzi alti degli idrocarburi durante il primo decennio del 2000 hanno portato nelle casse pubbliche montagne di soldi facili che hanno generato un mercato dopato: innalzamento dei consumi interni, commesse miliardarie per infrastrutture, case, strade, ferrovie, ponti, aeroporti. Il Paese è un cantiere: un cantiere di appalti truccati, lavori strapagati e spesso mal eseguiti.
Nonostante lo spreco e la corruzione fossero alla luce del sole e conosciute da tutti, nei suoi primi mandati il presidente Bouteflika ha goduto di grande popolarità. La manna petrolifera serviva anche a comprare la pace sociale e a comprare o zittire ogni forma di opposizione.
Le 3 cause che hanno fatto traboccare il vaso
La misura colma che ha portato all’inizio delle proteste nel 2019 è dovuta a un insieme di cose.
Il primo elemento è il fatto che quel presidente forte, carismatico che ha saputo mettere in secondo piano i Generali e a concentrare nelle sue mani tanto potere, si è ammalato all’inizio del suo terzo mandato. Una serie di ictus l’hanno progressivamente ridotto a uno stato di totale indigenza.
Dal 2013, quella figura – che era onnipresente sui media e che girava il paese come una trottola in cerca di consensi – è scomparsa. A decidere e a parlare a nome suo sono subentrati personaggi della cerchia famigliare. Il suo clan, incapace di proporre un’altra figura così forte e carismatica, lo ha imposto, pur malato, per un quarto mandato. Ma coscienti dell’avvicinarsi della loro fine, hanno impiegato il quarto mandato per depredare il Paese, arraffando tutto sul loro passaggio.
Il secondo elemento che ha portato al malcontento generale è la diminuzione delle entrate generate dalla vendita di petrolio e gas. I giacimenti eccessivamente sfruttati cominciano a produrre di meno e nel contempo i prezzi sul mercato, per effetto della crisi globale del 2008, cominciano a scendere.
Le entrate diminuiscono ma il ritmo degli sprechi continua. In pochi anni il fondo sovrano di circa 200 miliardi di dollari accumulato durante gli anni di vacche grasse si scioglie come neve al sole. Per compensare le perdite, come si fa ovunque ormai, invece di ridurre le spese inutili – infrastrutture faraoniche, costi del governo, spese militari, malversazioni, corruzione ecc. – si va a tagliare le spese sociale, sanità, scuole... Lo Stato provvidenza non lo è più e la popolarità scende.
Il terzo elemento è l’emergere di una nuova generazione che non ha vissuto la guerra civile. Una delle basi della popolarità di Bouteflika è dovuta al fatto che è stato presentato all’opinione pubblica come colui che ha finalizzato gli accordi di pace tra l’esercito e i Gruppi Islamici Armati (Gia). Per anni le popolazioni delle zone che hanno conosciuto gli orrori della guerra senza nome negli anni '90 hanno sentito una specie di debito nei confronti di Bouteflika: aveva portato la pace e la prosperità.
I giovani che oggi hanno 20 anni sono nati all’inizio degli anni 2000 quindi alla fine della guerra. Non subiscono la paura di un ritorno a una situazione che non hanno conosciuto. E della «prosperità» di Bouteflika stanno oggi vedendo solo gli effetti distruttivi: casse dello Stato vuote; sanità, università, scuola disastrate; formazione di una classe arrogante di ladri oligarchi e pluri miliardari...
Inizia tutto da Kherrata, di nuovo
Tutti questi elementi messi insieme hanno portato a un malcontento generalizzato, che girava sui social network, nei caffè, negli stadi. Tutti – compresi molti riparti interni al regime algerino – vedono la possibilità di un quinto mandato del «presidente mummia» come un vero e proprio disastro.
La prima scintilla partì il 16 febbraio 2019 sotto forma di un corteo popolare che ha camminato per le strade della piccola località di Kherrata, in mezzo alle montagne, a 300 km a Est di Algeri. Una località molto conosciuta nonostante le sue modeste dimensioni. Kherrata, con Guelma e Setif era luogo delle manifestazioni per l’indipendenza nel 1945 che portarono a uno dei maggiori massacri compiuti dal colonialismo francese: decine di migliaia di morti, fra i 20 e i 40 mila secondo le varie stime. Quei massacri, compiuti dall’esercito francese e da milizie di coloni, furono il punto di svolta fra le popolazioni indigene algerine e il colonialismo francese: svolta che portò, 9 anni dopo, all’inizio della guerra di liberazione.
Ancora una volta la cittadina di Kherrata si trova a essere all’inizio di una rivolta nazionale. Questa volta non contro un nemico straniero ma contro un sistema di governo descritto come ladro, violento, bugiardo e incompetente.
Subito dopo quella marcia partono appelli di vari gruppi e persone sui social media per una grande mobilitazione nazionale contro il 5° mandato. La mobilitazione del 22 ha luogo in varie città del Paese. Ma è timida. I numeri sono piccoli e la parola d’ordine è solo «No al 5° mandato». Ma tutto si svolge nella calma e con buon umore. La polizia non carica e i manifestanti sono del tutto pacifici. La mobilitazione viene anche coperta da alcuni media privati, proprietà di persone vicine alle alte sfere. Si capisce che anche da dentro il regime si vuole accompagnare il vecchio presidente verso la porta.
Il venerdì seguente le manifestazioni cambiarono aspetto. L’assenza di repressione e la copertura mediatica portarono in strada molta più gente: uomini e donne, famiglie intere. I cortei diventano molto più imponenti, colorati, gioiosi: belli!
Un anno che ha sconvolto l’Algeria
La cosa dura da un anno. Ogni venerdì esce la popolazione prima a migliaia, poi a centinaia di migliaia, qualche volta a milioni. I martedì escono gli studenti di tutti gli atenei, spesso accompagnati da molti altri cittadini. Il regime ha accolto prima con uno sguardo compiacente queste manifestazioni. Erano per loro una ragione valida per sbarazzarsi del vecchio presidente e il suo stretto giro, diventati imbarazzanti un po’ per tutti. Ma poco a poco le rivendicazioni del hirak sono diventate più radicali ed è arrivata la repressione.
Di risultati ce ne sono stati parecchi. Bouteflika (o chi per lui) ha annunciato di non presentarsi alle prossime elezioni, poi ha presentato le dimissioni, prima dell’elezione. La magistratura ha aperto processi per corruzione, frodi e abusi vari e ha fatto arrestare il fratello del presidente, Said Bouteflika, vari oligarchi corrotti del loro giro, i responsabili dei servizi segreti e vari ministri, parlamentari e responsabili del regime.
Una vera e propria operazione «mani pulite» all’Algerina. Ma solo a metà – dice la strada – perché quando un clan della mafia se la prende con un altro non si chiama giustizia ma regolamento di conti. La giustizia è ancora “quella del telefono”, dicono, cioè che arresta e libera su chiamata di chi ha il potere civile o militare.
“Dobbiamo toglierli tutti!” è diventata la nuova parola d’ordine condivisa dal hirak, dopo la caduta di Bouteflika.
Dopo le dimissioni del presidente, al potere (almeno in apparenza) è rimasto un uomo solo: il Generale-maggiore Ahmed Gaid Salah, capo dello Stato Maggiore e vice-ministro della Difesa.
Procedendo con un colpo alla botte e uno al cerchio, ha continuato a lanciare messaggi favorevoli alla rivoluzione del popolo, promettendo di proteggere i manifestanti pacifici, e nello stesso tempo a reprimere in modo mirato cercando di dividere i manifestanti per appartenenza linguistica e culturale o fra laici e islamisti, arrestando alcune figure ritenute più attive e più carismatiche.
Come piano di uscita dalla crisi ha proposto un percorso che passa per la rielezione a breve di un nuovo presidente della repubblica, che avrebbe poi lavorato alla riscrittura della Costituzione e all’adozione di riforme che andrebbero nella direzione delle rivendicazioni del popolo.
Il hirak da parte sua ha rimandato al mittente le proposte del generale. Non basta un nuovo presidente eletto con le solite elezioni truccate. Ci vuole una Costituente, incaricata di scrivere una nuova Costituzione, nominare un governo di transizione e organizzare poi – secondo la nuova Costituzione – elezioni vere, trasparenti e libere.
Quella solidarietà internazionale che non è mai arrivata
A livello internazionale, la protesta algerina è del tutto ignorata. Gli stessi network arabi che negli anni delle cosiddette Primavere facevano dirette di 24 ore da Tunisi, Cairo, Bengasi e Aleppo... oggi a malapena ne parlano nei telegiornali.
Tutti fanno finta di niente, guardano dall’altra parte. O ancora peggio ne approfittano per mettere il regime alle strette e pretendere più concessioni per le multinazionali in cambio del silenzio.
Una delle prove di questa strategia adottata dalle potenze straniere è l’adozione in fretta e furia, in piena fase di transizione, da un Parlamento quasi dimezzato e che nessuno riconosce più, della nuova legge sugli idrocarburi che rompe la regola della soglia massima del 49% di partecipazione per le multinazionale nello sfruttamento dei giacimenti. Cioè fino a quest’anno, le multinazionali, in Algeria dovevano lavorare sempre in partenariato con la Sonatrach, la società pubblica nazionale. E la Sonatrach doveva sempre avere minimo 51% di quote societarie. Con la nuova legge, le multinazionali straniere possono sfruttare i giacimenti anche al 100%. È l’annullamento definitivo della nazionalizzazione delle risorse, decisa nel 1971.
Altro problema della nuova legge è che apre anche alla possibilità di sfruttare le risorse di gas non convenzionali, dette comunemente “gas di scisto“, con l’uso della discutibilissima tecnica della fratturazione idraulica o fracking.
L’introduzione di questa attività, richiesta a gran voce dalle multinazionali, Total in primis, è stata finora bloccata dalle proteste popolari degli abitanti del sud, preoccupati dall’alto rischio di inquinamento della falda acquifera fossile, un vero mare sotterraneo, che si trova tra le zone Sud dell’Algeria, Tunisia e Libia, e che è rimasta quasi come unica fonte di vita di quelle aree povere d'acqua di superficie.
Come altro effetto perverso delle pressioni internazionali sul regime Algerino, si può citare l’affaire appena scoppiato della raffineria di Augusta. Questa vecchia installazione, proprietà della Exxon, che si trova in Sicilia, ad Augusta, doveva chiudere e rischiava di lasciare a casa centinaia di lavoratori, mettendo in crisi la città siciliana.
Invece quella raffineria vecchia, arrugginita, fuori norma e non adatta a trattare il petrolio algerino è stata acquistata in una trattativa segreta dalla compagnia algerina di petrolio Sonatrach per la bellezza di 725 milioni di dollari.
L’intento dichiarato sarebbe far uscire l’Algeria dalla dipendenza dalla benzina di importazione. Il risultato è un impianto vecchio pagato come uno nuovo, che ha bisogno di altri investimenti per essere messo a norma e, colmo dei colmi, l’Algeria – che produce una delle qualità migliori di greggio al mondo – avrebbe bisogno di importare petrolio “pesante” dai Paesi del Golfo per farlo funzionare.
La verità è che la trattativa è stata fatta alla fine del 2018, quindi nel momento di massima fragilità del clan Bouteflika e l’ex amministratore delegato della Sonatrach Abdelmoumen Ould Kaddour, già immischiato in vari altri affari loschi, con questo regalo alla Exxon si è guadagnato un biglietto per andare a godere dell’impunità negli USA, in compagnia dell’ex ministro dell’energia Chakib Khellil anche lui indagato in vari affari gravi, tra i quali quello di Sonatrach-ENI-Saipem, e che vive tranquillo, protetto dai suoi amici petrolieri texani.
Tutto questo è un luminoso esempio dell’aiuto portato dai leader del «mondo libero», sempre pronti a bombardare per le buone cause, ai popoli in lotta che vogliono però decidere da soli del proprio destino.
Due strade parallele
Per tornare alla lotta politica, ancora oggi le due proposte di uscita dalla crisi, quella del Hirak e quella del regime, continuano il loro cammino in parallelo.
I militari si accaniscono a mettere in atto la loro proposta. Hanno indetto le elezioni per il 12 dicembre scorso. Non essendosi presentato nessun candidato serio, hanno messo 5 fantocci e mantenuto l’appuntamento elettorale nonostante la massiccia mobilitazione per il loro boicottaggio.
Il 12 dicembre i seggi erano vuoti e in molti Comuni, non sono stati proprio aperti. Centinaia di sindaci hanno rifiutato di organizzare il voto. Invece l’esercito ha mobilitato giovani della leva vestiti in civile, per dare una illusione di affluenza in alcuni seggi più visibili. Oltre ai militari, hanno costretto al voto tutti i funzionari della polizia e delle amministrazioni pubbliche.
In alcuni luoghi le vecchie reti di manipolazione hanno funzionato come da sempre, con centinaia di persone pagate per fare le comparse, in una messa in scena patetica, in una gara di cui tutti sapevano il risultato in anticipo.
Il risultato è una consultazione elettorale nella quale il numero di votanti dichiarato sarebbe di oltre il 39% ma in cui in verità partecipò un numero stimato a 8-9 per cento degli aventi diritto, secondo fonti ben informate. Un presidente «eletto» secondo le vecchie modalità delle elezioni preconfezionate ma che la popolazione non riconosce.
La più grande realizzazione è il Hirak stesso
Oggi, un anno dopo le prime manifestazioni del 2019, la mobilitazione resta alta pur mostrando segni di stanchezza qui e là. Del resto un anno intero è un tempo lunghissimo e molti movimenti muoiono dopo le prime settimane o cadono nell’impazienza e nella trappola della violenza. Il fatto che il Hirak algerino sia arrivato a questo traguardo mantenendo la propria unità, le sue parole d’ordine, il suo carattere combattivo ma non violento, è già una grande vittoria. Altra vittoria sono le migliaia di cittadini che si sono svegliati dall'apatia e che parlano e praticano politica, tutti i giorni, sulla piazza pubblica, per le strade nei caffè... Ovunque.
Le ultime mobilitazioni di queste dimensioni in Algeria risalgono a 30 anni fa. Ma era tutt’altra canzone. Allora centinaia di migliaia di militanti islamisti bloccavano le strade e gridavano “Dawla Islamiya”, Stato Islamico.
Portando milioni di algerini in piazza, con le loro differenze di generazione, di genere, di culture e di lingue, a gridare tutti all’unisono: Algeria libera democratica... ebbene questa già è una bella realizzazione.
Ma la strada verso quella Algeria libera e democratica che tanti vogliamo resta ancora lunga. Molto lunga. Ma di questo, credo che anche la gente del hirak sia molto cosciente.
Fonte
Brancaccio - Propagazione versus recessione?
RAI Radio Uno – ERESIE, 28 febbraio 2020. Sull’impatto economico del
coronavirus non è vero che gli economisti e le istituzioni non sono
ancora in grado di valutare. Per esempio, un paper pubblicato dalla
Commissione europea stima che una pandemia con caratteristiche non
troppo lontane dal Covid-19 possa determinare una caduta della
produzione tra l’uno e mezzo e il due e mezzo percento in un anno (“The macroeconomic effects of a pandemic in Europe”. European Commission).
Il modello di previsione è quello standard dell’Ecofin e può essere
criticato sotto molti aspetti, ma questo studio condivide con tutti gli
altri una tesi corretta: quanto più le autorità cercano di abbattere il
tasso di propagazione del virus a colpi di quarantene, serrate dei
negozi, chiusure delle scuole e blocchi stradali, tanto più allora si
interrompono i circuiti della produzione e della spesa e si alimentano i
moltiplicatori della recessione. Una soluzione per questo dilemma
amletico per fortuna esiste: un massiccio piano di investimenti
pubblici. Ma in Europa a quanto pare non l’hanno ancora compreso. Il
commento dell’economista Emiliano Brancaccio dell’Università del Sannio.
Fonte
Fonte
Hunters: la serie che racconta di nazisti salvati in USA
Niente ti scuote di più dal torpore che una serie tv che racconta verità in sequenze pulp su quello che il revisionismo nazista nega ancora oggi: i nazisti sono stati salvati e protetti dalle alte sfere americane per servirsi di scienziati e medici, lasciando che sperimentassero ancora sulla gente relegata nei bassifondi, persone di colore e poveri. I nazisti sono stati salvati nell’operazione PiperClip e uno dei nomi è quello di chi però (eh, si, però) portò alla Nasa gli americani sulla luna. Alcuni nomi erano quelli che dopo aver gasato milioni di persone nei campi di concentramento negli Usa contribuivano a ricerche su armi di distruzione di massa.
Noi sappiamo, perchè l’abbiamo studiato, che in America negli anni settanta ancora si praticavano sperimentazioni e sterilizzazioni coatte sulle persone di colore e latine per evitare che sporcassero la bianchezza americana. Sappiamo che donne di colore e latine venivano private dell’utero nelle carceri a loro insaputa. Sappiamo che non è poi così assurdo che ci siano state persone razziste che abbiano dato vita al pensiero unico nazista che regna ancora oggi.
Ma sappiamo che l’epoca che corrisponde alla “lotta al comunismo” riguarda anche l’Italia dove i governi proteggevano gli stragisti fascisti e i nazi si alleavano con i mafiosi per sabotare e ammazzare gente che lottava per i diritti civili*. Tutto con la benedizione degli Stati Uniti. Sappiamo quanta ipocrisia regni attorno alla giornata della memoria quando gente razzista si fa fotografare assieme ai rappresentanti delle vittime della Shoah. Sappiamo quanto sia ancora vivo l’odio contro persone ebree, nere, musulmane, latine, lesbiche, gay, trans, donne e persone che lottano per difendere ancora oggi i diritti civili.
Sappiamo molte cose ma è difficile comunicarlo. Forse una serie del genere potrà insegnare qualcosa a chi la memoria l’ha persa da un pezzo o a chi crede che quello che sta scritto sui libri di storia sia propaganda “comunista”. Forse potrà dire a molti quanto il negazionismo nazista abbia radici profonde. Forse.
Vi consiglio di vederlo. Pace e bene a tutti.
Ps: mi chiedo, ma il processo di Norimberga, con solo una ventina di processati su migliaia di assassini in libertà assimilati in Usa, non pare una presa per i fondelli?
Fonte
C'erano pure i diritti sociali... come a Portella della Ginestra.
Noi sappiamo, perchè l’abbiamo studiato, che in America negli anni settanta ancora si praticavano sperimentazioni e sterilizzazioni coatte sulle persone di colore e latine per evitare che sporcassero la bianchezza americana. Sappiamo che donne di colore e latine venivano private dell’utero nelle carceri a loro insaputa. Sappiamo che non è poi così assurdo che ci siano state persone razziste che abbiano dato vita al pensiero unico nazista che regna ancora oggi.
Ma sappiamo che l’epoca che corrisponde alla “lotta al comunismo” riguarda anche l’Italia dove i governi proteggevano gli stragisti fascisti e i nazi si alleavano con i mafiosi per sabotare e ammazzare gente che lottava per i diritti civili*. Tutto con la benedizione degli Stati Uniti. Sappiamo quanta ipocrisia regni attorno alla giornata della memoria quando gente razzista si fa fotografare assieme ai rappresentanti delle vittime della Shoah. Sappiamo quanto sia ancora vivo l’odio contro persone ebree, nere, musulmane, latine, lesbiche, gay, trans, donne e persone che lottano per difendere ancora oggi i diritti civili.
Sappiamo molte cose ma è difficile comunicarlo. Forse una serie del genere potrà insegnare qualcosa a chi la memoria l’ha persa da un pezzo o a chi crede che quello che sta scritto sui libri di storia sia propaganda “comunista”. Forse potrà dire a molti quanto il negazionismo nazista abbia radici profonde. Forse.
Vi consiglio di vederlo. Pace e bene a tutti.
Ps: mi chiedo, ma il processo di Norimberga, con solo una ventina di processati su migliaia di assassini in libertà assimilati in Usa, non pare una presa per i fondelli?
Fonte
C'erano pure i diritti sociali... come a Portella della Ginestra.
Coronavirus in Italia, la serie tv 4/ Milano o Amity Island?
quarto episodio: Milano o Amity Island?
Nello storico primo film della serie Lo squalo ci sono tanti episodi che attirano attenzione da decenni. Non a caso si tratta del film che ha fatto conoscere Spielberg al mondo con un lavoro che è anche una grande allegoria dei timori della crisi economica dell’epoca. Allegoria che si accende con la ragazza trascinata a fondo dallo squalo, all’inizio del film, che rappresenta l’inizio dell’era delle grandi paure dopo la stagione spensierata degli anni ’60 (con i giovani del falò notturno sulla spiaggia come allusione proprio a quell’epoca). Nello squalo c’è una celeberrima situazione che rappresenta bene i dilemmi che si ripropongono oggi ai tempi del coronavirus. Le autorità di Amity Island, dopo aver capito della presenza e della pericolosità dello squalo che si era mangiato la ragazza, dichiarano l’emergenza finita una volta che uno squalo più piccolo era stato catturato. E questo giusto in tempo per poter autorizzare l’inizio della stagione balneare di punta. Naturalmente l’arrivo dei turisti altro non è che l’inizio del grande pasto dello squalo, quello vero: l’emergenza economica, ovvero la fretta di avviare la grande stagione dei guadagni turistici, non aveva fatto i conti con la realtà.
In queste ore in Lombardia si sono visti diversi segnali: “Milano reagisce“, “si rialza“, “dichiara finita la stagione dell’emergenza” (meno di una settimana ndr) sui media principali assieme alle richieste di ripresa dell’attività produttiva, di sgravi fiscali, finanziamenti etc. da parte dell’impresa per “ripartire subito” perchè “un fine settimana di shopping è un messaggio d’amore per Milano“. Insomma, l’isolamento dei focolai lombardi è considerato a Milano, per quanto i casi di infezione aumentino e gli ospedali investiti abbiano diverse criticità, qualcosa di utile e sufficiente per “la ripresa“.
Intanto possiamo dire che i crolli delle borse per la “ripresa” non promettono niente di buono. Poi vedremo se si tratterà di Milano che si rialza dopo aver isolato i focolai oppure se saremo nella nostra Amity Island. Un paio di cose sono certe: la prima è che le filierie produttive, dell’export e della globalizzazione, possono restare ferme solo per pochi giorni, la seconda è che la confusione regna sovrana in una società a differenti velocità, con esigenze fortemente differenziate, così marcate da far perdere al primo sguardo l’impressione di un qualcosa di unitario.
Fonte
Nello storico primo film della serie Lo squalo ci sono tanti episodi che attirano attenzione da decenni. Non a caso si tratta del film che ha fatto conoscere Spielberg al mondo con un lavoro che è anche una grande allegoria dei timori della crisi economica dell’epoca. Allegoria che si accende con la ragazza trascinata a fondo dallo squalo, all’inizio del film, che rappresenta l’inizio dell’era delle grandi paure dopo la stagione spensierata degli anni ’60 (con i giovani del falò notturno sulla spiaggia come allusione proprio a quell’epoca). Nello squalo c’è una celeberrima situazione che rappresenta bene i dilemmi che si ripropongono oggi ai tempi del coronavirus. Le autorità di Amity Island, dopo aver capito della presenza e della pericolosità dello squalo che si era mangiato la ragazza, dichiarano l’emergenza finita una volta che uno squalo più piccolo era stato catturato. E questo giusto in tempo per poter autorizzare l’inizio della stagione balneare di punta. Naturalmente l’arrivo dei turisti altro non è che l’inizio del grande pasto dello squalo, quello vero: l’emergenza economica, ovvero la fretta di avviare la grande stagione dei guadagni turistici, non aveva fatto i conti con la realtà.
In queste ore in Lombardia si sono visti diversi segnali: “Milano reagisce“, “si rialza“, “dichiara finita la stagione dell’emergenza” (meno di una settimana ndr) sui media principali assieme alle richieste di ripresa dell’attività produttiva, di sgravi fiscali, finanziamenti etc. da parte dell’impresa per “ripartire subito” perchè “un fine settimana di shopping è un messaggio d’amore per Milano“. Insomma, l’isolamento dei focolai lombardi è considerato a Milano, per quanto i casi di infezione aumentino e gli ospedali investiti abbiano diverse criticità, qualcosa di utile e sufficiente per “la ripresa“.
Intanto possiamo dire che i crolli delle borse per la “ripresa” non promettono niente di buono. Poi vedremo se si tratterà di Milano che si rialza dopo aver isolato i focolai oppure se saremo nella nostra Amity Island. Un paio di cose sono certe: la prima è che le filierie produttive, dell’export e della globalizzazione, possono restare ferme solo per pochi giorni, la seconda è che la confusione regna sovrana in una società a differenti velocità, con esigenze fortemente differenziate, così marcate da far perdere al primo sguardo l’impressione di un qualcosa di unitario.
Fonte
Iscriviti a:
Commenti (Atom)