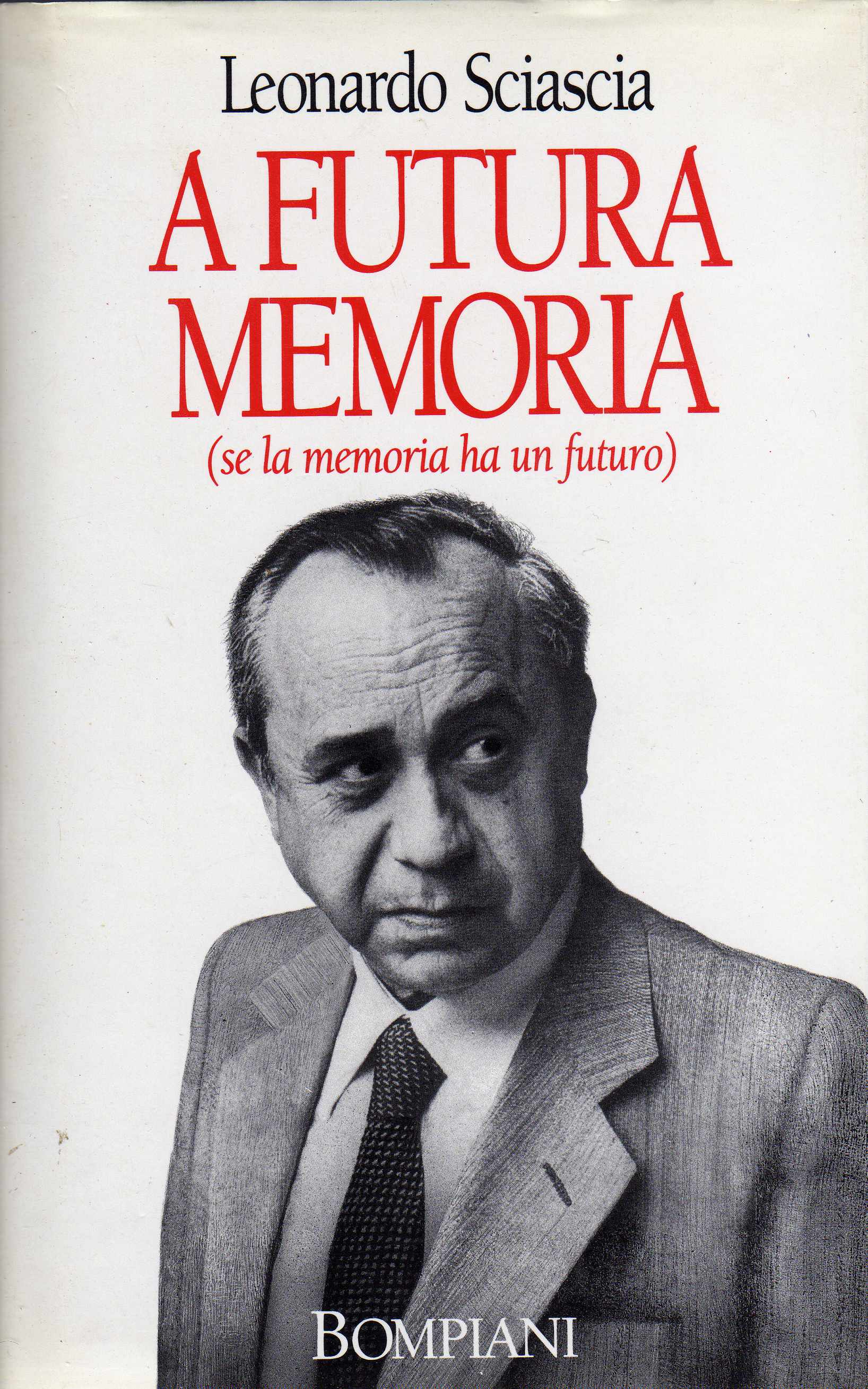Presentazione
Analisi, opinioni, fatti e (più di rado) arte da una prospettiva di classe.
30/11/2019
Gaza - Hamas annulla la Marcia del Ritorno, ma la protesta continua
di Michele Giorgio - il Manifesto
Non appartengono ad alcun partito, sono ragazzini, alcuni poco più che bambini. Il venerdì corrono urlando, alcuni stringendo una bandiera nella mano, verso le barriere di demarcazione con Israele. Senza alcun timore, come se non rischiassero la vita ad ogni metro percorso. E ormai non badano più alle decisioni, politiche e «diplomatiche», del movimento islamico Hamas che per il terzo venerdì consecutivo ha annullato le proteste popolari contro il blocco di Gaza per non turbare le trattative indirette che ha ripreso con Israele. Sul piatto c’è una tregua a lunga durata destinata a non cambiare la condizione di Gaza di grande prigione a cielo aperto ma solo a «migliorare» il disastro umanitario che si è abbattuto su due milioni di civili palestinesi dimenticati dal mondo. Donald Trump che in tre anni ha tagliato tutti i fondi Usa destinati ai palestinesi, all’improvviso ha regalato a Gaza, con pelosa generosità, un ospedale da campo in fase di allestimento non lontano dal valico di Erez, intorno al quale regna sempre un fitto mistero. A Gaza sussurrano che i particolari e le finalità del progetto, favorito dalla mediazione del Qatar e approvato da Israele, sarebbero conosciuti solo ai vertici di Hamas.
Fahad al Astal, 16 anni, viso di bambino, è caduto ieri nella giornata internazionale a sostegno del popolo palestinese, stabilita dalle Nazioni Unite. È l’ultimo ragazzo ucciso dal fuoco dei tiratori scelti israeliani appostati sulle dune a ridosso delle barriere. I suoi compagni dicono che ha lanciato un urlo prima di accasciarsi al suolo, centrato in pieno all’addome. Inutile la corsa all’ospedale, è morto in pochi minuti. Aveva cominciato la sua corsa verso il proiettile che lo ha ammazzato da Al Adwa, all’altezza di Khan Younis, uno campo di tende allestiti nel marzo 2018 per la Grande Marcia del Ritorno. Laconica la versione israeliana dell’accaduto: «Alcune decine di persone si sono affollate in un punto nel sud in prossimità dei reticolati di confine. I soldati hanno notato che cercavano di sabotarli e hanno reagito con mezzi di dispersione di dimostrazioni, ricorrendo fra l’altro a proiettili Ruger». Il 16enne Al Astal stava «sabotando» i reticolati? I palestinesi negano con forza. Ieri in un ospedale è spirato anche Riad Sarsawi, 30 anni, ferito da un bombardamento israeliano durante l’ultima escalation tra Israele e Gaza. Non era un civile ma un militante del Jihad Islamica. Sale a 36 il bilancio totale palestinesi uccisi in quei giorni.
Non c’è un comunicato dell’esercito invece sugli atti di vandalismo avvenuti giovedì notte in villaggi palestinesi della Cisgiordania, attribuiti a coloni israeliani. A Taibeh (Ramallah), un’automobile è stata data alle fiamme: nelle vicinanze una scritta ostile in lingua ebraica. Nella zona di Nablus decine di ulivi sono stati sradicati e i palestinesi puntano il dito contro gli abitanti del vicino avamposto coloniale di Rachelim. Atti che si stanno moltiplicando e che si aggiungono a quelli del recente passato. A condannarli sono stati anche i rappresentanti delle chiese cristiane in Terra Santa che li hanno definiti «atti razzisti di vandalismo» e chiesto di portare di fronte alla giustizia non solo chi compie gesti del genere ma anche coloro che incitano alla violenza.
Fonte
Non appartengono ad alcun partito, sono ragazzini, alcuni poco più che bambini. Il venerdì corrono urlando, alcuni stringendo una bandiera nella mano, verso le barriere di demarcazione con Israele. Senza alcun timore, come se non rischiassero la vita ad ogni metro percorso. E ormai non badano più alle decisioni, politiche e «diplomatiche», del movimento islamico Hamas che per il terzo venerdì consecutivo ha annullato le proteste popolari contro il blocco di Gaza per non turbare le trattative indirette che ha ripreso con Israele. Sul piatto c’è una tregua a lunga durata destinata a non cambiare la condizione di Gaza di grande prigione a cielo aperto ma solo a «migliorare» il disastro umanitario che si è abbattuto su due milioni di civili palestinesi dimenticati dal mondo. Donald Trump che in tre anni ha tagliato tutti i fondi Usa destinati ai palestinesi, all’improvviso ha regalato a Gaza, con pelosa generosità, un ospedale da campo in fase di allestimento non lontano dal valico di Erez, intorno al quale regna sempre un fitto mistero. A Gaza sussurrano che i particolari e le finalità del progetto, favorito dalla mediazione del Qatar e approvato da Israele, sarebbero conosciuti solo ai vertici di Hamas.
Fahad al Astal, 16 anni, viso di bambino, è caduto ieri nella giornata internazionale a sostegno del popolo palestinese, stabilita dalle Nazioni Unite. È l’ultimo ragazzo ucciso dal fuoco dei tiratori scelti israeliani appostati sulle dune a ridosso delle barriere. I suoi compagni dicono che ha lanciato un urlo prima di accasciarsi al suolo, centrato in pieno all’addome. Inutile la corsa all’ospedale, è morto in pochi minuti. Aveva cominciato la sua corsa verso il proiettile che lo ha ammazzato da Al Adwa, all’altezza di Khan Younis, uno campo di tende allestiti nel marzo 2018 per la Grande Marcia del Ritorno. Laconica la versione israeliana dell’accaduto: «Alcune decine di persone si sono affollate in un punto nel sud in prossimità dei reticolati di confine. I soldati hanno notato che cercavano di sabotarli e hanno reagito con mezzi di dispersione di dimostrazioni, ricorrendo fra l’altro a proiettili Ruger». Il 16enne Al Astal stava «sabotando» i reticolati? I palestinesi negano con forza. Ieri in un ospedale è spirato anche Riad Sarsawi, 30 anni, ferito da un bombardamento israeliano durante l’ultima escalation tra Israele e Gaza. Non era un civile ma un militante del Jihad Islamica. Sale a 36 il bilancio totale palestinesi uccisi in quei giorni.
Non c’è un comunicato dell’esercito invece sugli atti di vandalismo avvenuti giovedì notte in villaggi palestinesi della Cisgiordania, attribuiti a coloni israeliani. A Taibeh (Ramallah), un’automobile è stata data alle fiamme: nelle vicinanze una scritta ostile in lingua ebraica. Nella zona di Nablus decine di ulivi sono stati sradicati e i palestinesi puntano il dito contro gli abitanti del vicino avamposto coloniale di Rachelim. Atti che si stanno moltiplicando e che si aggiungono a quelli del recente passato. A condannarli sono stati anche i rappresentanti delle chiese cristiane in Terra Santa che li hanno definiti «atti razzisti di vandalismo» e chiesto di portare di fronte alla giustizia non solo chi compie gesti del genere ma anche coloro che incitano alla violenza.
Fonte
MES incostituzionale, oltre che suicida
Alla fine, oltre ad essere assurdamente svantaggioso (per l’Italia e altri paesi) il trattato che riforma il Meccanismo Europeo di Stabilità (Mes) è anche incostituzionale. Sia nel contenuto sia nell’iter procedurale.
In più, risulta essere la prova inconfutabile dell’idiozia contrattuale della nostra “classe politica”, pronta a firmare quel che gli altri partner europei – a cominciare ovviamente da quelli più forti, la Germania – si guardano bene dal sottoscrivere.
Un’analisi costituzionale e non soltanto economica del testo solleva infatti “delicate questioni di legittimità costituzionale e di uguaglianza dell’Italia nei rapporti internazionali”. Parole che appaiono sull’editoriale di Milano Finanza, a firma di Guido Salerno Aletta (L’Unione dei diseguali), non in qualche scantinato leghista.
In ballo ci sono due “piccoli dettagli” come il principio di sovranità (chi comanda dentro i confini dello Stato) e il ruolo del Parlamento, cui la sovranità popolare viene delegata con il normale processo elettorale.
Da sempre, l’Italia firma i trattati europei senza una vera discussione parlamentare (addirittura a Camere chiuse, come avvenne per il Trattato di Maastricht!) e sicuramente senza alcun esame della Corte Costituzionale.
Tanto per restare nell’esempio tipico, la Germania agisce in modo opposto, tanto che – come nel 2012, quando fu decisa la struttura istituzionale del Mes ancora oggi vigente – il Bundestag approvò il trattato solo il 27 settembre, dopo una sentenza dell’Alta Corte che metteva rigidi paletti all’approvazione del trattato stesso.
L’Italia invece lo aveva approvato il 23 luglio, tra le tante cosette che un Parlamento con le valige in mano, pronto a traslocare in qualche spiaggia assolta, vota senza neanche starci a pensare un attimo.
La corte tedesca poneva infatti due condizioni, come ricorda Salerno Aletta: «la necessità che ogni incremento dell’ammontare della dotazione dell’Esm fosse preventivamente ed esplicitamente approvato dal Parlamento tedesco». Perché quando si parla di impegnare soldi pubblici, foss’anche per un’istituzione europea, il Parlamento deve farlo con tutta la consapevolezza e la formalità necessaria.
E «la necessità di assicurare una sufficiente influenza parlamentare sulla maniera in cui vengono gestiti i fondi». Ossia: non è che noi (la Germania) mettiamo soldi nostri e poi qualcun altro decide come spenderli; in ogni passaggio noi (la Germania) vogliamo decidere a chi si danno, come, perché e in che modo debbono essere restituiti.
Per maggiore sicurezza pretesero la nomina di Klaus Regling a capo del Mes.
Ma non basta. La stessa Corte Costituzionale germanica mise altre tre condizioni: “nello strumento di ratifica del Trattato si sarebbe dovuta inserire una riserva formale che recepisse le condizioni di merito stabilite dalla Corte medesima; occorreva inoltre inserirvi la clausola secondo cui la Germania non desidera essere vincolata da quanto stabilito dal Trattato medesimo nella sua interezza se dette riserve dovessero risultare inefficaci sul piano del diritto internazionale; infine, si precisava che le altre Parti che avevano già ratificato il Trattato avrebbero dovuto esprimersi sulle riserve poste dalla Germania, accettandole o meno.”
Della serie: “partner europei, avete capito che noi non ci accolleremo nessun carico senza prima vedere se ci conviene?”
In ogni caso, bontà loro, veniva dato per scontato che anche gli altri paesi avrebbero potuto avanzare le stesse “riserve”, limitando così le funzioni del Mes.
Ma quando mai... Dall’Italia non venne neanche un vagito, figuriamoci una perplessità. Non sarebbe stato facile, perché “non sarebbe stata sufficiente la sola dichiarazione ministeriale di accettazione unilaterale delle riserve tedesche, resa senza l’assenso preventivo del Parlamento”. Altrimenti “sarebbe intervenuta, senza averne titolo, su un atto del Presidente della Repubblica”, ossia la firma al trattato.
In altre parole, la “diseguaglianza tra [finti] uguali” ha nell’Unione Europea una lunga storia, fatta di complicità – sposata a incompetenza e debolezza – e “volontà di potenza” di chi ha un peso economico superiore. Ma è una diseguaglianza che è andata crescendo oltre ogni ragionevole tolleranza, e che genera le “tensioni” popolari che sprezzantemente vengono derubricate a “populiste” o “sovraniste”, ma che riguardano effettivamente le condizioni di vita dei vari popoli europei ed anche la loro (residua) sovranità popolare, inscritta in genere nelle loro Costituzioni.
Ma, giunti a questo punto, come se ne esce? Giustamente Salerno Aletta fa notare che – per tentare di salvare capra e cavoli – almeno si sarebbe dovuta ripristinare la “parità tra partner”. Ovvero: “Una volta che la Germania ha affermato l’incomprimibilità della responsabilità del Parlamento in ordine alle decisioni di spesa, e visto che la medesima prescrizione è contenuta nella nostra Costituzione per quanto riguarda i trattati internazionali, è via obbligata accedere alla impostazione della riserva tedesca e inserirne una di identica portata da parte italiana”.
Ma di questa consapevolezza nella nostra “classe dirigente” – non solo della sua parte “politica” – non c’è alcuna traccia.
La Lega solleva strumentalmente il problema, è vero. Ma il problema esiste e il gruppo dirigente della Lega lo sapeva benissimo. Il “documento” con il testo del nuovo Mes campeggia infatti dal 4 dicembre 2018 sul sito del Consiglio Ue, e illustra in dettaglio ciò che poi sarebbe stato concordato sei mesi dopo. Una “location” certo poco attrattiva per i “leoni da tastiera”, ma sicuramente non ignorata dai Bagnai, Borghi e Garavaglia – le “teste economiche” del Carroccio.
Il problema politico ora è piuttosto incasinato. Divisioni partitiche a parte, infatti, accettare questo trattato è finanziariamente un suicidio. L’Italia dovrebbe garantire copertura (in caso di necessità) per 125 miliardi ad un fondo gestito non all’unanimità (in cui non avrebbe insomma diritto di veto), ma in base alla maggioranza delle quote. Germania e Francia, insieme, dispongono del 47%; basterà aggregare Olanda, Austria o Finlandia per raggiungere la maggioranza e farci neri. Al resto penseranno come sempre “i mercati”...
L’analisi sulla sostenibilità del debito pubblico dei vari paesi, infatti, passerebbe dall’essere esclusiva della Commissione Europea (organo politico, dunque in qualche misura “sensibile” o “sensibilizzabile” alle ragioni di opportunità, equilibrio, cautela, ecc.) a prerogativa principale del Mes, che assume però “il punto di vista del creditore”. Ossia di chi vuol rientrare del proprio capitale (cui contribuiscono però i vari paesi, non “appartiene” al Mes) e se ne fotte se il debitore va sul lastrico.
È il massimo dell’idiozia, ci sembra, finanziare (sia pure “a garanzia”) lo strumento che potrebbe decapitarci come Paese e gettare milioni di lavoratori/correntisti (obbligati) in pasto alla speculazione.
L’unica soluzione decente sarebbe non ratificare il trattato (ormai “inemendabile”, garantisce il ministro dell’economia, nonché ex tecnoburocrate di Bruxelles ed ex senatore Pd) e far saltare il tavolo.
Ma di certo non lo faranno queste orde di mentitori professionali e statisti mancati che abitano le stanze di Cinque Stelle, Lega e, a maggior ragione, Pd, Fratelli d’Italia e frattaglie varie. I “sovranisti da operetta”, quando il gioco si fa duro, farfugliano e si arrendono.
Fonte
In più, risulta essere la prova inconfutabile dell’idiozia contrattuale della nostra “classe politica”, pronta a firmare quel che gli altri partner europei – a cominciare ovviamente da quelli più forti, la Germania – si guardano bene dal sottoscrivere.
Un’analisi costituzionale e non soltanto economica del testo solleva infatti “delicate questioni di legittimità costituzionale e di uguaglianza dell’Italia nei rapporti internazionali”. Parole che appaiono sull’editoriale di Milano Finanza, a firma di Guido Salerno Aletta (L’Unione dei diseguali), non in qualche scantinato leghista.
In ballo ci sono due “piccoli dettagli” come il principio di sovranità (chi comanda dentro i confini dello Stato) e il ruolo del Parlamento, cui la sovranità popolare viene delegata con il normale processo elettorale.
Da sempre, l’Italia firma i trattati europei senza una vera discussione parlamentare (addirittura a Camere chiuse, come avvenne per il Trattato di Maastricht!) e sicuramente senza alcun esame della Corte Costituzionale.
Tanto per restare nell’esempio tipico, la Germania agisce in modo opposto, tanto che – come nel 2012, quando fu decisa la struttura istituzionale del Mes ancora oggi vigente – il Bundestag approvò il trattato solo il 27 settembre, dopo una sentenza dell’Alta Corte che metteva rigidi paletti all’approvazione del trattato stesso.
L’Italia invece lo aveva approvato il 23 luglio, tra le tante cosette che un Parlamento con le valige in mano, pronto a traslocare in qualche spiaggia assolta, vota senza neanche starci a pensare un attimo.
La corte tedesca poneva infatti due condizioni, come ricorda Salerno Aletta: «la necessità che ogni incremento dell’ammontare della dotazione dell’Esm fosse preventivamente ed esplicitamente approvato dal Parlamento tedesco». Perché quando si parla di impegnare soldi pubblici, foss’anche per un’istituzione europea, il Parlamento deve farlo con tutta la consapevolezza e la formalità necessaria.
E «la necessità di assicurare una sufficiente influenza parlamentare sulla maniera in cui vengono gestiti i fondi». Ossia: non è che noi (la Germania) mettiamo soldi nostri e poi qualcun altro decide come spenderli; in ogni passaggio noi (la Germania) vogliamo decidere a chi si danno, come, perché e in che modo debbono essere restituiti.
Per maggiore sicurezza pretesero la nomina di Klaus Regling a capo del Mes.
Ma non basta. La stessa Corte Costituzionale germanica mise altre tre condizioni: “nello strumento di ratifica del Trattato si sarebbe dovuta inserire una riserva formale che recepisse le condizioni di merito stabilite dalla Corte medesima; occorreva inoltre inserirvi la clausola secondo cui la Germania non desidera essere vincolata da quanto stabilito dal Trattato medesimo nella sua interezza se dette riserve dovessero risultare inefficaci sul piano del diritto internazionale; infine, si precisava che le altre Parti che avevano già ratificato il Trattato avrebbero dovuto esprimersi sulle riserve poste dalla Germania, accettandole o meno.”
Della serie: “partner europei, avete capito che noi non ci accolleremo nessun carico senza prima vedere se ci conviene?”
In ogni caso, bontà loro, veniva dato per scontato che anche gli altri paesi avrebbero potuto avanzare le stesse “riserve”, limitando così le funzioni del Mes.
Ma quando mai... Dall’Italia non venne neanche un vagito, figuriamoci una perplessità. Non sarebbe stato facile, perché “non sarebbe stata sufficiente la sola dichiarazione ministeriale di accettazione unilaterale delle riserve tedesche, resa senza l’assenso preventivo del Parlamento”. Altrimenti “sarebbe intervenuta, senza averne titolo, su un atto del Presidente della Repubblica”, ossia la firma al trattato.
In altre parole, la “diseguaglianza tra [finti] uguali” ha nell’Unione Europea una lunga storia, fatta di complicità – sposata a incompetenza e debolezza – e “volontà di potenza” di chi ha un peso economico superiore. Ma è una diseguaglianza che è andata crescendo oltre ogni ragionevole tolleranza, e che genera le “tensioni” popolari che sprezzantemente vengono derubricate a “populiste” o “sovraniste”, ma che riguardano effettivamente le condizioni di vita dei vari popoli europei ed anche la loro (residua) sovranità popolare, inscritta in genere nelle loro Costituzioni.
Ma, giunti a questo punto, come se ne esce? Giustamente Salerno Aletta fa notare che – per tentare di salvare capra e cavoli – almeno si sarebbe dovuta ripristinare la “parità tra partner”. Ovvero: “Una volta che la Germania ha affermato l’incomprimibilità della responsabilità del Parlamento in ordine alle decisioni di spesa, e visto che la medesima prescrizione è contenuta nella nostra Costituzione per quanto riguarda i trattati internazionali, è via obbligata accedere alla impostazione della riserva tedesca e inserirne una di identica portata da parte italiana”.
Ma di questa consapevolezza nella nostra “classe dirigente” – non solo della sua parte “politica” – non c’è alcuna traccia.
La Lega solleva strumentalmente il problema, è vero. Ma il problema esiste e il gruppo dirigente della Lega lo sapeva benissimo. Il “documento” con il testo del nuovo Mes campeggia infatti dal 4 dicembre 2018 sul sito del Consiglio Ue, e illustra in dettaglio ciò che poi sarebbe stato concordato sei mesi dopo. Una “location” certo poco attrattiva per i “leoni da tastiera”, ma sicuramente non ignorata dai Bagnai, Borghi e Garavaglia – le “teste economiche” del Carroccio.
Il problema politico ora è piuttosto incasinato. Divisioni partitiche a parte, infatti, accettare questo trattato è finanziariamente un suicidio. L’Italia dovrebbe garantire copertura (in caso di necessità) per 125 miliardi ad un fondo gestito non all’unanimità (in cui non avrebbe insomma diritto di veto), ma in base alla maggioranza delle quote. Germania e Francia, insieme, dispongono del 47%; basterà aggregare Olanda, Austria o Finlandia per raggiungere la maggioranza e farci neri. Al resto penseranno come sempre “i mercati”...
L’analisi sulla sostenibilità del debito pubblico dei vari paesi, infatti, passerebbe dall’essere esclusiva della Commissione Europea (organo politico, dunque in qualche misura “sensibile” o “sensibilizzabile” alle ragioni di opportunità, equilibrio, cautela, ecc.) a prerogativa principale del Mes, che assume però “il punto di vista del creditore”. Ossia di chi vuol rientrare del proprio capitale (cui contribuiscono però i vari paesi, non “appartiene” al Mes) e se ne fotte se il debitore va sul lastrico.
È il massimo dell’idiozia, ci sembra, finanziare (sia pure “a garanzia”) lo strumento che potrebbe decapitarci come Paese e gettare milioni di lavoratori/correntisti (obbligati) in pasto alla speculazione.
L’unica soluzione decente sarebbe non ratificare il trattato (ormai “inemendabile”, garantisce il ministro dell’economia, nonché ex tecnoburocrate di Bruxelles ed ex senatore Pd) e far saltare il tavolo.
Ma di certo non lo faranno queste orde di mentitori professionali e statisti mancati che abitano le stanze di Cinque Stelle, Lega e, a maggior ragione, Pd, Fratelli d’Italia e frattaglie varie. I “sovranisti da operetta”, quando il gioco si fa duro, farfugliano e si arrendono.
Fonte
Parigi - Sfratti e speculazione in vista dei Giochi Olimpici
Almeno 400 abitanti del 93° dipartimento, nella banlieue nord, perderanno le proprie case a causa della costruzione del Villaggio Olimpico per i Giochi che Parigi ospiterà nel 2024. Tuttavia, in realtà, la zona di Saint-Denis ospiterà gran parte delle gare e delle infrastrutture per la sua vicinanza allo Stade de France e alla futura Gare de Grand Paris. Si tratta di una sostanziale trasformazione dell’intera zona della Plaine del 93°, la quale sarà colpita dai vari progetti prima, durante e dopo le Olimpiadi.
Il Comitato Internazionale Olimpico ha tenuto nei giorni del 26 e 27 novembre a Parigi una riunione di aggiornamento ed eventuale revisione del progetto. Da questa, come dalle precedenti decisioni, sono stati completamente esclusi gli abitanti del 93°, sui quali ricadranno direttamente i costi sociali del progetto, e le associazioni attive per dimostrare le conseguenze e i rischi di questa trasformazione forzata.
Per la costruzione degli impianti olimpici saranno sfrattate diverse unità abitative, una residenza universitaria e il Foyer Adef. Le aziende della zona industriale della vecchia Saint-Ouen saranno sicuramente ricollocate in un’altra parte del dipartimento, così come gli studenti della residenza universitaria. Al contrario, il Foyer Adef dei lavoratori migranti verrà demolito senza soluzioni abitative alternative. Poiché i foyer della regione sono già congestionati, qualsiasi possibile trasferimento sarà fuori da Saint-Denis e Saint-Ouen.
Che ne sarà delle diverse strutture e degli impianti olimpici dopo le Olimpiadi del 2024? La questione è preoccupante, vista l’ampiezza del progetto. Il Villaggio Olimpico si estenderà su 51 ettari, a Saint-Denis, Saint-Ouen e L’Île-Saint-Denis, con 17.000 posti letto per ospitare gli atleti. Dovrebbe essere convertito in 22.000 unità abitative, 900 unità abitative per studenti, 100.000 m² di uffici e 3 ettari di spazio verde. Gli alloggi saranno di alta qualità e quindi finanziariamente inaccessibili per gran parte della popolazione locale.
L’organizzazione dei Giochi Olimpici a Saint-Denis, e tutto ciò che ne deriva, porterà ad un aumento del prezzo dei terreni e delle abitazioni intorno allo Stade de France e al futuro Villaggio Olimpico.
Con la costruzione della Gare de Grand Paris e delle nuove linee della metropolitana – estensione delle linee 12 e 14 e creazione della 16 – Saint-Denis diventerà un’area molto attraente per i promotori immobiliari. I prezzi degli affitti aumenteranno, soprattutto quelli delle abitazioni costruite nell’ambito della conversione degli impianti olimpici. I quartieri popolari della zona subiranno un profondo processo di gentrificazione che costringerà gran parte della popolazione che attualmente vi abita ad andarsene.
Fonte
Il Comitato Internazionale Olimpico ha tenuto nei giorni del 26 e 27 novembre a Parigi una riunione di aggiornamento ed eventuale revisione del progetto. Da questa, come dalle precedenti decisioni, sono stati completamente esclusi gli abitanti del 93°, sui quali ricadranno direttamente i costi sociali del progetto, e le associazioni attive per dimostrare le conseguenze e i rischi di questa trasformazione forzata.
Per la costruzione degli impianti olimpici saranno sfrattate diverse unità abitative, una residenza universitaria e il Foyer Adef. Le aziende della zona industriale della vecchia Saint-Ouen saranno sicuramente ricollocate in un’altra parte del dipartimento, così come gli studenti della residenza universitaria. Al contrario, il Foyer Adef dei lavoratori migranti verrà demolito senza soluzioni abitative alternative. Poiché i foyer della regione sono già congestionati, qualsiasi possibile trasferimento sarà fuori da Saint-Denis e Saint-Ouen.
Che ne sarà delle diverse strutture e degli impianti olimpici dopo le Olimpiadi del 2024? La questione è preoccupante, vista l’ampiezza del progetto. Il Villaggio Olimpico si estenderà su 51 ettari, a Saint-Denis, Saint-Ouen e L’Île-Saint-Denis, con 17.000 posti letto per ospitare gli atleti. Dovrebbe essere convertito in 22.000 unità abitative, 900 unità abitative per studenti, 100.000 m² di uffici e 3 ettari di spazio verde. Gli alloggi saranno di alta qualità e quindi finanziariamente inaccessibili per gran parte della popolazione locale.
L’organizzazione dei Giochi Olimpici a Saint-Denis, e tutto ciò che ne deriva, porterà ad un aumento del prezzo dei terreni e delle abitazioni intorno allo Stade de France e al futuro Villaggio Olimpico.
Con la costruzione della Gare de Grand Paris e delle nuove linee della metropolitana – estensione delle linee 12 e 14 e creazione della 16 – Saint-Denis diventerà un’area molto attraente per i promotori immobiliari. I prezzi degli affitti aumenteranno, soprattutto quelli delle abitazioni costruite nell’ambito della conversione degli impianti olimpici. I quartieri popolari della zona subiranno un profondo processo di gentrificazione che costringerà gran parte della popolazione che attualmente vi abita ad andarsene.
Fonte
Libano, giorno 40
Manifestazione davanti all’ambasciata americana in Libano, ad Aoukar, contro le interferenze straniere, 24 novembre 2019. I manifestanti sono per lo più sostenitori del Partito comunista libanese, altri partiti di sinistra e Hezbollah (in foto).
*****
Hezbollah, per bocca del suo Segretario Generale Hassan Nasrallah, si oppone alle interferenze americane negli affari libanesi. Ciò va tutto in suo onore. Allo stesso tempo, ha approvato la road map avviata da Saad Hariri in risposta alla crisi che ha scosso il paese e sfidata dal movimento popolare.
Questo è classicamente definito “il grande divario”. O se preferisci, l’arte di sostenere una cosa e il suo contrario.
È certo che questa posizione porta direttamente alla demagogia e alla mancanza di fiducia nei confronti del suo autore.
In effetti, qual è la tabella di marcia del signor Hariri se non le direttive della Banca mondiale che sono guidate da vicino dall’amministrazione americana?
Quindi c’è una grave contraddizione che il signor Nasrallah deve superare rapidamente se vuole mantenere un minimo di serietà.
Ma, questo è il punto, il leader religioso non può, per la semplice ragione che fa parte di un sistema che ha raggiunto i suoi limiti storici. È impossibile che allo stesso tempo faccia parte del confessionalismo politico e si opponga durevolmente a Israele, il quale è uno stato espansionista basato su una concezione religiosa di ispirazione razzista costruita nella Palestina occupata al confine con il Libano.
Ancora una volta è il “grande divario”.
In effetti, con l’attuale rivoluzione, che mira a stabilire uno stato civile moderno e democratico in Libano, diametralmente opposto allo stato sionista, la cosiddetta resistenza “islamica” è ora a un bivio.
Questo tipo di resistenza non è più necessaria. Deve fare una scelta storica: o trasformarsi integrandosi in una resistenza nazionale aperta a tutto il popolo libanese di tutte le fedi, etnie e regioni, oppure rimanere allineata agli interessi dei valletti della Banca Mondiale, strumento economico e finanziario per eccellenza l’imperialismo.
In breve, il signor Nasrallah deve scegliere tra servire gli interessi della grande massa del popolo o quelli della grande borghesia.
Il tempo sta per scadere. Deve decidere rapidamente.
Possano la sua intelligenza e la sua saggezza orientarsi nella giusta direzione.
Fonte
Strage di Piazza Fontana. Ha un nome chi mise la bomba
Cinquanta anni dopo la Strage di Stato del 12 dicembre 1969 in piazza Fontana, emerge un nome per l’uomo che avrebbe messo materialmente la bomba nella Banca dell’Agricoltura.
Secondo il libro dato alle stampe dal giudice Guido Salvini, il magistrato che con la sua inchiesta riuscì a far riaprire il processo per la strage, l’uomo sarebbe Claudio Bizzarri, veronese, ex parà e militante dell’organizzazione neofascista Ordine Nuovo. Negli anni subito dopo la strage si rifugiò nella Grecia dei colonnelli, successivamente in Svizzera per poi rientrare in Italia.
Nel libro “La maledizione di Piazza Fontana”, sempre secondo Guido Salvini, a confezionare l’ordigno fu il fascista Delfo Zorzi oggi residente in Giappone e per il quale, diversamente che per Cesare Battisti, non è mai stata richiesta l’estradizione.
Ma nel Giugno del 2005 la Corte di Cassazione ha confermato l’assoluzione dei neofascisti imputati per la strage del 12 dicembre 1969 sostenendo che i colpevoli erano quelli del primo processo, ma essendo stati già giudicati e assolti per lo stesso reato non potevano essere di nuovo processati.
È il settembre del 2008 quando il giudice Guido Salvini, autore dell’indagine che aveva portato all’ultimo processo sulla strage, riceve la lettera di un ex fascista di Ordine Nuovo padovano. “La prego contattarmi personalmente per novità su piazza Fontana.” è il primo passo di una lunga e puntigliosa inchiesta, a questo punto privata da parte dell’ex magistrato.
Nelle prossime due settimane parleremo della Strage di Stato in diverse città italiane dopo aver dato alla ristampa il nostro opuscolo: “Piazza Fontana, una strage lunga cinquanta anni”. Restiamo convinti che se la realtà giudiziaria sulla strage è ormai seppellita, quella storica e politica è di straordinaria importanza che venga conosciuta, impugnata e attualizzata.
Fonte
29/11/2019
Sciascia e l’antimafia: trent’anni di polemiche
di Umberto Santino
«A futura memoria (se la memoria ha un futuro)» è il titolo del libro in cui, nel dicembre 1989, poco dopo la sua scomparsa, sono stati pubblicati alcuni scritti di Leonardo Sciascia, tra cui l’articolo del “Corriere della sera” del 10 gennaio 1987, con il titolo, redazionale, “I professionisti dell’antimafia” [1].
In quell’articolo Sciascia esordiva con una lunga citazione dal suo romanzo Il giorno della civetta, pubblicato nel 1961, in cui il protagonista, il capitano Bellodi, ripensa l’esperienza del prefetto Mori, durante il periodo fascista, disapprova la sua azione fondata sulla sospensione delle garanzie costituzionali in Sicilia e indica un’altra strada: «bisognerebbe sorprendere la gente nel covo dell’inadempienza fiscale, come in America… Bisognerebbe, di colpo, piombare nelle banche: mettere mani esperte nella contabilità… delle grandi e piccole aziende, revisionare i catasti… annusare intorno alle ville, le automobili fuori serie… e confrontare questi segni di ricchezza agli stipendi e tirarne il giusto senso». E aggiungeva un’altra autocitazione, tratta dal romanzo A ciascuno il suo, del 1966: «Ma il fatto è… che l’Italia è un così felice Paese che quando si cominciano a combattere le mafie vernacole vuol dire che se ne è stabilita una in lingua» [2].
Seguivano dei riferimenti al libro La mafia durante il fascismo dello storico Christopher Duggan, recentemente scomparso, e a una piéce teatrale, La Mafia, di Luigi Sturzo, il prete fondatore del Partito popolare, di cui si sono trovati solo gli abbozzi del quinto atto, che davano un’immagine inquietante della realtà della mafia [3]. Il riferimento centrale nel corpo dell’articolo era il libro di Duggan, considerato «un’accurata indagine e sensata analisi» su mafia e fascismo. In effetti il testo di Duggan era basato su una ricerca archivistica abbastanza attenta, ma arrivava a una conclusione inaccettabile: che il fascismo avesse inventato la mafia. Certamente il fascismo ha utilizzato la lotta alla mafia per risolvere i suoi conflitti interni, ma la mafia c’era, non era un’invenzione. Il prefetto Mori ha potuto agire solo fino a un certo punto; il tentativo di andare oltre quel punto, colpendo politici e grandi agrari collusi con la mafia, è stato arrestato con il suo precoce pensionamento. Sciascia utilizza il libro dello storico inglese per trarne un’indicazione: «l’antimafia come strumento di potere». E avverte che quello che è accaduto con il fascismo può «accadere anche in un sistema democratico, retorica aiutando e spirito critico mancando».
Per avallare questo assunto venivano fatti degli esempi: un sindaco, innominato, ma il riferimento era a Leoluca Orlando, che «per sentimento o per calcolo cominci ad esibirsi – in interviste televisive e scolastiche, in convegni, conferenze e cortei – come antimafioso, anche se dedicherà tutto il suo tempo a queste esibizioni e non ne troverà mai per occuparsi dei problemi del paese o della città che amministra». L’altro esempio aveva nomi e cognome: il magistrato Paolo Emanuele Borsellino che, per avere svolto indagini sulla mafia, aveva scavalcato un magistrato più anziano ed era stato nominato procuratore a Marsala. La conclusione di Sciascia era tranchant: «i lettori prendano atto che nulla vale più in Sicilia, per far carriera nella magistratura, del prender parte a processi di stampo mafioso». Era evidente che tutta l’analisi precedente, volta al passato, era solo una preparazione per questa sciabolata rivolta al presente.
Le reazioni all’articolo di Sciascia, Il Coordinamento antimafia
Le reazioni all’articolo di Sciascia, pubblicato con un titolo redazionale che appesantiva ancora di più il contenuto, furono furenti. Fra gli altri ci fu un comunicato dell’associazione Coordinamento antimafia che, utilizzando la classificazione antropologica del capomafia don Mariano, coprotagonista del romanzo Il giorno della civetta, che distingueva uomini, mezz’uomini, ominicchi, pigliainculo e quaquaracquà, definiva Sciascia un quaquaracquà, cioè una nullità, e lo relegava «ai margini della società civile» [4].
Il Coordinamento antimafia era nato nel 1984 su proposta del Centro Impastato. Dopo una fase abbastanza travagliata di convivenza, in cui aveva tentato di collegare il variegato mondo dell’antimafia cittadina (aderirono 38 organizzazioni, tra associazioni, centri, comitati, sezioni di partito, frange di sindacato, ma alcune organizzazioni esistevano solo sulla carta) nel 1986 si era formata una singola associazione che aveva mantenuto quella denominazione ma in realtà coordinava solo se stessa e si configurerà sempre più come tifoseria del sindaco. Con l’aiuto di stampa e televisione si poneva come l’unico verbo antimafia. Agiva insieme come claque e come ordalia, ignorando tutto ciò che si muoveva al di fuori di essa e non era pronto a intrupparsi nelle sue file.
Il comunicato del Coordinamento suscitava la reazione di Sciascia che, si può dire, non aspettava altro per infierire. Definiva il Coordinamento «frangia fanatica e stupida di quel costituendo o costituito potere… un potere fondato sulla lotta alla mafia che non consente dubbio, dissenso, critica. Ne sono soddisfatto: si sono consegnati all’opinione di chi sa di avere un’opinione, nella loro vera immagine». A dire di Sciascia esso coordinava «interessi politici e stupidità» [5]. E il «Giornale di Sicilia», che plaudiva all’articolo di Sciascia, pensò bene di pubblicare i nomi dei componenti del Coordinamento, qualcosa che somigliava a una schedatura e a una gogna.
Tenendo conto dell’esperienza personale, il mio giudizio sul Coordinamento è ancora più duro di quello di Sciascia: bisogna mettere nel conto anche una sequela di scorrettezze; si potrebbe dire: la scorrettezza come regola, come modello relazionale e modo di essere. Qualche esempio: comunicati approvati e non dati alla stampa, poiché c’era una supervisione, occulta ma evidente, dei dirigenti del Pci e delle Acli, allora affiancati nella lotta contro l’installazione dei missili nucleari a Comiso; il peso esercitato dalle appartenenze a partiti e organizzazioni nazionali, al limite dell’arroganza e della presunzione; la superficialità e la mancanza d’interesse di tanti, che pure godevano di credito e di pubblicità. Ma un conto è il giudizio politico un altro la gogna.
Alla testa del Coordinamento e suoi ispiratori erano personaggi che, a dimostrazione della tempra della loro fede e della loro coerenza, dopo sono passati nel centrodestra, in piena bufera di berlusconismo, come dire il picco dell’immoralità pubblica nella storia dell’Italia repubblicana. Sbocco non nuovo di trasversalismi teorizzati e praticati e di “estremismi” fasulli. Per esempio, il gesuita Ennio Pintacuda, punto di riferimento per l’antimafia più pubblicizzata e grande sostenitore di Orlando, fino allo scontro con il confratello Bartolomeo Sorge e l’abbandono della Compagnia di Gesù, si è riposizionato nell’area filoberlusconiana, avendone in cambio la direzione del Cerisdi, un centro studi che per molto tempo ha goduto di lauti finanziamenti pubblici e mirava a formare la classe dirigente della città [6]. Altri, tra cui gli estensori del comunicato antisciascia e allora in prima linea nel Coordinamento, sono letteralmente scomparsi.
Un buco nell’acqua: il comunicato del Centro Impastato
Nel tentativo di riportare la polemica a un confronto civile, mettendo al centro i problemi e lasciando da parte offese e insulti, come presidente del Centro Impastato scrivevo un comunicato pubblicato dal giornale “L’Ora”. Ecco il testo:
«Abbiamo preferito non prendere la parola nel corso delle recenti polemiche perché il tono di esse ci è sembrato il meno adatto per una riflessione seria su alcuni problemi particolarmente gravi, che rischiano di aggravarsi ulteriormente. Ci limitiamo adesso ad alcune considerazioni molto sommarie su qualcuno di essi.
1) Valutazione dell’operato del sindaco Orlando e della giunta pentapartito. Il sindaco Orlando ha compiuto alcuni gesti (quali, per esempio, la costituzione di parte civile del Comune al maxiprocesso, le dichiarazioni fatte nel corso di esso, il tentativo di portare un minimo di trasparenza nella procedura di aggiudicazione degli appalti di opere pubbliche) che non possono non essere apprezzati, ma tutti i problemi di Palermo (la disoccupazione, il risanamento del centro storico, il funzionamento delle aziende municipalizzate etc. etc.) restano irrisolti per ragioni che non è difficile individuare: la Democrazia Cristiana rimane legata ai peggiori interessi, sotto la tutela di uomini come Lima, e il pentapartito è un pantano che non consente nessuna politica rinnovatrice. Ci sembra arrivato il momento di fare un bilancio di questa amministrazione comunale e di vedere se è possibile sbloccare una situazione di immobilismo, avvelenata da polemiche personalistiche.
2) Conformismo e anticonformismo. In una città in cui straripa l’assuefazione alla violenza, la stragrande maggioranza degli abitanti non si scuote neppure per l’assassinio di un bambino, si svolgono manifestazioni in cui s’inneggia alla mafia, dominano il conformismo filomafioso e l’indifferenza, parlare di «conformismo antimafioso» ci sembra un po’ troppo.
3) Antimafia: seria o da vetrina. È vero, c’è un’antimafia “da vetrina”, come qualcuno l’ha definita, ma vogliamo fare qualche esempio? Ci sembrano «antimafia da vetrina»: l’azione, abbastanza incolore, dei vari Alti Commissari contro la mafia; l’altrettanto incolore operato delle Commissioni antimafia, nazionale e regionale; le prediche con il morto davanti; le scoperte di grandi e piccoli inviati che hanno dovuto attendere l’uccisione di Dalla Chiesa per parlare di mafia come «questione nazionale» e lo hanno dimenticato il giorno dopo; i fumetti televisivi e cinematografici e le pubblicazioni di mafiologi improvvisati regolarmente prefate da firme “prestigiose”; buona parte delle attività svolte nelle scuole per utilizzare in qualche modo i finanziamenti regionali; i centri inesistenti che hanno finanziamenti pubblici per centinaia di milioni; le sigle fabbricate sulle ceneri di ipotesi più consistenti che si è fatto di tutto per non far maturare. Si collocano su un altro versante i pochissimi magistrati che, rischiando la vita, hanno svolto le inchieste più impegnative contro la mafia.
4) Problema della “giustizia giusta”. È il problema più grosso, e non è di facile soluzione. La mafia e la criminalità organizzata non sono una novità, ma le dimensioni e la complessità attuali lo sono, e gli attuali ordinamenti giuridici sono inadeguati per fronteggiare fenomeni che non sono una “emergenza” ma un dato strutturale.
Ci chiediamo: ci può essere “giustizia giusta” con gli assassinii regolarmente impuniti? Si ritiene che, passata l’onda alta delle uccisioni, tutto si risolva con l’«uscita dall’emergenza» e il ristabilimento delle regole del «garantismo classico»? Non occorre piuttosto elaborare una riforma del processo penale e della normativa vigente che tenga conto di questi fatti nuovi? Come intervenire sui canali di accumulazione illegale? Come troncare il meccanismo di simbiosi tra capitale illegale e legale garantito dal segreto bancario? Non si tratta di decretare “stati d’assedio”, o di avallare “teoremi Buscetta”, ma di trovare soluzioni adeguate a problemi che non possono essere minimizzati o considerati con ottiche tradizionali.
Per affrontare seriamente questi temi non ci pare che siano utili le polemiche, soprattutto quando si risolvono in ingiurie e scomuniche. Occorrono: coraggio, studio, serenità[7]».
Il comunicato cadeva nel vuoto. Commentavo: «Non è il momento adatto per discutere seriamente e serenamente. Bisogna schierarsi, come se si fosse nel pieno di un combattimento senza esclusione di colpi» [8].
La promozione di Borsellino e la bocciatura di Falcone
Successivamente alla pubblicazione dell’articolo, c’è stato un incontro tra Sciascia e Borsellino, in cui ci sarebbe stato un “chiarimento”. Sciascia ha ammesso di essere stato “mal consigliato” e non si può non osservare che uno come lui, maître-à-penser già da anni, non poteva non essere consapevole degli effetti che le sue parole avrebbero avuto. Avrebbe potuto e dovuto far attenzione a chi lo consigliava e a cosa consigliava.
Se la ferita sembrava rimarginata, e i rapporti fra Sciascia e Borsellino erano diventati quasi amichevoli e cordiali, in realtà nel profondo essa rimaneva aperta e sanguinante. Dopo la strage di Capaci, in cui morirono Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo, gli agenti di scorta Rocco Dicillo, Antonio Montinaro e Vito Schifani, in un incontro pubblico Borsellino, già consapevole di un destino che si avvicinava, in un accorato intervento, in cui ricostruiva le difficoltà e le inimicizie che avevano segnato la vita e l’attività di Falcone, diceva: «Tutto cominciò con quell’articolo sui professionisti dell’antimafia» [9].
Falcone era stato ostacolato più volte e in vari modi: bocciata la sua candidatura a Consigliere istruttore, al posto di Rocco Chinnici, fondatore del pool antimafia, assassinato il 29 luglio 1983; bocciata la sua candidatura al Consiglio superiore della magistratura. Si potrebbe dire che, dopo la mafia, i principali nemici di Falcone siano stati i suoi colleghi. Per invidia, per il peso della sua personalità, non ostentato ma effettivo, per la sua visibilità.
Si è detto e scritto che la bocciatura della candidatura di Falcone a capo del’Ufficio istruzione, allora strategico nella attività giudiziaria antimafia e successivamente abolito, sia stata il frutto dell’applicazione del criterio dell’anzianità, che portò a favorire un magistrato come Antonino Meli, che mai si era occupato di mafia e che smantellerà il pool antimafia, portando indietro di anni l’attività giudiziaria contro la mafia. E siccome il rispetto del criterio fondato sull’anzianità era proprio quello che voleva Sciascia, la colpa sarebbe sua. Accusa che gli si è rivolta in passato ed è ritornata nel giorni scorsi, in occasione del trentennale dell’articolo sul “Corriere”.
Sciascia aveva già risposto a quell’accusa. In un articolo sulla “Stampa” del 6 agosto 1988, scriveva: nel promuovere Borsellino il CSM si era «sottratto alla regola vigente senza però stabilirne un’altra. Se l’avesse in quel momento stabilita, il caso del dottor Falcone, con tutto quel che oggi importa, non ci sarebbe stato. Adottando un criterio per promuovere Borsellino e tornando invece alla vecchia regola per non promuovere Falcone, ecco il nodo che presto o tardi sarebbe venuto al pettine. La situazione di oggi, insomma, non l’ho inventata io con quel mio articolo sul ‘Corriere’: c’era, e non poteva che esplodere. Io non ho fatto che avvertirla, e tempestivamente» [10]. Non si può non dargli ragione.
Trent’anni dopo
Perché a trent’anni dall’articolo di Sciascia quelle parole vengono ricordate e riesplodono le polemiche? Tornano a confrontarsi, senza dialogare, due schieramenti. C’è chi considera Sciascia un maestro di pensiero e di vita, un profeta, e invita al pentimento, all’autocritica; chi sta dall’altro lato allora e ancor’oggi lo considera un bastian contrario che ha fatto danni all’antimafia, provocando l’isolamento dei magistrati più impegnati ed esponendoli alle critiche e all’avversione di coloro che hanno usato le sue parole per condannare e auto assolversi. Possiamo definirli i “professionisti della mafia”, a cominciare dai politici, dagli imprenditori, più o meno collusi, che, facendosi scudo del prestigio dello scrittore, passavano dal silenzio e dalla difensiva al contrattacco, nel momento in cui erano in difficoltà e il maxiprocesso veniva percepito come un inizio e più d’uno pensava che prima o poi sarebbe toccato a lui. Da ciò nascerà, dopo il successo del maxiprocesso in tutti i tre gradi di giudizio, lo smantellamento del pool antimafia. Ma questo non c’entra con il parere di Sciascia. Però la sua polemica, sbagliata nel tono, nella scelta degli esempi e del tempo, si prestava a quel tipo di uso strumentale.
I problemi che lo scrittore poneva erano reali: il pericolo della strumentalizzazione dell’antimafia, il rispetto delle regole, la democrazia come unica strada per lottare la mafia, poiché ha «tra le mani lo strumento che la tirannia non ha: il diritto, la legge uguale per tutti, la bilancia della giustizia» [11]. Il tema di fondo del discorso di Sciascia era il sistema di garanzie, cioè il garantismo. Ne aveva un’idea che sapeva di religioso, come se si trattasse di una sorta di depositum fidei. Partendo da alcuni esempi concreti, aveva intravisto una sua violazione, che si era ritenuto in dovere di denunciare come un vulnus all’ordinamento democratico, ma per molti anni il culto del garantismo più che la certezza del diritto aveva assicurato la certezza dell’impunità.
Sciascia ha per molti anni esercitato una sorta di magistero civile: come abbiamo visto, aveva indicato, nei primi anni ’60, le banche come il terreno su cui sondare l’accumulazione mafiosa; precedendo di quasi trent’anni il mio saggio «La mafia finanziaria» scritto e pubblicato quando imperversava lo stereotipo della mafia imprenditrice, per giunta disorganizzata [12]. Il maestro di Racalmuto, dopo aver raccontato la provincia siciliana [13], ha percorso una linea narrativa che mischiava i generi letterari, con ampio spazio per la trattazione saggistica, l’analisi sociologica e il compte philosophique. Il costante ancoraggio alla tradizione illuministica più che un vezzo letterario era un modello di scrittura e un metodo di indagine. I suoi apologhi su una società mafiosizzata nei suoi centri di potere, nei suoi codici culturali, nella sua pratica quotidiana, costituiscono una variazione sul tema del potere e delle sue implicazioni criminali, e questo è un patrimonio ormai consegnato alla storia della letteratura e alla cultura, non solo italiana.
Trent’anni dopo possiamo chiederci se le sue parole sono state una profezia. Certo, con quel che è accaduto negli ultimi anni, siamo portati a pensarlo. Un breve elenco: imprenditori che si mostravano in prima fila nella lotta alla mafia incriminati per i loro rapporti con Cosa nostra; uno di essi, che passava per promotore del movimento antiracket, colto in flagrante mentre intascava una mazzetta; un telegiornalista, insignito di award internazionali, che ha fatto passare una faccenda di corna per aggressione mafiosa; una magistrata, dirigente dell’ufficio che gestisce i beni confiscati, che ne aveva fatto un’azienda privata, assegnandoli ai suoi amici e ricevendone favori, in un classico do ut des; una prefetta che le teneva bordone. Con questo campionario di “buoni esempi” si deve riconoscere che la realtà ha superato le rappresentazioni dello scrittore, ma potremmo dire che non ci troviamo di fronte a «professionisti dell’antimafia» (i professionisti, cioè persone capaci e competenti, ci vogliono, per l’antimafia come per qualsiasi altro tema, arduo e complesso, quelli che fanno danno sono i dilettanti e i cialtroni) ma a dei cattivi attori che hanno recitato la commedia dell’antimafia. La cosa grave, e che ci induce a una impietosa riflessione, è che tanti ci hanno creduto.
Ma quel che ci interessa oggi è lo “stato dell’arte” dell’antimafia. Cos’è accaduto dopo le polemiche del 1987, a parte gli episodi già richiamati? Sono sorti comitati, centri, associazioni e fondazioni, quasi tutti vanno avanti con finanziamenti ottenuti con metodi personalistici e clientelari. La proposta del Centro Impastato che la Regione Sicilia si doti di una legge che fissi criteri oggettivi per l’erogazione dei fondi pubblici è stata isolata, come se fosse una stranezza, la trovata eccentrica di chi non conosce le regole del gioco. In realtà, le conosce ma non le accetta.
Nel 1995 è nata Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie, sulla base di associazioni nazionali come le Acli, l’Arci, la Sinistra giovanile del Pds, legate direttamente o indirettamente ai partiti, e il primo, consistente, nucleo di adesioni si è costituito con l’elenco dalle loro sezioni locali, a prescindere se fossero o meno impegnate in attività antimafia. I referenti regionali sono stati nominati sulla base della loro appartenenze a queste associazioni. In Sicilia è toccato a una rappresentante dell’Arci, che mai si era vista in iniziative antimafia. Successivamente la referente si è candidata con Forza Italia ed è stata “dimissionata”. Dimissionati due vicepresidenti e i responsabili per il lavoro nelle scuole e per i beni confiscati, senza nessuna discussione. Chi scrive è stato sospeso, e si è dimesso, dopo aver posto problemi di democrazia interna, dovuti al leaderismo carismatico del fondatore, il sacerdote Luigi Ciotti. Recentemente è stato “licenziato” con un messaggino il figlio di Pio La Torre, protagonista delle lotte contadine, dirigente comunista e parlamentare nazionale, ucciso il 30 aprile del 1982.
Le attività continuative sono quelle nelle scuole, del movimento antiracket, per l’uso sociale dei beni confiscati. Nelle scuole l’educazione alla legalità si riduce troppo spesso a prediche senza analisi, al richiamo al rispetto delle leggi, ignorando che ancora più grave dell’illegalità mafiosa è quella delle istituzioni, che hanno troppi scheletri negli armadi e nessuna volontà di aprirli. Le associazioni antiracket, con esempi significativi, si limitano alle regioni meridionali, nonostante che le estorsioni siano ormai presenti sul territorio nazionale; l’uso sociale dei beni confiscati si limita a una decina di cooperative in tutta l’Italia.
Sul terreno della giustizia accanto a magistrati seriamente impegnati ci sono altri in vetrina o in giro con un personaggio come il direttore della rivista “Antimafia duemila”, che dice di avere ricevuto dalla Madonna di Fatima la mission di lottare la mafia, anticristo del nostro tempo, di avere le stimmate e di essere il maggiore esperto di Ufo! Qualche altro magistrato, smessa temporaneamente o definitivamente la toga, fa da foglia di fico a potenti in cerca di credenziali o si candida come salvatore della patria, andando incontro a patetici insuccessi. Sulla stampa e alla televisione qualcuno si atteggia a monopolista del pensiero unico antimafioso.
Il processo in corso sulla “trattativa” Stato-mafia rischia di delegare al potere giudiziario problemi, come il rapporto tra mafia, politica e istituzioni, che dovrebbero essere affrontati e risolti dall’intera società. Viviamo una crisi della democrazia, all’interno di una crisi più generale frutto del dominio del capitalismo finanziario e della dittatura del mercato globalizzato, che aggravano squilibri territoriali e divari sociali. In Italia, dopo vent’anni di Berlusconi, andato al potere con milioni di voti, sembrava che ci si potesse rialzare, con uno scatto di dignità. Ma i giovani “rottamatori” hanno fatto, o tentato di fare, quello che non è riuscito al patriarca di Arcore, abolendo l’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, che tutela i licenziati senza giusta causa, e progettando una riforma costituzionale impresentabile. Per fortuna il 4 dicembre c’è stato il referendum, ma non possiamo campare solo di referendum. Bisogna ripensare e ricostruire i fondamenti del vivere quotidiano. Su questa strada la lezione di Sciascia (considerato per tutta la sua opera, e non per un singolo episodio, che può essere criticabile) con i suoi meriti e le sue contraddizioni può essere un buon bagaglio di viaggio e le sue pagine, lette con attenzione e non con devozione, ci servono ancora per capire in che mondo viviamo, anche se la realtà è andata al di là delle sue più pessimistiche previsioni.
Note:
[1] L. Sciascia, A futura memoria (se la memoria ha un futuro), Bompiani, Milano 1989. Le citazioni successive sono tratte da questo libro.
[2] L. Sciascia, Il giorno della civetta, Einaudi, Torino 1961; A ciascuno il suo, Einaudi, Torino 1966.
[3] C. Duggan, La mafia durante il fascismo, Rubbettino, Soveria Mannelli 1986; L. Sturzo, La Mafia, in Scritti inediti 1890-1924, Cinque Lune, Roma 1974.
[4] Cfr. U. Santino, Storia del movimento antimafia. Dalla lotta di classe all’impegno civile, Editori Runiti University Press, Roma 2009, terza edizione, pp. 325 ss. Anche per le successive considerazioni si rimanda a questo testo.
[5] L. Sciascia, A futura memoria, cit., pp. 131 ss.
[6] U: Santino, Storia del movimento antimafia, cit., p. 395.
[7] “L’Ora”, 3 febbraio 1987, Troppa antimafia? ma dai; il comunicato è pubblicato in appendice al mio L’alleanza e il compromesso. Mafia e politica dai tempi di Lima e Andreotti ali giorni nostri, Rubbettino, Soveria Mannelli 1997, pp.269 s.
[8] U. Santino, L’alleanza e il compromesso, cit., p. 77.
[9] L’incontro, organizzato dalla rivista “Micromega”, si svolse il 25 giugno 1992, presso la Biblioteca comunale di Palermo.
[10] In L.Sciascia, A futura memoria, cit., p. 153.
[11] Ibidem, p. 139.
[12] U. Santino, La mafia finanziaria. Accumulazione illegale e complesso finanziario-industrale, in “Segno” nn. 69-70, aprile maggio 1986, pp. 7-49, trad. inglese: The financial mafia. The illegal accumulation of wealth and the financial-industrial complex, in “Contemporary Crises”, vol. 12, n. 3, September 1988, pp.203-243, e in www.centroimpastato.com; P. Arlacchi La mafia imprenditrice. L’etica mafiosa e lo spirito del capitalismo, il Mulino, Bologna 1983, a cui è ispirata la legge antimafia del 1982, che non considerava la dimensione finanziaria che già allora si affermava a grandi passi.
[13] L. Sciascia, Le parrocchie di Regalpetra, Laterza, Bari 1956.
Fonte
«A futura memoria (se la memoria ha un futuro)» è il titolo del libro in cui, nel dicembre 1989, poco dopo la sua scomparsa, sono stati pubblicati alcuni scritti di Leonardo Sciascia, tra cui l’articolo del “Corriere della sera” del 10 gennaio 1987, con il titolo, redazionale, “I professionisti dell’antimafia” [1].
In quell’articolo Sciascia esordiva con una lunga citazione dal suo romanzo Il giorno della civetta, pubblicato nel 1961, in cui il protagonista, il capitano Bellodi, ripensa l’esperienza del prefetto Mori, durante il periodo fascista, disapprova la sua azione fondata sulla sospensione delle garanzie costituzionali in Sicilia e indica un’altra strada: «bisognerebbe sorprendere la gente nel covo dell’inadempienza fiscale, come in America… Bisognerebbe, di colpo, piombare nelle banche: mettere mani esperte nella contabilità… delle grandi e piccole aziende, revisionare i catasti… annusare intorno alle ville, le automobili fuori serie… e confrontare questi segni di ricchezza agli stipendi e tirarne il giusto senso». E aggiungeva un’altra autocitazione, tratta dal romanzo A ciascuno il suo, del 1966: «Ma il fatto è… che l’Italia è un così felice Paese che quando si cominciano a combattere le mafie vernacole vuol dire che se ne è stabilita una in lingua» [2].
Seguivano dei riferimenti al libro La mafia durante il fascismo dello storico Christopher Duggan, recentemente scomparso, e a una piéce teatrale, La Mafia, di Luigi Sturzo, il prete fondatore del Partito popolare, di cui si sono trovati solo gli abbozzi del quinto atto, che davano un’immagine inquietante della realtà della mafia [3]. Il riferimento centrale nel corpo dell’articolo era il libro di Duggan, considerato «un’accurata indagine e sensata analisi» su mafia e fascismo. In effetti il testo di Duggan era basato su una ricerca archivistica abbastanza attenta, ma arrivava a una conclusione inaccettabile: che il fascismo avesse inventato la mafia. Certamente il fascismo ha utilizzato la lotta alla mafia per risolvere i suoi conflitti interni, ma la mafia c’era, non era un’invenzione. Il prefetto Mori ha potuto agire solo fino a un certo punto; il tentativo di andare oltre quel punto, colpendo politici e grandi agrari collusi con la mafia, è stato arrestato con il suo precoce pensionamento. Sciascia utilizza il libro dello storico inglese per trarne un’indicazione: «l’antimafia come strumento di potere». E avverte che quello che è accaduto con il fascismo può «accadere anche in un sistema democratico, retorica aiutando e spirito critico mancando».
Per avallare questo assunto venivano fatti degli esempi: un sindaco, innominato, ma il riferimento era a Leoluca Orlando, che «per sentimento o per calcolo cominci ad esibirsi – in interviste televisive e scolastiche, in convegni, conferenze e cortei – come antimafioso, anche se dedicherà tutto il suo tempo a queste esibizioni e non ne troverà mai per occuparsi dei problemi del paese o della città che amministra». L’altro esempio aveva nomi e cognome: il magistrato Paolo Emanuele Borsellino che, per avere svolto indagini sulla mafia, aveva scavalcato un magistrato più anziano ed era stato nominato procuratore a Marsala. La conclusione di Sciascia era tranchant: «i lettori prendano atto che nulla vale più in Sicilia, per far carriera nella magistratura, del prender parte a processi di stampo mafioso». Era evidente che tutta l’analisi precedente, volta al passato, era solo una preparazione per questa sciabolata rivolta al presente.
Le reazioni all’articolo di Sciascia, Il Coordinamento antimafia
Le reazioni all’articolo di Sciascia, pubblicato con un titolo redazionale che appesantiva ancora di più il contenuto, furono furenti. Fra gli altri ci fu un comunicato dell’associazione Coordinamento antimafia che, utilizzando la classificazione antropologica del capomafia don Mariano, coprotagonista del romanzo Il giorno della civetta, che distingueva uomini, mezz’uomini, ominicchi, pigliainculo e quaquaracquà, definiva Sciascia un quaquaracquà, cioè una nullità, e lo relegava «ai margini della società civile» [4].
Il Coordinamento antimafia era nato nel 1984 su proposta del Centro Impastato. Dopo una fase abbastanza travagliata di convivenza, in cui aveva tentato di collegare il variegato mondo dell’antimafia cittadina (aderirono 38 organizzazioni, tra associazioni, centri, comitati, sezioni di partito, frange di sindacato, ma alcune organizzazioni esistevano solo sulla carta) nel 1986 si era formata una singola associazione che aveva mantenuto quella denominazione ma in realtà coordinava solo se stessa e si configurerà sempre più come tifoseria del sindaco. Con l’aiuto di stampa e televisione si poneva come l’unico verbo antimafia. Agiva insieme come claque e come ordalia, ignorando tutto ciò che si muoveva al di fuori di essa e non era pronto a intrupparsi nelle sue file.
Il comunicato del Coordinamento suscitava la reazione di Sciascia che, si può dire, non aspettava altro per infierire. Definiva il Coordinamento «frangia fanatica e stupida di quel costituendo o costituito potere… un potere fondato sulla lotta alla mafia che non consente dubbio, dissenso, critica. Ne sono soddisfatto: si sono consegnati all’opinione di chi sa di avere un’opinione, nella loro vera immagine». A dire di Sciascia esso coordinava «interessi politici e stupidità» [5]. E il «Giornale di Sicilia», che plaudiva all’articolo di Sciascia, pensò bene di pubblicare i nomi dei componenti del Coordinamento, qualcosa che somigliava a una schedatura e a una gogna.
Tenendo conto dell’esperienza personale, il mio giudizio sul Coordinamento è ancora più duro di quello di Sciascia: bisogna mettere nel conto anche una sequela di scorrettezze; si potrebbe dire: la scorrettezza come regola, come modello relazionale e modo di essere. Qualche esempio: comunicati approvati e non dati alla stampa, poiché c’era una supervisione, occulta ma evidente, dei dirigenti del Pci e delle Acli, allora affiancati nella lotta contro l’installazione dei missili nucleari a Comiso; il peso esercitato dalle appartenenze a partiti e organizzazioni nazionali, al limite dell’arroganza e della presunzione; la superficialità e la mancanza d’interesse di tanti, che pure godevano di credito e di pubblicità. Ma un conto è il giudizio politico un altro la gogna.
Alla testa del Coordinamento e suoi ispiratori erano personaggi che, a dimostrazione della tempra della loro fede e della loro coerenza, dopo sono passati nel centrodestra, in piena bufera di berlusconismo, come dire il picco dell’immoralità pubblica nella storia dell’Italia repubblicana. Sbocco non nuovo di trasversalismi teorizzati e praticati e di “estremismi” fasulli. Per esempio, il gesuita Ennio Pintacuda, punto di riferimento per l’antimafia più pubblicizzata e grande sostenitore di Orlando, fino allo scontro con il confratello Bartolomeo Sorge e l’abbandono della Compagnia di Gesù, si è riposizionato nell’area filoberlusconiana, avendone in cambio la direzione del Cerisdi, un centro studi che per molto tempo ha goduto di lauti finanziamenti pubblici e mirava a formare la classe dirigente della città [6]. Altri, tra cui gli estensori del comunicato antisciascia e allora in prima linea nel Coordinamento, sono letteralmente scomparsi.
Un buco nell’acqua: il comunicato del Centro Impastato
Nel tentativo di riportare la polemica a un confronto civile, mettendo al centro i problemi e lasciando da parte offese e insulti, come presidente del Centro Impastato scrivevo un comunicato pubblicato dal giornale “L’Ora”. Ecco il testo:
«Abbiamo preferito non prendere la parola nel corso delle recenti polemiche perché il tono di esse ci è sembrato il meno adatto per una riflessione seria su alcuni problemi particolarmente gravi, che rischiano di aggravarsi ulteriormente. Ci limitiamo adesso ad alcune considerazioni molto sommarie su qualcuno di essi.
1) Valutazione dell’operato del sindaco Orlando e della giunta pentapartito. Il sindaco Orlando ha compiuto alcuni gesti (quali, per esempio, la costituzione di parte civile del Comune al maxiprocesso, le dichiarazioni fatte nel corso di esso, il tentativo di portare un minimo di trasparenza nella procedura di aggiudicazione degli appalti di opere pubbliche) che non possono non essere apprezzati, ma tutti i problemi di Palermo (la disoccupazione, il risanamento del centro storico, il funzionamento delle aziende municipalizzate etc. etc.) restano irrisolti per ragioni che non è difficile individuare: la Democrazia Cristiana rimane legata ai peggiori interessi, sotto la tutela di uomini come Lima, e il pentapartito è un pantano che non consente nessuna politica rinnovatrice. Ci sembra arrivato il momento di fare un bilancio di questa amministrazione comunale e di vedere se è possibile sbloccare una situazione di immobilismo, avvelenata da polemiche personalistiche.
2) Conformismo e anticonformismo. In una città in cui straripa l’assuefazione alla violenza, la stragrande maggioranza degli abitanti non si scuote neppure per l’assassinio di un bambino, si svolgono manifestazioni in cui s’inneggia alla mafia, dominano il conformismo filomafioso e l’indifferenza, parlare di «conformismo antimafioso» ci sembra un po’ troppo.
3) Antimafia: seria o da vetrina. È vero, c’è un’antimafia “da vetrina”, come qualcuno l’ha definita, ma vogliamo fare qualche esempio? Ci sembrano «antimafia da vetrina»: l’azione, abbastanza incolore, dei vari Alti Commissari contro la mafia; l’altrettanto incolore operato delle Commissioni antimafia, nazionale e regionale; le prediche con il morto davanti; le scoperte di grandi e piccoli inviati che hanno dovuto attendere l’uccisione di Dalla Chiesa per parlare di mafia come «questione nazionale» e lo hanno dimenticato il giorno dopo; i fumetti televisivi e cinematografici e le pubblicazioni di mafiologi improvvisati regolarmente prefate da firme “prestigiose”; buona parte delle attività svolte nelle scuole per utilizzare in qualche modo i finanziamenti regionali; i centri inesistenti che hanno finanziamenti pubblici per centinaia di milioni; le sigle fabbricate sulle ceneri di ipotesi più consistenti che si è fatto di tutto per non far maturare. Si collocano su un altro versante i pochissimi magistrati che, rischiando la vita, hanno svolto le inchieste più impegnative contro la mafia.
4) Problema della “giustizia giusta”. È il problema più grosso, e non è di facile soluzione. La mafia e la criminalità organizzata non sono una novità, ma le dimensioni e la complessità attuali lo sono, e gli attuali ordinamenti giuridici sono inadeguati per fronteggiare fenomeni che non sono una “emergenza” ma un dato strutturale.
Ci chiediamo: ci può essere “giustizia giusta” con gli assassinii regolarmente impuniti? Si ritiene che, passata l’onda alta delle uccisioni, tutto si risolva con l’«uscita dall’emergenza» e il ristabilimento delle regole del «garantismo classico»? Non occorre piuttosto elaborare una riforma del processo penale e della normativa vigente che tenga conto di questi fatti nuovi? Come intervenire sui canali di accumulazione illegale? Come troncare il meccanismo di simbiosi tra capitale illegale e legale garantito dal segreto bancario? Non si tratta di decretare “stati d’assedio”, o di avallare “teoremi Buscetta”, ma di trovare soluzioni adeguate a problemi che non possono essere minimizzati o considerati con ottiche tradizionali.
Per affrontare seriamente questi temi non ci pare che siano utili le polemiche, soprattutto quando si risolvono in ingiurie e scomuniche. Occorrono: coraggio, studio, serenità[7]».
Il comunicato cadeva nel vuoto. Commentavo: «Non è il momento adatto per discutere seriamente e serenamente. Bisogna schierarsi, come se si fosse nel pieno di un combattimento senza esclusione di colpi» [8].
La promozione di Borsellino e la bocciatura di Falcone
Successivamente alla pubblicazione dell’articolo, c’è stato un incontro tra Sciascia e Borsellino, in cui ci sarebbe stato un “chiarimento”. Sciascia ha ammesso di essere stato “mal consigliato” e non si può non osservare che uno come lui, maître-à-penser già da anni, non poteva non essere consapevole degli effetti che le sue parole avrebbero avuto. Avrebbe potuto e dovuto far attenzione a chi lo consigliava e a cosa consigliava.
Se la ferita sembrava rimarginata, e i rapporti fra Sciascia e Borsellino erano diventati quasi amichevoli e cordiali, in realtà nel profondo essa rimaneva aperta e sanguinante. Dopo la strage di Capaci, in cui morirono Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo, gli agenti di scorta Rocco Dicillo, Antonio Montinaro e Vito Schifani, in un incontro pubblico Borsellino, già consapevole di un destino che si avvicinava, in un accorato intervento, in cui ricostruiva le difficoltà e le inimicizie che avevano segnato la vita e l’attività di Falcone, diceva: «Tutto cominciò con quell’articolo sui professionisti dell’antimafia» [9].
Falcone era stato ostacolato più volte e in vari modi: bocciata la sua candidatura a Consigliere istruttore, al posto di Rocco Chinnici, fondatore del pool antimafia, assassinato il 29 luglio 1983; bocciata la sua candidatura al Consiglio superiore della magistratura. Si potrebbe dire che, dopo la mafia, i principali nemici di Falcone siano stati i suoi colleghi. Per invidia, per il peso della sua personalità, non ostentato ma effettivo, per la sua visibilità.
Si è detto e scritto che la bocciatura della candidatura di Falcone a capo del’Ufficio istruzione, allora strategico nella attività giudiziaria antimafia e successivamente abolito, sia stata il frutto dell’applicazione del criterio dell’anzianità, che portò a favorire un magistrato come Antonino Meli, che mai si era occupato di mafia e che smantellerà il pool antimafia, portando indietro di anni l’attività giudiziaria contro la mafia. E siccome il rispetto del criterio fondato sull’anzianità era proprio quello che voleva Sciascia, la colpa sarebbe sua. Accusa che gli si è rivolta in passato ed è ritornata nel giorni scorsi, in occasione del trentennale dell’articolo sul “Corriere”.
Sciascia aveva già risposto a quell’accusa. In un articolo sulla “Stampa” del 6 agosto 1988, scriveva: nel promuovere Borsellino il CSM si era «sottratto alla regola vigente senza però stabilirne un’altra. Se l’avesse in quel momento stabilita, il caso del dottor Falcone, con tutto quel che oggi importa, non ci sarebbe stato. Adottando un criterio per promuovere Borsellino e tornando invece alla vecchia regola per non promuovere Falcone, ecco il nodo che presto o tardi sarebbe venuto al pettine. La situazione di oggi, insomma, non l’ho inventata io con quel mio articolo sul ‘Corriere’: c’era, e non poteva che esplodere. Io non ho fatto che avvertirla, e tempestivamente» [10]. Non si può non dargli ragione.
Trent’anni dopo
Perché a trent’anni dall’articolo di Sciascia quelle parole vengono ricordate e riesplodono le polemiche? Tornano a confrontarsi, senza dialogare, due schieramenti. C’è chi considera Sciascia un maestro di pensiero e di vita, un profeta, e invita al pentimento, all’autocritica; chi sta dall’altro lato allora e ancor’oggi lo considera un bastian contrario che ha fatto danni all’antimafia, provocando l’isolamento dei magistrati più impegnati ed esponendoli alle critiche e all’avversione di coloro che hanno usato le sue parole per condannare e auto assolversi. Possiamo definirli i “professionisti della mafia”, a cominciare dai politici, dagli imprenditori, più o meno collusi, che, facendosi scudo del prestigio dello scrittore, passavano dal silenzio e dalla difensiva al contrattacco, nel momento in cui erano in difficoltà e il maxiprocesso veniva percepito come un inizio e più d’uno pensava che prima o poi sarebbe toccato a lui. Da ciò nascerà, dopo il successo del maxiprocesso in tutti i tre gradi di giudizio, lo smantellamento del pool antimafia. Ma questo non c’entra con il parere di Sciascia. Però la sua polemica, sbagliata nel tono, nella scelta degli esempi e del tempo, si prestava a quel tipo di uso strumentale.
I problemi che lo scrittore poneva erano reali: il pericolo della strumentalizzazione dell’antimafia, il rispetto delle regole, la democrazia come unica strada per lottare la mafia, poiché ha «tra le mani lo strumento che la tirannia non ha: il diritto, la legge uguale per tutti, la bilancia della giustizia» [11]. Il tema di fondo del discorso di Sciascia era il sistema di garanzie, cioè il garantismo. Ne aveva un’idea che sapeva di religioso, come se si trattasse di una sorta di depositum fidei. Partendo da alcuni esempi concreti, aveva intravisto una sua violazione, che si era ritenuto in dovere di denunciare come un vulnus all’ordinamento democratico, ma per molti anni il culto del garantismo più che la certezza del diritto aveva assicurato la certezza dell’impunità.
Sciascia ha per molti anni esercitato una sorta di magistero civile: come abbiamo visto, aveva indicato, nei primi anni ’60, le banche come il terreno su cui sondare l’accumulazione mafiosa; precedendo di quasi trent’anni il mio saggio «La mafia finanziaria» scritto e pubblicato quando imperversava lo stereotipo della mafia imprenditrice, per giunta disorganizzata [12]. Il maestro di Racalmuto, dopo aver raccontato la provincia siciliana [13], ha percorso una linea narrativa che mischiava i generi letterari, con ampio spazio per la trattazione saggistica, l’analisi sociologica e il compte philosophique. Il costante ancoraggio alla tradizione illuministica più che un vezzo letterario era un modello di scrittura e un metodo di indagine. I suoi apologhi su una società mafiosizzata nei suoi centri di potere, nei suoi codici culturali, nella sua pratica quotidiana, costituiscono una variazione sul tema del potere e delle sue implicazioni criminali, e questo è un patrimonio ormai consegnato alla storia della letteratura e alla cultura, non solo italiana.
Trent’anni dopo possiamo chiederci se le sue parole sono state una profezia. Certo, con quel che è accaduto negli ultimi anni, siamo portati a pensarlo. Un breve elenco: imprenditori che si mostravano in prima fila nella lotta alla mafia incriminati per i loro rapporti con Cosa nostra; uno di essi, che passava per promotore del movimento antiracket, colto in flagrante mentre intascava una mazzetta; un telegiornalista, insignito di award internazionali, che ha fatto passare una faccenda di corna per aggressione mafiosa; una magistrata, dirigente dell’ufficio che gestisce i beni confiscati, che ne aveva fatto un’azienda privata, assegnandoli ai suoi amici e ricevendone favori, in un classico do ut des; una prefetta che le teneva bordone. Con questo campionario di “buoni esempi” si deve riconoscere che la realtà ha superato le rappresentazioni dello scrittore, ma potremmo dire che non ci troviamo di fronte a «professionisti dell’antimafia» (i professionisti, cioè persone capaci e competenti, ci vogliono, per l’antimafia come per qualsiasi altro tema, arduo e complesso, quelli che fanno danno sono i dilettanti e i cialtroni) ma a dei cattivi attori che hanno recitato la commedia dell’antimafia. La cosa grave, e che ci induce a una impietosa riflessione, è che tanti ci hanno creduto.
Ma quel che ci interessa oggi è lo “stato dell’arte” dell’antimafia. Cos’è accaduto dopo le polemiche del 1987, a parte gli episodi già richiamati? Sono sorti comitati, centri, associazioni e fondazioni, quasi tutti vanno avanti con finanziamenti ottenuti con metodi personalistici e clientelari. La proposta del Centro Impastato che la Regione Sicilia si doti di una legge che fissi criteri oggettivi per l’erogazione dei fondi pubblici è stata isolata, come se fosse una stranezza, la trovata eccentrica di chi non conosce le regole del gioco. In realtà, le conosce ma non le accetta.
Nel 1995 è nata Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie, sulla base di associazioni nazionali come le Acli, l’Arci, la Sinistra giovanile del Pds, legate direttamente o indirettamente ai partiti, e il primo, consistente, nucleo di adesioni si è costituito con l’elenco dalle loro sezioni locali, a prescindere se fossero o meno impegnate in attività antimafia. I referenti regionali sono stati nominati sulla base della loro appartenenze a queste associazioni. In Sicilia è toccato a una rappresentante dell’Arci, che mai si era vista in iniziative antimafia. Successivamente la referente si è candidata con Forza Italia ed è stata “dimissionata”. Dimissionati due vicepresidenti e i responsabili per il lavoro nelle scuole e per i beni confiscati, senza nessuna discussione. Chi scrive è stato sospeso, e si è dimesso, dopo aver posto problemi di democrazia interna, dovuti al leaderismo carismatico del fondatore, il sacerdote Luigi Ciotti. Recentemente è stato “licenziato” con un messaggino il figlio di Pio La Torre, protagonista delle lotte contadine, dirigente comunista e parlamentare nazionale, ucciso il 30 aprile del 1982.
Le attività continuative sono quelle nelle scuole, del movimento antiracket, per l’uso sociale dei beni confiscati. Nelle scuole l’educazione alla legalità si riduce troppo spesso a prediche senza analisi, al richiamo al rispetto delle leggi, ignorando che ancora più grave dell’illegalità mafiosa è quella delle istituzioni, che hanno troppi scheletri negli armadi e nessuna volontà di aprirli. Le associazioni antiracket, con esempi significativi, si limitano alle regioni meridionali, nonostante che le estorsioni siano ormai presenti sul territorio nazionale; l’uso sociale dei beni confiscati si limita a una decina di cooperative in tutta l’Italia.
Sul terreno della giustizia accanto a magistrati seriamente impegnati ci sono altri in vetrina o in giro con un personaggio come il direttore della rivista “Antimafia duemila”, che dice di avere ricevuto dalla Madonna di Fatima la mission di lottare la mafia, anticristo del nostro tempo, di avere le stimmate e di essere il maggiore esperto di Ufo! Qualche altro magistrato, smessa temporaneamente o definitivamente la toga, fa da foglia di fico a potenti in cerca di credenziali o si candida come salvatore della patria, andando incontro a patetici insuccessi. Sulla stampa e alla televisione qualcuno si atteggia a monopolista del pensiero unico antimafioso.
Il processo in corso sulla “trattativa” Stato-mafia rischia di delegare al potere giudiziario problemi, come il rapporto tra mafia, politica e istituzioni, che dovrebbero essere affrontati e risolti dall’intera società. Viviamo una crisi della democrazia, all’interno di una crisi più generale frutto del dominio del capitalismo finanziario e della dittatura del mercato globalizzato, che aggravano squilibri territoriali e divari sociali. In Italia, dopo vent’anni di Berlusconi, andato al potere con milioni di voti, sembrava che ci si potesse rialzare, con uno scatto di dignità. Ma i giovani “rottamatori” hanno fatto, o tentato di fare, quello che non è riuscito al patriarca di Arcore, abolendo l’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, che tutela i licenziati senza giusta causa, e progettando una riforma costituzionale impresentabile. Per fortuna il 4 dicembre c’è stato il referendum, ma non possiamo campare solo di referendum. Bisogna ripensare e ricostruire i fondamenti del vivere quotidiano. Su questa strada la lezione di Sciascia (considerato per tutta la sua opera, e non per un singolo episodio, che può essere criticabile) con i suoi meriti e le sue contraddizioni può essere un buon bagaglio di viaggio e le sue pagine, lette con attenzione e non con devozione, ci servono ancora per capire in che mondo viviamo, anche se la realtà è andata al di là delle sue più pessimistiche previsioni.
Note:
[1] L. Sciascia, A futura memoria (se la memoria ha un futuro), Bompiani, Milano 1989. Le citazioni successive sono tratte da questo libro.
[2] L. Sciascia, Il giorno della civetta, Einaudi, Torino 1961; A ciascuno il suo, Einaudi, Torino 1966.
[3] C. Duggan, La mafia durante il fascismo, Rubbettino, Soveria Mannelli 1986; L. Sturzo, La Mafia, in Scritti inediti 1890-1924, Cinque Lune, Roma 1974.
[4] Cfr. U. Santino, Storia del movimento antimafia. Dalla lotta di classe all’impegno civile, Editori Runiti University Press, Roma 2009, terza edizione, pp. 325 ss. Anche per le successive considerazioni si rimanda a questo testo.
[5] L. Sciascia, A futura memoria, cit., pp. 131 ss.
[6] U: Santino, Storia del movimento antimafia, cit., p. 395.
[7] “L’Ora”, 3 febbraio 1987, Troppa antimafia? ma dai; il comunicato è pubblicato in appendice al mio L’alleanza e il compromesso. Mafia e politica dai tempi di Lima e Andreotti ali giorni nostri, Rubbettino, Soveria Mannelli 1997, pp.269 s.
[8] U. Santino, L’alleanza e il compromesso, cit., p. 77.
[9] L’incontro, organizzato dalla rivista “Micromega”, si svolse il 25 giugno 1992, presso la Biblioteca comunale di Palermo.
[10] In L.Sciascia, A futura memoria, cit., p. 153.
[11] Ibidem, p. 139.
[12] U. Santino, La mafia finanziaria. Accumulazione illegale e complesso finanziario-industrale, in “Segno” nn. 69-70, aprile maggio 1986, pp. 7-49, trad. inglese: The financial mafia. The illegal accumulation of wealth and the financial-industrial complex, in “Contemporary Crises”, vol. 12, n. 3, September 1988, pp.203-243, e in www.centroimpastato.com; P. Arlacchi La mafia imprenditrice. L’etica mafiosa e lo spirito del capitalismo, il Mulino, Bologna 1983, a cui è ispirata la legge antimafia del 1982, che non considerava la dimensione finanziaria che già allora si affermava a grandi passi.
[13] L. Sciascia, Le parrocchie di Regalpetra, Laterza, Bari 1956.
Fonte
Iraq - Escalation della repressione, massacro di civili
di Roberto Prinzi
È stata l’ennesima giornata di sangue ieri in Iraq: le forze di sicurezza irachene hanno ucciso infatti almeno 45 manifestanti in varie aree del Paese. Il bilancio più grave (29 morti) si è registrato nella città meridionale di Nassiriya dove le truppe hanno aperto il fuoco sui dimostranti che bloccavano un ponte. Secondo fonti mediche, in città sarebbero decine i feriti. Migliaia di persone hanno poi sfidato il coprifuoco circondando il quartier generale dell’esercito.
Situazione molto tesa anche nella capitale Baghdad dove i manifestanti uccisi dalle pallottole vere e di gomma sparate dalla polizia sono stati 4. Bagno di sangue anche a Najaf dove 12 persone hanno perso la vita negli scontri con le forze dell’ordine. Nella città, importante meta di pellegrinaggio per gli sciiti e sede del potente clero sciita iracheno, la tensione è altissima da quando (mercoledì sera) i manifestanti hanno dato alle fiamme la rappresentanza diplomatica iraniana, situata non molto distante dall’abitazione della massima autorità sciita del Paese, l’Ayatollah al-Sistani. A gettare benzina sul fuoco è stato poi ieri Abu Mahdi al-Muhandis, il comandante delle Forze di Mobilitazione popolare (strettamente legate a Teheran), che ha minacciato che “taglierà le mani a chiunque proverà a toccare al-Sistani”.
L’assalto al consolato iraniano è di sicuro un dato politico molto significativo perché mostra in modo palese l’insofferenza di non pochi iracheni nei confronti dell’influenza di Teheran nell’Iraq post-Saddam, dono della “democrazia esportata” dagli occidentali (Usa in testa) nel 2003. Che la tensione sia alta è chiaro anche all’Iran che ieri sera ha deciso di chiudere il valico di confine di Mehran “per motivi di sicurezza”. A riferirlo è stata l’agenzia statale iraniana Mehr citando l’ufficiale di sicurezza Mojtaba Soleimani. “Con attenzione ai recenti eventi e ai tumulti avvenuti in Iraq, il valico di Mehran sarà chiuso a partire da stanotte” ha detto Soleimani che non ha chiarito quando sarà riaperto. L’ostilità montante anti-iraniana si tocca con mano a Najaf dove i manifestanti, per la stragrande maggioranza sciiti, hanno accusato le autorità locali di agire contro gli interessi del popolo iracheno pur di difendere gli interessi del potente vicino.
“Tutta la polizia antisommossa e le forze di sicurezza ci hanno sparato come se stessimo bruciando l’intero Iraq” ha sintetizzato un manifestante alla Reuters. Un altro di nome Alì ha descritto l’assalto al consolato come un “atto coraggioso”, “una reazione del popolo iracheno”. “Non vogliamo gli iraniani” ha chiosato. Da parte sua l’Iran, per bocca del suo ministro degli esteri, ha chiesto a Baghdad una “risposta ferma contro gli aggressori” del consolato. E la risposta è venuta subito ed è la stessa che si ripete dal 1 ottobre: pallottole vere, gas lacrimogeni sparati ad altezza uomo che hanno fatto schizzare il bilancio delle vittime delle proteste ad almeno 408 persone.
Di fronte alle istanze di migliaia di iracheni che da quasi due mesi scendono in strada chiedendo lo smantellamento dell’intero sistema di potere politico ed economico, fatto di corruzione, settarismo e liberismo selvaggio, la politica non sa offrire alcuna risposta se non quella basata sulla repressione. Il premier Abdel Mahdi si è finora rifiutato di dimettersi (lo ha ribadito in più incontri a cui ha preso parte anche Qassem Soleimani, il comandante delle Forze al-Quds delle Guardie Rivoluzionarie iraniane) e si è limitato ieri a convocare un comandante militare della provincia di Dhi Qar (dove è situata Nassiriya) per sapere quanto sta accadendo al sud. L’influente leader religioso Moqtada al-Sadr ha invece chiesto nuovamente al governo di dimettersi avvertendo però nello stesso tempo i manifestanti che la loro azione contro il consolato iraniano potrebbe portare a una violenta repressione delle proteste da parte di Baghdad. Sadr sta facendo astutamente l’equilibrista: pubblicamente si schiera con i manifestanti (“Non permettete di dare a loro [le autorità, ndr] un pretesto per porre fine alla vostra rivoluzione”) chiedendo con forza la fine del governo al-Mahdi perché se ciò non accade “è l’inizio della fine dell’Iraq”. Dall’altro, però, non arriva alla completa rottura con il governo e con le istituzioni (di cui fa parte) in questa fase dove gli esiti delle proteste appaiono ancora incerti.
Al di là del chiaro messaggio politico che porta con sé, quanto accaduto a Najaf con l’assalto al consolato iraniano potrebbe essere strumentalizzato dal governo per giustificare una maggiore repressione delle proteste. Se così si decidesse a Baghdad, potrebbe essere data luce verde al comandante del Forze di mobilitazione popolare Abu Mahdi al-Muhandis per chiudere la partita con i manifestanti. La scusa è giù pronta sul tavolo: è in gioco l’incolumità di al-Sistani. Eppure al-Sistani, massima figura sciita in Iraq, vestendo i panni del pompiere, sin dall’inizio ha ufficialmente sostenuto i manifestanti e ha invitato i politici ad ascoltare le loro richieste. Del resto il caos e l’incertezza non convengono al potente clero sciita locale, Sistani questo lo sa bene. Ma l’invito ad abbassare i toni dello scontro non è compreso a Baghdad: le autorità hanno infatti annunciato la creazione di “cellule di crisi” chiamati a gestire i servizi di sicurezza con l’obiettivo di fermare la protesta.
AGGIORNAMENTO
ore 16:50 Il premier iracheno Abdel Mahdi ha rassegnato le dimissioni
Il premier iracheno Adel Abdul Mahdi ha annunciato che presenterà le sue dimissioni al parlamento. Alcune ore prima, nel suo sermone settimanale, la massima autorità religiosa del Paese, lo sciita al-Sistani, aveva chiesto un cambiamento di leadership. Detto, fatto: nel suo comunicato Abdel Mahdi ha detto “di aver ascoltato con grande preoccupazione” le parole di al-Sistani e di aver preso questa decisione in risposta al suo appello così da “facilitare e sveltire il suo adempimento al più presto possibile”. La decisione giunge dopo la giornata di sangue di ieri durante la quale sono stati uccisi più di 50 dimostranti dalle forze di sicurezza irachene.
Le dimissioni di Abdul Mahdi sono state accolte a Baghdad con canti e gioia a Piazza Tahrir, centro delle proteste anti-governative. Tuttavia i manifestanti hanno subito ribadito che la loro lotta continuerà finché tutte le loro istanze non verranno implementate. “La condizione è che tutti i partiti se ne vadano. Non sono più accettabili. Tutti hanno preso parte agli omicidi criminali di dimostranti” ha detto uno di loro intervistato da al-Jazeera.
Fonte
È stata l’ennesima giornata di sangue ieri in Iraq: le forze di sicurezza irachene hanno ucciso infatti almeno 45 manifestanti in varie aree del Paese. Il bilancio più grave (29 morti) si è registrato nella città meridionale di Nassiriya dove le truppe hanno aperto il fuoco sui dimostranti che bloccavano un ponte. Secondo fonti mediche, in città sarebbero decine i feriti. Migliaia di persone hanno poi sfidato il coprifuoco circondando il quartier generale dell’esercito.
Situazione molto tesa anche nella capitale Baghdad dove i manifestanti uccisi dalle pallottole vere e di gomma sparate dalla polizia sono stati 4. Bagno di sangue anche a Najaf dove 12 persone hanno perso la vita negli scontri con le forze dell’ordine. Nella città, importante meta di pellegrinaggio per gli sciiti e sede del potente clero sciita iracheno, la tensione è altissima da quando (mercoledì sera) i manifestanti hanno dato alle fiamme la rappresentanza diplomatica iraniana, situata non molto distante dall’abitazione della massima autorità sciita del Paese, l’Ayatollah al-Sistani. A gettare benzina sul fuoco è stato poi ieri Abu Mahdi al-Muhandis, il comandante delle Forze di Mobilitazione popolare (strettamente legate a Teheran), che ha minacciato che “taglierà le mani a chiunque proverà a toccare al-Sistani”.
L’assalto al consolato iraniano è di sicuro un dato politico molto significativo perché mostra in modo palese l’insofferenza di non pochi iracheni nei confronti dell’influenza di Teheran nell’Iraq post-Saddam, dono della “democrazia esportata” dagli occidentali (Usa in testa) nel 2003. Che la tensione sia alta è chiaro anche all’Iran che ieri sera ha deciso di chiudere il valico di confine di Mehran “per motivi di sicurezza”. A riferirlo è stata l’agenzia statale iraniana Mehr citando l’ufficiale di sicurezza Mojtaba Soleimani. “Con attenzione ai recenti eventi e ai tumulti avvenuti in Iraq, il valico di Mehran sarà chiuso a partire da stanotte” ha detto Soleimani che non ha chiarito quando sarà riaperto. L’ostilità montante anti-iraniana si tocca con mano a Najaf dove i manifestanti, per la stragrande maggioranza sciiti, hanno accusato le autorità locali di agire contro gli interessi del popolo iracheno pur di difendere gli interessi del potente vicino.
“Tutta la polizia antisommossa e le forze di sicurezza ci hanno sparato come se stessimo bruciando l’intero Iraq” ha sintetizzato un manifestante alla Reuters. Un altro di nome Alì ha descritto l’assalto al consolato come un “atto coraggioso”, “una reazione del popolo iracheno”. “Non vogliamo gli iraniani” ha chiosato. Da parte sua l’Iran, per bocca del suo ministro degli esteri, ha chiesto a Baghdad una “risposta ferma contro gli aggressori” del consolato. E la risposta è venuta subito ed è la stessa che si ripete dal 1 ottobre: pallottole vere, gas lacrimogeni sparati ad altezza uomo che hanno fatto schizzare il bilancio delle vittime delle proteste ad almeno 408 persone.
Di fronte alle istanze di migliaia di iracheni che da quasi due mesi scendono in strada chiedendo lo smantellamento dell’intero sistema di potere politico ed economico, fatto di corruzione, settarismo e liberismo selvaggio, la politica non sa offrire alcuna risposta se non quella basata sulla repressione. Il premier Abdel Mahdi si è finora rifiutato di dimettersi (lo ha ribadito in più incontri a cui ha preso parte anche Qassem Soleimani, il comandante delle Forze al-Quds delle Guardie Rivoluzionarie iraniane) e si è limitato ieri a convocare un comandante militare della provincia di Dhi Qar (dove è situata Nassiriya) per sapere quanto sta accadendo al sud. L’influente leader religioso Moqtada al-Sadr ha invece chiesto nuovamente al governo di dimettersi avvertendo però nello stesso tempo i manifestanti che la loro azione contro il consolato iraniano potrebbe portare a una violenta repressione delle proteste da parte di Baghdad. Sadr sta facendo astutamente l’equilibrista: pubblicamente si schiera con i manifestanti (“Non permettete di dare a loro [le autorità, ndr] un pretesto per porre fine alla vostra rivoluzione”) chiedendo con forza la fine del governo al-Mahdi perché se ciò non accade “è l’inizio della fine dell’Iraq”. Dall’altro, però, non arriva alla completa rottura con il governo e con le istituzioni (di cui fa parte) in questa fase dove gli esiti delle proteste appaiono ancora incerti.
Al di là del chiaro messaggio politico che porta con sé, quanto accaduto a Najaf con l’assalto al consolato iraniano potrebbe essere strumentalizzato dal governo per giustificare una maggiore repressione delle proteste. Se così si decidesse a Baghdad, potrebbe essere data luce verde al comandante del Forze di mobilitazione popolare Abu Mahdi al-Muhandis per chiudere la partita con i manifestanti. La scusa è giù pronta sul tavolo: è in gioco l’incolumità di al-Sistani. Eppure al-Sistani, massima figura sciita in Iraq, vestendo i panni del pompiere, sin dall’inizio ha ufficialmente sostenuto i manifestanti e ha invitato i politici ad ascoltare le loro richieste. Del resto il caos e l’incertezza non convengono al potente clero sciita locale, Sistani questo lo sa bene. Ma l’invito ad abbassare i toni dello scontro non è compreso a Baghdad: le autorità hanno infatti annunciato la creazione di “cellule di crisi” chiamati a gestire i servizi di sicurezza con l’obiettivo di fermare la protesta.
AGGIORNAMENTO
ore 16:50 Il premier iracheno Abdel Mahdi ha rassegnato le dimissioni
Il premier iracheno Adel Abdul Mahdi ha annunciato che presenterà le sue dimissioni al parlamento. Alcune ore prima, nel suo sermone settimanale, la massima autorità religiosa del Paese, lo sciita al-Sistani, aveva chiesto un cambiamento di leadership. Detto, fatto: nel suo comunicato Abdel Mahdi ha detto “di aver ascoltato con grande preoccupazione” le parole di al-Sistani e di aver preso questa decisione in risposta al suo appello così da “facilitare e sveltire il suo adempimento al più presto possibile”. La decisione giunge dopo la giornata di sangue di ieri durante la quale sono stati uccisi più di 50 dimostranti dalle forze di sicurezza irachene.
Le dimissioni di Abdul Mahdi sono state accolte a Baghdad con canti e gioia a Piazza Tahrir, centro delle proteste anti-governative. Tuttavia i manifestanti hanno subito ribadito che la loro lotta continuerà finché tutte le loro istanze non verranno implementate. “La condizione è che tutti i partiti se ne vadano. Non sono più accettabili. Tutti hanno preso parte agli omicidi criminali di dimostranti” ha detto uno di loro intervistato da al-Jazeera.
Fonte
“Il ricatto su Taranto è un ricatto su tutto il paese”. Adesso alternative in campo
“La rassegnazione non è una opzione considerabile”. All’assemblea operaia chiamata dall’Usb a Taranto intorno alla vicenda dell’ex Ilva le idee sono chiare, fino alle conseguenze più impegnative.
La sala nel pomeriggio di giovedì si è riempita di lavoratrici e lavoratori dell’ex Ilva ma anche venuti da altri stabilimenti siderurgici e industriali di altre città. Dalla lontanissima Trieste a Terni, da Piombino a Melfi. Un po’ ovunque si è alle prese con crisi industriali, ristrutturazioni dolorose, svendite a multinazionali straniere, minacce di chiusure. È uno spaccato del paese reale e del suo sistema industriale che si va desertificando e centralizzando, come ricorda Stefano Zai di Parma, intorno alle nicchie produttive dell’industria 4.0 ma che azzera tutto il resto, soprattutto nel Meridione.
Tra gli operai e i delegati Usb dell’ex Ilva c’è l’aria pesante della consapevolezza di aver lanciato una sfida avanzata invocando quella “chiusura delle produzioni inquinanti” che va in direzione opposta a chi in questi anni ha giocato spregiudicatamente sulla contrapposizione tra lavoro, salute pubblica e ambiente.
L’assemblea viene introdotta da Francesco Rizzo, quadro operaio storico dell’ex Ilva e coordinatore dell’Usb tarantina. E non si perde in giri di parole. “A cosa serve lo scudo penale chiesto da ArcelorMittal. Se lo chiedi direttamente ai politici non sanno come e cosa rispondere. La risposta ce l’abbiamo noi – dice Rizzo – serve a non andare in galera anche se continui a far lavorare dentro una fabbrica che sta cadendo a pezzi ed in cui si rischia la vita".
Rizzo insiste nel voler chiarire un aspetto importante: “Noi abbiamo chiesto la nazionalizzazione dell’ex Ilva e non solo l’intervento pubblico con lo Stato che mette solo i soldi. Il problema è pianificare la chiusura e la riconversione e i privati non lo vorranno mai fare. Per impedirlo vengono invocate le regole europee che vietano gli aiuti di Stato ma sappiamo che non è vero, perché in altri paesi lo hanno fatto e lo abbiamo verificato”.
Sasha Colautti viene da Trieste. Anche lì la situazione è pesante e ci sono ormai 6 crisi industriali – dalle Ferriere alla Flextronics, dalla Wartsila alle cartiere Burgo – in cui la politica nazionale e locale sono latitanti.
L’inquinamento pesa anche a Trieste. Nel quartiere di Servola dove ci sono le Ferriere hanno chiuso i giardini pubblici e quelli delle scuole. La stessa proprietà vuole chiudere l’area a caldo, ma senza una politica industriale che preveda altro non ci sono soluzioni se non quelle speculative sui fabbricati industriali da cedere magari per l’allargamento della banchina portuale. Se non si pensa ad un altro modello di sviluppo c’è solo la chiusura e basta.
Raffaele Cataldi è un operaio dell’Ilva ma è anche un attivista del Comitato Liberi e Pensanti, quelli che nel 2012 ruppero l’incantesimo contestando il comizio della manifestazione sindacale chiamata contro la decisione della magistratura di fermare le produzioni inquinanti. “La fabbrica si sta chiudendo da sola perché cade a pezzi” e fa riferimento come modello all’accordo di programma firmato a Genova dove c’è un altro stabilimento dell’Ilva. Sono in molti a chiedersi perché quell’accordo si fece a Genova e non anche a Taranto, come se nel Sud e a Taranto ci fossero dei cittadini di serie B. Sulla stessa lunghezza d’onda insiste anche Daniela Spera di un’altra associazione ambientalista. Anche lei parla di programmazione della chiusura della fabbrica. “Negli anni scorsi quando fornivamo i dati sulla salute, la mortalità e l’inquinamento ci accusavano di essere allarmisti. Adesso, finalmente siamo uniti sugli stessi obiettivi”.
Sergio Bellavita dell’Usb suona l’allarme. “Ad ArcelorMittal se dai un dito si prende tutto il braccio. Su questa vicenda si gioca una partita più ampia, inclusa quella di un nuovo tipo di intervento pubblico nell’economia, soprattutto al Sud”. Torna spesso la parola ricatto, per Bellavita quello sull’Ilva e come e forse più grave di quello di Marchionne sugli stabilimenti Fiat nel 2010.
Luciano Staccioli di Alitalia sottolinea come la vicenda dell’Ilva e quella di Alitalia abbiano molto in comune, incluso il tema della sicurezza che sta diventando pesante anche in questo settore e che ha portato al licenziamento di un delegato Usb. All’Alitalia c’erano 23mila lavoratrici e lavoratori ed ora sono 11mila, c’erano 230 aerei ed ora 118 eppure i passeggeri sono raddoppiati. “Abbiamo subito 11mila licenziamenti, tre ristrutturazioni e le perdite sono aumentate. Non è vero che lo Stato ha continuato a buttare soldi in Alitalia, ha speso 4 miliardi ma di fatto solo per finanziare i licenziamenti”. I gruppi stranieri come Delta hanno messo a disposizione solo 100 milioni per entrare in Alitalia, mentre Lufthansa vuole subito 3mila licenziamenti. Atlantia vuole la salvaguardia delle concessioni autostradali e di quelle aeroportuali, inclusa la quarta pista sui terreni adiacenti a Fiumicino acquistati a suo tempo dai Benetton dopo la privatizzazione di Maccarese da parte dell’Iri. “Noi chiediamo una nazionalizzazione e una sorta di nuova “Iri 4.0” e, contestualmente, la revoca delle concessioni autostradali e aeroportuali ad Atlantia”.
Giorgio Cremaschi ha salutato il coraggio di aver saputo costruire un fronte comune sull’Ilva lì dove prima c’erano divisioni. “L’Ilva è un rischio di morte sia per chi ci lavora dentro, sia per chi sta fuori”. Se un magistrato, un sindacato o i lavoratori avessero fermato il lavoro alla ThyssenKrupp di Torino due giorni prima della strage di operai nel 2007, sarebbero stati messi sotto accusa come accade adesso all’Usb dell’Ilva afferma Cremaschi, secondo il quale “la vicenda dell’Ilva può diventare anche un’occasione per Taranto e il paese per cominciare a cambiare le priorità, a pianificare la riconversione ecologica che i padroni privati e le multinazionali non faranno mai”.
Per Daniele Pica, che viene da Terni e lavora alla Acciai Speciali di proprietà della ThyssenKrupp, “quella della Usb non è solo una scelta coraggiosa ma è anche una visione”. Siamo vittime di “una classe politica di cialtroni che stanno facendo passare il paese da produttore a trasformatore di prodotti e quindi facendola diventare dipendente dall’estero”, per questo c’è bisogno della nazionalizzazione, “quando lo dicevamo alcuni anni fa ci prendevano per matti”.
Pierpaolo Leonardi dell’esecutivo nazionale Usb mostra un manifesto di solidarietà con gli operai dell’ex Ilva da parte dei sindacalisti del Lab degli stabilimenti ArcelorMittal nei Paesi Baschi. Per Leonardi l’Usb dell’Ilva ha fatto un miracolo sia per la fabbrica che per la città, “ha messo gli operai davanti ad una prospettiva difficile ma vera, ossia chiudere le produzioni inquinanti”. Ricorda come due iscritti Usb all’Ilva e uno agli Aeroporti di Roma siano stati licenziati recentemente perché hanno fermato il lavoro denunciando le minacce alla sicurezza. Secondo Leonardi lo sciopero convocato per oggi, venerdì 29 novembre, deve far saltare l’accordo raggiunto tra governo e ArcelorMittal, “gli accordi a perdere non possono più essere accettati”. Non solo. “La contraddizione capitale/natura oltre quella capitale/lavoro, sta dentro la visione dell’Usb, per questo è stato convocato lo sciopero in occasione del Friday For Future".
Sul nodo della discussione ossia la nazionalizzazione, Leonardi ci tiene a precisare che occorre stanare Governo e Parlamento sulla programmazione industriale. “Il ministro Patuanelli ad una domanda se volesse per caso una nuova IRI ha risposto: perché no? E lo abbiamo invitato a questo convegno, anche perché al Ministero dello Sviluppo Economico ci sono quasi 160 tavoli di crisi industriali aperti anche da anni e senza soluzioni. Su questo ormai ci vuole una proposta complessiva sulla quale intendiamo aprire il confronto e lavorare da subito”.
Intervengono poi operai e delegati dalla Fca di Melfi e delle Acciaierie di Piombino (passate all’indiana Jindal), Riadh della Logistica, un operaio della Flextronics che dichiara esplicitamente come “la rassegnazione non è più una opzione”. Interessante l’intervento di Stefano Zai da Parma che ha decostruito due narrazioni tossiche: quella sulla concentrazione dello sviluppo di alcune aree del Nord (Emilia, Lombardia, Veneto) che però terziarizza al ribasso il resto del paese e quella sulle magnificenze dell’industria 4.0. L’automazione, a livello mondiale, tra il 2015 e il 2020 ha distrutto 7 milioni di posti di lavoro e ne ha creati solo due. Secondo una proiezione uscita su Il Sole 24 Ore, l’industria 4.0 in Italia tra il 2017 e il 2035 porterà alla scomparsa di 3,5 milioni di posti di lavoro. “Se non si istituisce un reddito sociale vero non legato obbligatoriamente alla prospettiva lavorativa, esploderà la disoccupazione tecnologica”.
Francesco Rizzo ha tirato le conclusioni dando appuntamento a tutti alle 5:15 di oggi davanti alle portinerie dell’Ilva per invitare allo sciopero e poi in piazza per il corteo dello sciopero generale. Il corteo operaio, significativamente, confluirà nella piazza conclusiva insieme a quello degli studenti di Friday for Future. Anche questo è un segno della svolta possibile, a partire da Taranto ma per tutto il paese.
Fonte
La sala nel pomeriggio di giovedì si è riempita di lavoratrici e lavoratori dell’ex Ilva ma anche venuti da altri stabilimenti siderurgici e industriali di altre città. Dalla lontanissima Trieste a Terni, da Piombino a Melfi. Un po’ ovunque si è alle prese con crisi industriali, ristrutturazioni dolorose, svendite a multinazionali straniere, minacce di chiusure. È uno spaccato del paese reale e del suo sistema industriale che si va desertificando e centralizzando, come ricorda Stefano Zai di Parma, intorno alle nicchie produttive dell’industria 4.0 ma che azzera tutto il resto, soprattutto nel Meridione.
Tra gli operai e i delegati Usb dell’ex Ilva c’è l’aria pesante della consapevolezza di aver lanciato una sfida avanzata invocando quella “chiusura delle produzioni inquinanti” che va in direzione opposta a chi in questi anni ha giocato spregiudicatamente sulla contrapposizione tra lavoro, salute pubblica e ambiente.
L’assemblea viene introdotta da Francesco Rizzo, quadro operaio storico dell’ex Ilva e coordinatore dell’Usb tarantina. E non si perde in giri di parole. “A cosa serve lo scudo penale chiesto da ArcelorMittal. Se lo chiedi direttamente ai politici non sanno come e cosa rispondere. La risposta ce l’abbiamo noi – dice Rizzo – serve a non andare in galera anche se continui a far lavorare dentro una fabbrica che sta cadendo a pezzi ed in cui si rischia la vita".
Rizzo insiste nel voler chiarire un aspetto importante: “Noi abbiamo chiesto la nazionalizzazione dell’ex Ilva e non solo l’intervento pubblico con lo Stato che mette solo i soldi. Il problema è pianificare la chiusura e la riconversione e i privati non lo vorranno mai fare. Per impedirlo vengono invocate le regole europee che vietano gli aiuti di Stato ma sappiamo che non è vero, perché in altri paesi lo hanno fatto e lo abbiamo verificato”.
Sasha Colautti viene da Trieste. Anche lì la situazione è pesante e ci sono ormai 6 crisi industriali – dalle Ferriere alla Flextronics, dalla Wartsila alle cartiere Burgo – in cui la politica nazionale e locale sono latitanti.
L’inquinamento pesa anche a Trieste. Nel quartiere di Servola dove ci sono le Ferriere hanno chiuso i giardini pubblici e quelli delle scuole. La stessa proprietà vuole chiudere l’area a caldo, ma senza una politica industriale che preveda altro non ci sono soluzioni se non quelle speculative sui fabbricati industriali da cedere magari per l’allargamento della banchina portuale. Se non si pensa ad un altro modello di sviluppo c’è solo la chiusura e basta.
Raffaele Cataldi è un operaio dell’Ilva ma è anche un attivista del Comitato Liberi e Pensanti, quelli che nel 2012 ruppero l’incantesimo contestando il comizio della manifestazione sindacale chiamata contro la decisione della magistratura di fermare le produzioni inquinanti. “La fabbrica si sta chiudendo da sola perché cade a pezzi” e fa riferimento come modello all’accordo di programma firmato a Genova dove c’è un altro stabilimento dell’Ilva. Sono in molti a chiedersi perché quell’accordo si fece a Genova e non anche a Taranto, come se nel Sud e a Taranto ci fossero dei cittadini di serie B. Sulla stessa lunghezza d’onda insiste anche Daniela Spera di un’altra associazione ambientalista. Anche lei parla di programmazione della chiusura della fabbrica. “Negli anni scorsi quando fornivamo i dati sulla salute, la mortalità e l’inquinamento ci accusavano di essere allarmisti. Adesso, finalmente siamo uniti sugli stessi obiettivi”.
Sergio Bellavita dell’Usb suona l’allarme. “Ad ArcelorMittal se dai un dito si prende tutto il braccio. Su questa vicenda si gioca una partita più ampia, inclusa quella di un nuovo tipo di intervento pubblico nell’economia, soprattutto al Sud”. Torna spesso la parola ricatto, per Bellavita quello sull’Ilva e come e forse più grave di quello di Marchionne sugli stabilimenti Fiat nel 2010.
Luciano Staccioli di Alitalia sottolinea come la vicenda dell’Ilva e quella di Alitalia abbiano molto in comune, incluso il tema della sicurezza che sta diventando pesante anche in questo settore e che ha portato al licenziamento di un delegato Usb. All’Alitalia c’erano 23mila lavoratrici e lavoratori ed ora sono 11mila, c’erano 230 aerei ed ora 118 eppure i passeggeri sono raddoppiati. “Abbiamo subito 11mila licenziamenti, tre ristrutturazioni e le perdite sono aumentate. Non è vero che lo Stato ha continuato a buttare soldi in Alitalia, ha speso 4 miliardi ma di fatto solo per finanziare i licenziamenti”. I gruppi stranieri come Delta hanno messo a disposizione solo 100 milioni per entrare in Alitalia, mentre Lufthansa vuole subito 3mila licenziamenti. Atlantia vuole la salvaguardia delle concessioni autostradali e di quelle aeroportuali, inclusa la quarta pista sui terreni adiacenti a Fiumicino acquistati a suo tempo dai Benetton dopo la privatizzazione di Maccarese da parte dell’Iri. “Noi chiediamo una nazionalizzazione e una sorta di nuova “Iri 4.0” e, contestualmente, la revoca delle concessioni autostradali e aeroportuali ad Atlantia”.
Giorgio Cremaschi ha salutato il coraggio di aver saputo costruire un fronte comune sull’Ilva lì dove prima c’erano divisioni. “L’Ilva è un rischio di morte sia per chi ci lavora dentro, sia per chi sta fuori”. Se un magistrato, un sindacato o i lavoratori avessero fermato il lavoro alla ThyssenKrupp di Torino due giorni prima della strage di operai nel 2007, sarebbero stati messi sotto accusa come accade adesso all’Usb dell’Ilva afferma Cremaschi, secondo il quale “la vicenda dell’Ilva può diventare anche un’occasione per Taranto e il paese per cominciare a cambiare le priorità, a pianificare la riconversione ecologica che i padroni privati e le multinazionali non faranno mai”.
Per Daniele Pica, che viene da Terni e lavora alla Acciai Speciali di proprietà della ThyssenKrupp, “quella della Usb non è solo una scelta coraggiosa ma è anche una visione”. Siamo vittime di “una classe politica di cialtroni che stanno facendo passare il paese da produttore a trasformatore di prodotti e quindi facendola diventare dipendente dall’estero”, per questo c’è bisogno della nazionalizzazione, “quando lo dicevamo alcuni anni fa ci prendevano per matti”.
Pierpaolo Leonardi dell’esecutivo nazionale Usb mostra un manifesto di solidarietà con gli operai dell’ex Ilva da parte dei sindacalisti del Lab degli stabilimenti ArcelorMittal nei Paesi Baschi. Per Leonardi l’Usb dell’Ilva ha fatto un miracolo sia per la fabbrica che per la città, “ha messo gli operai davanti ad una prospettiva difficile ma vera, ossia chiudere le produzioni inquinanti”. Ricorda come due iscritti Usb all’Ilva e uno agli Aeroporti di Roma siano stati licenziati recentemente perché hanno fermato il lavoro denunciando le minacce alla sicurezza. Secondo Leonardi lo sciopero convocato per oggi, venerdì 29 novembre, deve far saltare l’accordo raggiunto tra governo e ArcelorMittal, “gli accordi a perdere non possono più essere accettati”. Non solo. “La contraddizione capitale/natura oltre quella capitale/lavoro, sta dentro la visione dell’Usb, per questo è stato convocato lo sciopero in occasione del Friday For Future".
Sul nodo della discussione ossia la nazionalizzazione, Leonardi ci tiene a precisare che occorre stanare Governo e Parlamento sulla programmazione industriale. “Il ministro Patuanelli ad una domanda se volesse per caso una nuova IRI ha risposto: perché no? E lo abbiamo invitato a questo convegno, anche perché al Ministero dello Sviluppo Economico ci sono quasi 160 tavoli di crisi industriali aperti anche da anni e senza soluzioni. Su questo ormai ci vuole una proposta complessiva sulla quale intendiamo aprire il confronto e lavorare da subito”.
Intervengono poi operai e delegati dalla Fca di Melfi e delle Acciaierie di Piombino (passate all’indiana Jindal), Riadh della Logistica, un operaio della Flextronics che dichiara esplicitamente come “la rassegnazione non è più una opzione”. Interessante l’intervento di Stefano Zai da Parma che ha decostruito due narrazioni tossiche: quella sulla concentrazione dello sviluppo di alcune aree del Nord (Emilia, Lombardia, Veneto) che però terziarizza al ribasso il resto del paese e quella sulle magnificenze dell’industria 4.0. L’automazione, a livello mondiale, tra il 2015 e il 2020 ha distrutto 7 milioni di posti di lavoro e ne ha creati solo due. Secondo una proiezione uscita su Il Sole 24 Ore, l’industria 4.0 in Italia tra il 2017 e il 2035 porterà alla scomparsa di 3,5 milioni di posti di lavoro. “Se non si istituisce un reddito sociale vero non legato obbligatoriamente alla prospettiva lavorativa, esploderà la disoccupazione tecnologica”.
Francesco Rizzo ha tirato le conclusioni dando appuntamento a tutti alle 5:15 di oggi davanti alle portinerie dell’Ilva per invitare allo sciopero e poi in piazza per il corteo dello sciopero generale. Il corteo operaio, significativamente, confluirà nella piazza conclusiva insieme a quello degli studenti di Friday for Future. Anche questo è un segno della svolta possibile, a partire da Taranto ma per tutto il paese.
Fonte
MES, si profila uno scontro istituzionale
Siamo ritornati al 1989, quando, con la caduta del Muro di Berlino, il Presidente Cossiga picconò il Parlamento. L’oggetto del contendere ora è il Mes che, a quanto pare, sembra sia stato sottoscritto il 21 giugno scorso da Conte nonostante una risoluzione contraria della maggioranza parlamentare.
I leghisti stanno allertando costituzionalisti e giuristi per, eventualmente, denunciare il Presidente del Consiglio. Oggi Salvini invoca l’intervento di Mattarella.
E qui sta il vulnus. Il Presidente della Repubblica, ma questo discorso vale da Oscar Luigi Scalfaro in poi, è espressione diretta anche generazionale del principio europeo, Mattarella invoca l’Europa, o meglio l’Unione Europea, a ogni discorso pubblico.
Come si comporterà ora, visto che si profila una violazione del regime parlamentare come previsto dalla Costituzione del 1948? Si può dire quel che si vuole, ma la Lega ha ora la stessa forza elettorale del Pci degli anni settanta, assieme a Fdi supera il 40%. Parla a nome delle banche cooperative, delle piccole e medie imprese, dei professionisti, ma anche degli operai, queste ultime figure avendo da decenni abbandonato i partiti di “sinistra”.
Cossiga picconò il Pci, ma aveva un obiettivo, transitare il paese dopo la caduta del Muro di Berlino.
Una chiarezza che manca in questo Paese da due decenni. Rino Formica da un anno esorta Mattarella a mandare una lettera al Parlamento anche per verificare la posizione del nostro Paese circa l’Ue, per non subire sempre. Quella lettera non è mai pervenuta.
Ora Salvini coinvolge Mattarella, sul Mes vi potrebbe essere un potenziale conflitto istituzionale. Ma a quel punto, occorre dirlo, siamo ancora in una Repubblica Parlamentare o, a partire da Scalfaro, ma ancor di più con Napolitano, siamo in una Repubblica Presidenziale?
I cittadini hanno votato nel 2016 no alla riforma costituzionale. Sarebbe bene che Mattarella mandi un messaggio ufficiale alle Camere. Grande è la confusione sotto il cielo, la situazione potrebbe essere eccellente.
Fonte
I leghisti stanno allertando costituzionalisti e giuristi per, eventualmente, denunciare il Presidente del Consiglio. Oggi Salvini invoca l’intervento di Mattarella.
E qui sta il vulnus. Il Presidente della Repubblica, ma questo discorso vale da Oscar Luigi Scalfaro in poi, è espressione diretta anche generazionale del principio europeo, Mattarella invoca l’Europa, o meglio l’Unione Europea, a ogni discorso pubblico.
Come si comporterà ora, visto che si profila una violazione del regime parlamentare come previsto dalla Costituzione del 1948? Si può dire quel che si vuole, ma la Lega ha ora la stessa forza elettorale del Pci degli anni settanta, assieme a Fdi supera il 40%. Parla a nome delle banche cooperative, delle piccole e medie imprese, dei professionisti, ma anche degli operai, queste ultime figure avendo da decenni abbandonato i partiti di “sinistra”.
Cossiga picconò il Pci, ma aveva un obiettivo, transitare il paese dopo la caduta del Muro di Berlino.
Una chiarezza che manca in questo Paese da due decenni. Rino Formica da un anno esorta Mattarella a mandare una lettera al Parlamento anche per verificare la posizione del nostro Paese circa l’Ue, per non subire sempre. Quella lettera non è mai pervenuta.
Ora Salvini coinvolge Mattarella, sul Mes vi potrebbe essere un potenziale conflitto istituzionale. Ma a quel punto, occorre dirlo, siamo ancora in una Repubblica Parlamentare o, a partire da Scalfaro, ma ancor di più con Napolitano, siamo in una Repubblica Presidenziale?
I cittadini hanno votato nel 2016 no alla riforma costituzionale. Sarebbe bene che Mattarella mandi un messaggio ufficiale alle Camere. Grande è la confusione sotto il cielo, la situazione potrebbe essere eccellente.
Fonte
Le comiche politiche intorno alla tragedia del “nuovo MES”
Vedere un ministro “tecnico” ironizzare sui “presunti rischi” derivanti dal nuovo Meccanismo Europeo di Stabilità fa uno strano effetto; specie se premette “il trattato è già scritto ed è inemendabile”, e quindi il Parlamento non ci può fare niente. Da quando in qua un accordo “vantaggioso per il Paese” deve essere raggiunto nella più totale segretezza?
Della serie: siamo tutti noi i cretini, gli ignoranti o soltanto sospettosi, oppure è lui che mente buttandola in “coglionarella”?
In alcuni passaggi ha ricordato addirittura la versione italiana di “Alì il comico”, quel generale di Saddam che davanti alle telecamere ridacchiava negando che gli americani stessero avanzando, mentre in pratica stavano per apparire alle sue spalle...
Ricordiamo che su questi “pericoli” si erano espressi nella scorse settimane personaggi “tecnicamente” ben più influenti di noi, dal governatore della Banca d’Italia (Ignazio Visco), a ex senatori Pd ora in Confindustria (Giampaolo Galli), il presidente del Centro Europa Ricerche (Vladimiro Giacchè) e una massa di economisti di ogni livello che in genere plaudono a tutte le scelte dell’Unione Europea.
Last but not least, persino un veterano del neoliberismo più cieco come Francesco Giavazzi, ha speso un editoriale sul Corriere della Sera per dire che “ha ragione chi teme che le proposte di riforma del Fondo comportino dei rischi per l’Italia”. Salvo poi arrendersi subito, perché “sul Fondo salva-Stati ormai è tardi. Fra l’altro il precedente governo le aveva approvate prima dell’estate. Ora, contraddicendoci, potremmo solo opporre il nostro veto”.
Ma la vera fucilata contro la “comicità” del ministro Gualtieri è arrivata ieri mattina con un fondo a firma di Angelo De Mattia, che come economista esperto di finanza sicuramente “pesa” qualcosa più dell’ex tecnoburocrate europeo chiamato a fare il ministro. In fondo De Mattia può vantare una lunga carriera da dirigente in Banca d’Italia e ancora oggi guida l’ufficio studi della Fondazione Generali; mentre il ministro ha avuto una formazione da storico.
Il punto critico è colto con assoluta precisione. Passare – come Gualtieri ha ammesso – da requisiti impliciti a requisiti espliciti per la valutazione sulla sostenibilità del debito pubblico di un paese significa fornire un quadro certo non solo per la fornitura di prestiti, ma anche per l’iniziativa di qualsiasi speculatore sul mercato.
Se si è insomma certi che in determinate condizioni quantitativamente fissate uno Stato sarà costretto a ristrutturare il proprio debito (ossia a svalutare drasticamente i titoli di stato emessi e posseduti dalle banche, quasi sempre italiane), quella possibilità oggi solo ipotetica (l’Italia o altri paesi vicini al default) potrà diventare concreta con molta più facilità.
In secondo luogo, se è vero che il passaggio sulla “ristrutturazione del debito” non compare più nel testo dell’accordo già sottoscritto a giugno (con la Lega al governo!), altrettanto non si può dire sui working documents che stanno venendo fuori in questi giorni. Il Messaggero, per esempio, cita diffusamente un “allegato nascosto” – tra quelli che lo stesso Gualtieri ha definito “un lavoro sugli aspetti esterni” al trattato – che invece dovrebbe preoccupare anche il ministro. Vedi qui.
Tanto più che le decisioni del Mes non vengono prese all’unanimità (come nella Commissione Europea), ma a maggioranza, secondo le quote versate dai singoli paesi per il Fondo stesso. E lì, con Germania e Francia che da sole “pesano” per il 47% (rispettivamente 27 e 20), ci vuole un attimo a fare la maggioranza che ti stronca.
In effetti, a ben vedere, la sagoma di “Alì il comico” svolazza davvero anche sul palcoscenico italiano...
Angelo De Mattia – Milano Finanza
Nell’audizione tenuta ieri in Senato, il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, ha esordito affermando di avere ascoltato con stupore e con divertimento le tesi infondate sostenute dai critici della bozza dell’accordo intergovernativo sul Meccanismo europeo di stabilita.
Ha abbondato nelle aggettivazioni e nel sarcasmo, definendo comica l’affermazione secondo la quale la riforma del Fondo salva-Stati sarebbe una «terribile innovazione».
Ma basta seguire gli sviluppi del suo ragionamento perché si constati il calo dell’asserita comicità.
Gualtieri afferma che la revisione ha mirato a prevedere per il Mes una funzione di backstop del Fondo di risoluzione delle banche finanziato dai contributi delle stesse banche. Su questo punto, per la verità, nessuno ha mosso obiezioni, se non quelle, più generali, che riguardano l’adeguatezza di tale fondo, a prescindere dal «paracadute», e il fatto che esso è il secondo pilastro dell’Unione bancaria, mentre resta inedificato il terzo, assai importante, pilastro che è quello dell’assicurazione europea dei depositi.
Quanto ai criteri di ammissibilità alle linee di credito del Mes, il ministro osserva che si è trattato di esplicitare indicatori, in precedenza impliciti, della situazione fiscale e degli squilibri macroeconomici, nonché altri criteri concernenti la sostenibilità dei bilanci.
Il passaggio da requisiti impliciti a requisiti espliciti, il cui controllo spetterà alla Commissione Ue e al Mes, è acqua fresca? Che, poi, questi requisiti, quantitativi e qualitativi, siano indicati in un allegato all’accordo intergovemativo che può essere modificato, ha detto Gualtieri, con maggiore facilità rispetto al testo dell’accordo, non suggerisce di proporre sin d’ora modifiche, anziché indugiare in una ironia a buon mercato?
Poi Gualtieri ha aggiunto che i criteri quantitativi, riportati in un allegato all’accordo, vanno rispettati solo «in linea di principio» e, dunque, sono sottoposti a un regime di discrezionalità.
Insomma, si deve far leva, ove mai fosse necessario accedere ai finanziamenti, sulla buona disponibilità dei partner europei perché si impieghi la discrezionalità in senso favorevole? Siamo anche qui all’apoteosi della flessibilità?
È indubbio, poi, che con la modifica del tipo di voto che le riguarda, le clausole di azione collettiva vengano rafforzate. Ma il punctum dolens resta: con esplicitazioni e rafforzamenti di specifiche previsioni, il giudizio sulla sostenibilità del debito diventa più duro e le conseguenze che se ne traggono sul debitonon sono per nulla irrilevanti.
Di fatto, anche a prescindere dalla terminologia adottata, vi sarà, nei casi di non sostenibilità, l’obbligo di una ristrutturazione del debito che sarà la condizione per ottenere i prestiti. A questa parteciperanno anche i privati portatori dei titoli.
È indubbio, poi, che il rango del nuovo Fondo, per le maggiori attribuzioni, salga di livello nei confronti della Commissione. Non interessa sapere, ora, di quanto il Mes si discosti dalla precedente versione, anche perché, se si innova e lo si vuole fare seriamente, non si devono trovare le giustificazioni in ciò che è già vigente e costituisce una stortura.
Sarebbe singolare avere la pretesa di dividere ciò che, secondo un assai superficiale giudizio, tutto sommato si potrebbe accettare ed è quel che ora viene inserito ex novo nell’accordo, da ciò che non va bene, ma è già presente nell’intesa e, dunque, non si potrebbe modificare, chissà perché, autolimitandosi a priori.
La sostanza del Mes non è ridimensionata seriamente dal ministro, che su di un solo punto ha ragione, quando solleva il problema dei progetti, in primis il «non paper tedesco», che vorrebbero introdurre l’assicurazione europea dei depositi, ma come condizione richiedono l’attribuzione di un coefficiente di rischio ai titoli pubblici ai fini della Vigilanza.
Qui Gualtieri giustamente dissente. Ma, se si è morbidi nei confronti del Mes in questione e non si agisce per le necessarie modifiche, ci si candida a sorbire l’amaro calice anche di una proposta non adeguata di assicurazione dei depositi, magari sciorinando all’ultimo momento, prima della firma, la solita litania sui danni della non sottoscrizione, senza ricordare che da tempo, secondo i patti, tale assicurazione avrebbe dovuto essere introdotta.
Fonte
Della serie: siamo tutti noi i cretini, gli ignoranti o soltanto sospettosi, oppure è lui che mente buttandola in “coglionarella”?
In alcuni passaggi ha ricordato addirittura la versione italiana di “Alì il comico”, quel generale di Saddam che davanti alle telecamere ridacchiava negando che gli americani stessero avanzando, mentre in pratica stavano per apparire alle sue spalle...
Ricordiamo che su questi “pericoli” si erano espressi nella scorse settimane personaggi “tecnicamente” ben più influenti di noi, dal governatore della Banca d’Italia (Ignazio Visco), a ex senatori Pd ora in Confindustria (Giampaolo Galli), il presidente del Centro Europa Ricerche (Vladimiro Giacchè) e una massa di economisti di ogni livello che in genere plaudono a tutte le scelte dell’Unione Europea.
Last but not least, persino un veterano del neoliberismo più cieco come Francesco Giavazzi, ha speso un editoriale sul Corriere della Sera per dire che “ha ragione chi teme che le proposte di riforma del Fondo comportino dei rischi per l’Italia”. Salvo poi arrendersi subito, perché “sul Fondo salva-Stati ormai è tardi. Fra l’altro il precedente governo le aveva approvate prima dell’estate. Ora, contraddicendoci, potremmo solo opporre il nostro veto”.
Ma la vera fucilata contro la “comicità” del ministro Gualtieri è arrivata ieri mattina con un fondo a firma di Angelo De Mattia, che come economista esperto di finanza sicuramente “pesa” qualcosa più dell’ex tecnoburocrate europeo chiamato a fare il ministro. In fondo De Mattia può vantare una lunga carriera da dirigente in Banca d’Italia e ancora oggi guida l’ufficio studi della Fondazione Generali; mentre il ministro ha avuto una formazione da storico.
Il punto critico è colto con assoluta precisione. Passare – come Gualtieri ha ammesso – da requisiti impliciti a requisiti espliciti per la valutazione sulla sostenibilità del debito pubblico di un paese significa fornire un quadro certo non solo per la fornitura di prestiti, ma anche per l’iniziativa di qualsiasi speculatore sul mercato.
Se si è insomma certi che in determinate condizioni quantitativamente fissate uno Stato sarà costretto a ristrutturare il proprio debito (ossia a svalutare drasticamente i titoli di stato emessi e posseduti dalle banche, quasi sempre italiane), quella possibilità oggi solo ipotetica (l’Italia o altri paesi vicini al default) potrà diventare concreta con molta più facilità.
In secondo luogo, se è vero che il passaggio sulla “ristrutturazione del debito” non compare più nel testo dell’accordo già sottoscritto a giugno (con la Lega al governo!), altrettanto non si può dire sui working documents che stanno venendo fuori in questi giorni. Il Messaggero, per esempio, cita diffusamente un “allegato nascosto” – tra quelli che lo stesso Gualtieri ha definito “un lavoro sugli aspetti esterni” al trattato – che invece dovrebbe preoccupare anche il ministro. Vedi qui.
Tanto più che le decisioni del Mes non vengono prese all’unanimità (come nella Commissione Europea), ma a maggioranza, secondo le quote versate dai singoli paesi per il Fondo stesso. E lì, con Germania e Francia che da sole “pesano” per il 47% (rispettivamente 27 e 20), ci vuole un attimo a fare la maggioranza che ti stronca.
In effetti, a ben vedere, la sagoma di “Alì il comico” svolazza davvero anche sul palcoscenico italiano...
*****
Quei tanti dubbi che ancora restano sul Meccanismo
Angelo De Mattia – Milano Finanza
Nell’audizione tenuta ieri in Senato, il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, ha esordito affermando di avere ascoltato con stupore e con divertimento le tesi infondate sostenute dai critici della bozza dell’accordo intergovernativo sul Meccanismo europeo di stabilita.
Ha abbondato nelle aggettivazioni e nel sarcasmo, definendo comica l’affermazione secondo la quale la riforma del Fondo salva-Stati sarebbe una «terribile innovazione».
Ma basta seguire gli sviluppi del suo ragionamento perché si constati il calo dell’asserita comicità.
Gualtieri afferma che la revisione ha mirato a prevedere per il Mes una funzione di backstop del Fondo di risoluzione delle banche finanziato dai contributi delle stesse banche. Su questo punto, per la verità, nessuno ha mosso obiezioni, se non quelle, più generali, che riguardano l’adeguatezza di tale fondo, a prescindere dal «paracadute», e il fatto che esso è il secondo pilastro dell’Unione bancaria, mentre resta inedificato il terzo, assai importante, pilastro che è quello dell’assicurazione europea dei depositi.
Quanto ai criteri di ammissibilità alle linee di credito del Mes, il ministro osserva che si è trattato di esplicitare indicatori, in precedenza impliciti, della situazione fiscale e degli squilibri macroeconomici, nonché altri criteri concernenti la sostenibilità dei bilanci.
Il passaggio da requisiti impliciti a requisiti espliciti, il cui controllo spetterà alla Commissione Ue e al Mes, è acqua fresca? Che, poi, questi requisiti, quantitativi e qualitativi, siano indicati in un allegato all’accordo intergovemativo che può essere modificato, ha detto Gualtieri, con maggiore facilità rispetto al testo dell’accordo, non suggerisce di proporre sin d’ora modifiche, anziché indugiare in una ironia a buon mercato?
Poi Gualtieri ha aggiunto che i criteri quantitativi, riportati in un allegato all’accordo, vanno rispettati solo «in linea di principio» e, dunque, sono sottoposti a un regime di discrezionalità.
Insomma, si deve far leva, ove mai fosse necessario accedere ai finanziamenti, sulla buona disponibilità dei partner europei perché si impieghi la discrezionalità in senso favorevole? Siamo anche qui all’apoteosi della flessibilità?
È indubbio, poi, che con la modifica del tipo di voto che le riguarda, le clausole di azione collettiva vengano rafforzate. Ma il punctum dolens resta: con esplicitazioni e rafforzamenti di specifiche previsioni, il giudizio sulla sostenibilità del debito diventa più duro e le conseguenze che se ne traggono sul debitonon sono per nulla irrilevanti.
Di fatto, anche a prescindere dalla terminologia adottata, vi sarà, nei casi di non sostenibilità, l’obbligo di una ristrutturazione del debito che sarà la condizione per ottenere i prestiti. A questa parteciperanno anche i privati portatori dei titoli.
È indubbio, poi, che il rango del nuovo Fondo, per le maggiori attribuzioni, salga di livello nei confronti della Commissione. Non interessa sapere, ora, di quanto il Mes si discosti dalla precedente versione, anche perché, se si innova e lo si vuole fare seriamente, non si devono trovare le giustificazioni in ciò che è già vigente e costituisce una stortura.
Sarebbe singolare avere la pretesa di dividere ciò che, secondo un assai superficiale giudizio, tutto sommato si potrebbe accettare ed è quel che ora viene inserito ex novo nell’accordo, da ciò che non va bene, ma è già presente nell’intesa e, dunque, non si potrebbe modificare, chissà perché, autolimitandosi a priori.
La sostanza del Mes non è ridimensionata seriamente dal ministro, che su di un solo punto ha ragione, quando solleva il problema dei progetti, in primis il «non paper tedesco», che vorrebbero introdurre l’assicurazione europea dei depositi, ma come condizione richiedono l’attribuzione di un coefficiente di rischio ai titoli pubblici ai fini della Vigilanza.
Qui Gualtieri giustamente dissente. Ma, se si è morbidi nei confronti del Mes in questione e non si agisce per le necessarie modifiche, ci si candida a sorbire l’amaro calice anche di una proposta non adeguata di assicurazione dei depositi, magari sciorinando all’ultimo momento, prima della firma, la solita litania sui danni della non sottoscrizione, senza ricordare che da tempo, secondo i patti, tale assicurazione avrebbe dovuto essere introdotta.
Fonte
USA - Trump contro i militari
Un nuovo fronte di scontro sta alimentando le polemiche in questi giorni tra il presidente americano Trump e l’apparato di potere negli Stati Uniti. Oltre al conflitto in atto sulla questione dell’impeachment, riflesso delle divergenze attorno ai punti cardine della politica estera USA, e sul ruolo della prima potenza del pianeta in Medio Oriente, a cominciare dalla Siria, continuano a esserci scintille circa i recenti provvedimenti di grazia decisi dal presidente a beneficio di alcuni militari condannati per crimini di guerra.
Il caso che sta facendo più rumore riguarda il “Navy SEAL” o membro delle forze speciali della Marina, Eddie Gallagher. Quest’ultimo era accusato di avere sparato senza motivo su civili a Mosul, in Iraq, e dell’omicidio con un coltello da caccia di un giovane combattente dello Stato Islamico (ISIS) mentre era sotto custodia dei servizi medici militari americani. Gallagher avrebbe anche minacciato di morte alcuni soldati suoi compagni che intendevano testimoniare contro di lui. La corte marziale si era conclusa con l’assoluzione per l’omicidio, ma con una condanna per avere scattato un “selfie” vicino al cadavere del giovane militante, reato anch’esso considerato un crimine di guerra. La Marina americana lo aveva allora immediatamente degradato.
Gli interventi di Trump a favore di Gallagher erano iniziati già nel mese di marzo, con un ordine di rilascio dal carcere militare di San Diego in cui attendeva il processo, mentre la scorsa settimana era arrivata la decisione di annullare gli altri provvedimenti contro il “Navy SEAL” decisi dai vertici della Marina. Nonostante il perdono di Trump, i superiori di Gallagher avevano avviato una procedura di “revisione”, ugualmente bloccata dalla Casa Bianca, che avrebbe potuto privarlo dell’insegna dei corpi speciali dopo il congedo.
I provvedimenti presi da Trump avevano in precedenza riguardato anche altri due militari americani: il maggiore Mathew Golsteyn, responsabile dell’esecuzione sommaria di un membro dei talebani in Afghanistan, e il tenente Clint Lorance, condannato per avere ordinato ai soldati sotto il suo comando, sempre nel paese asiatico occupato, di sparare su tre uomini disarmati, uccidendone due. Gli interventi di Trump sono stati quasi sempre accompagnati dagli immancabili “tweet” che, nei casi in questione, hanno in sostanza espresso l’intenzione di garantire la completa impunità dei soldati americani nell’esecuzione delle operazioni dell’imperialismo a stelle e strisce.
Al centro della vicenda c’è dunque il clamoroso disaccordo tra il presidente e i vertici delle forze armate degli Stati Uniti. Il culmine dello scontro si è registrato finora nel fine settimana con il licenziamento del segretario della Marina militare, Richard Spencer, su richiesta del numero uno del Pentagono, Mark Esper. Ufficialmente, alla base della rimozione di Spencer ci sarebbe la mancata notifica da parte di quest’ultimo a Esper di un accordo che avrebbe proposto alla Casa Bianca sul caso del “SEAL” Eddie Gallagher.
Per il segretario alla Difesa, Spencer avrebbe proposto a Trump una soluzione che consentiva a Gallagher di essere congedato senza disonore, restando cioè un “SEAL” anche dopo avere lasciato i reparti speciali della Marina. Così facendo, Spencer avrebbe assunto una posizione diversa da quella ostentata pubblicamente, oltre ad avere tenuto all’oscuro della proposta di accordo il suo superiore civile.
Che questa ricostruzione corrisponda al vero sembra piuttosto improbabile, anche perché il segretario alla Marina uscente non ne ha fatto parola nella dichiarazione ufficiale in cui ha confermato le sue dimissioni. Spencer, invece, ha tenuto a evidenziare sia la totale diversità di vedute con il presidente sui “principi fondamentali di ordine e disciplina” sia la pericolosità, se non, velatamente, l’illegalità, del comportamento dello stesso Trump.
Il segretario uscente ha affermato che la sua “coscienza” non gli consente di “obbedire a un ordine” che, a suo dire, “viola il sacro giuramento... di rispettare e difendere la Costituzione degli Stati Uniti”. L’accusa indiretta al presidente americano di avere agito in violazione della Costituzione rappresenta un attacco gravissimo da parte di uno dei massimi esponenti dei vertici militari contro il più alto ufficio civile del paese, a cui i primi dovrebbero evidentemente sottostare.
Da questo punto di vista, la vicenda rappresenta l’ennesima conferma di come il principio del controllo civile sull’apparato militare negli USA sia ormai estremamente logoro sotto la spinta di ripetute avventure belliche negli ultimi due decenni, svincolate dal controllo e dall’approvazione dell’autorità civile. L’altro aspetto di rilievo, come accennato all’inizio, è l’aggravarsi dei segnali di conflitto tra l’amministrazione Trump e determinate fazioni dei poteri forti, in questo caso quella rappresentata dai militari.
Lo scontro attorno alla sorte dei “Navy SEAL” responsabili di crimini di guerra è esploso a causa del tentativo, da parte della Casa Bianca e degli alti ufficiali delle forze armate americane, di utilizzare il caso per ragioni differenti. La concessione della grazia è un altro modo per Trump di stimolare gli istinti retrogradi della sua base ultra-reazionaria nel paese e all’interno della classe dirigente, inclusi gli stessi ambienti militari, in vista delle presidenziali del 2020 e in risposta al procedimento di impeachment in atto al Congresso.
La strumentalizzazione politica del caso Gallagher è confermata anche dagli intrecci tra lo stesso membro delle forze speciali, nonché criminale di guerra condannato, e alcuni ambienti legali e dei media di estrema destra vicini allo stesso presidente. La decisione di Trump sarebbe stata consigliata da un ex ufficiale dell’esercito che conduce un programma per il network FoxNews e condivide l’avvocato di Gallagher. Un secondo legale di quest’ultimo lavora inoltre per la “Trump Organization” e un altro ancora è stato uno stretto collaboratore di Rudy Giuliani, ex sindaco di New York e attualmente avvocato personale del presidente.
Dal punto di vista dei militari, l’apparente durezza mostrata nei confronti dei soldati incriminati e condannati serve invece a mostrare un’intransigenza che torna utile a vendere all’opinione pubblica un’immagine di forze armate che garantiscono disciplina e procedure “democratiche”. Questa illusione, messa in pericolo da Trump, è necessaria per giustificare aggressioni militari, operazioni su scala sempre più vasta in ogni angolo nel pianeta e, in definitiva, crimini di guerra di gran lunga più gravi di quelli commessi individualmente dai singoli soldati americani.
Fonte
Il caso che sta facendo più rumore riguarda il “Navy SEAL” o membro delle forze speciali della Marina, Eddie Gallagher. Quest’ultimo era accusato di avere sparato senza motivo su civili a Mosul, in Iraq, e dell’omicidio con un coltello da caccia di un giovane combattente dello Stato Islamico (ISIS) mentre era sotto custodia dei servizi medici militari americani. Gallagher avrebbe anche minacciato di morte alcuni soldati suoi compagni che intendevano testimoniare contro di lui. La corte marziale si era conclusa con l’assoluzione per l’omicidio, ma con una condanna per avere scattato un “selfie” vicino al cadavere del giovane militante, reato anch’esso considerato un crimine di guerra. La Marina americana lo aveva allora immediatamente degradato.
Gli interventi di Trump a favore di Gallagher erano iniziati già nel mese di marzo, con un ordine di rilascio dal carcere militare di San Diego in cui attendeva il processo, mentre la scorsa settimana era arrivata la decisione di annullare gli altri provvedimenti contro il “Navy SEAL” decisi dai vertici della Marina. Nonostante il perdono di Trump, i superiori di Gallagher avevano avviato una procedura di “revisione”, ugualmente bloccata dalla Casa Bianca, che avrebbe potuto privarlo dell’insegna dei corpi speciali dopo il congedo.
I provvedimenti presi da Trump avevano in precedenza riguardato anche altri due militari americani: il maggiore Mathew Golsteyn, responsabile dell’esecuzione sommaria di un membro dei talebani in Afghanistan, e il tenente Clint Lorance, condannato per avere ordinato ai soldati sotto il suo comando, sempre nel paese asiatico occupato, di sparare su tre uomini disarmati, uccidendone due. Gli interventi di Trump sono stati quasi sempre accompagnati dagli immancabili “tweet” che, nei casi in questione, hanno in sostanza espresso l’intenzione di garantire la completa impunità dei soldati americani nell’esecuzione delle operazioni dell’imperialismo a stelle e strisce.
Al centro della vicenda c’è dunque il clamoroso disaccordo tra il presidente e i vertici delle forze armate degli Stati Uniti. Il culmine dello scontro si è registrato finora nel fine settimana con il licenziamento del segretario della Marina militare, Richard Spencer, su richiesta del numero uno del Pentagono, Mark Esper. Ufficialmente, alla base della rimozione di Spencer ci sarebbe la mancata notifica da parte di quest’ultimo a Esper di un accordo che avrebbe proposto alla Casa Bianca sul caso del “SEAL” Eddie Gallagher.
Per il segretario alla Difesa, Spencer avrebbe proposto a Trump una soluzione che consentiva a Gallagher di essere congedato senza disonore, restando cioè un “SEAL” anche dopo avere lasciato i reparti speciali della Marina. Così facendo, Spencer avrebbe assunto una posizione diversa da quella ostentata pubblicamente, oltre ad avere tenuto all’oscuro della proposta di accordo il suo superiore civile.
Che questa ricostruzione corrisponda al vero sembra piuttosto improbabile, anche perché il segretario alla Marina uscente non ne ha fatto parola nella dichiarazione ufficiale in cui ha confermato le sue dimissioni. Spencer, invece, ha tenuto a evidenziare sia la totale diversità di vedute con il presidente sui “principi fondamentali di ordine e disciplina” sia la pericolosità, se non, velatamente, l’illegalità, del comportamento dello stesso Trump.
Il segretario uscente ha affermato che la sua “coscienza” non gli consente di “obbedire a un ordine” che, a suo dire, “viola il sacro giuramento... di rispettare e difendere la Costituzione degli Stati Uniti”. L’accusa indiretta al presidente americano di avere agito in violazione della Costituzione rappresenta un attacco gravissimo da parte di uno dei massimi esponenti dei vertici militari contro il più alto ufficio civile del paese, a cui i primi dovrebbero evidentemente sottostare.
Da questo punto di vista, la vicenda rappresenta l’ennesima conferma di come il principio del controllo civile sull’apparato militare negli USA sia ormai estremamente logoro sotto la spinta di ripetute avventure belliche negli ultimi due decenni, svincolate dal controllo e dall’approvazione dell’autorità civile. L’altro aspetto di rilievo, come accennato all’inizio, è l’aggravarsi dei segnali di conflitto tra l’amministrazione Trump e determinate fazioni dei poteri forti, in questo caso quella rappresentata dai militari.
Lo scontro attorno alla sorte dei “Navy SEAL” responsabili di crimini di guerra è esploso a causa del tentativo, da parte della Casa Bianca e degli alti ufficiali delle forze armate americane, di utilizzare il caso per ragioni differenti. La concessione della grazia è un altro modo per Trump di stimolare gli istinti retrogradi della sua base ultra-reazionaria nel paese e all’interno della classe dirigente, inclusi gli stessi ambienti militari, in vista delle presidenziali del 2020 e in risposta al procedimento di impeachment in atto al Congresso.
La strumentalizzazione politica del caso Gallagher è confermata anche dagli intrecci tra lo stesso membro delle forze speciali, nonché criminale di guerra condannato, e alcuni ambienti legali e dei media di estrema destra vicini allo stesso presidente. La decisione di Trump sarebbe stata consigliata da un ex ufficiale dell’esercito che conduce un programma per il network FoxNews e condivide l’avvocato di Gallagher. Un secondo legale di quest’ultimo lavora inoltre per la “Trump Organization” e un altro ancora è stato uno stretto collaboratore di Rudy Giuliani, ex sindaco di New York e attualmente avvocato personale del presidente.
Dal punto di vista dei militari, l’apparente durezza mostrata nei confronti dei soldati incriminati e condannati serve invece a mostrare un’intransigenza che torna utile a vendere all’opinione pubblica un’immagine di forze armate che garantiscono disciplina e procedure “democratiche”. Questa illusione, messa in pericolo da Trump, è necessaria per giustificare aggressioni militari, operazioni su scala sempre più vasta in ogni angolo nel pianeta e, in definitiva, crimini di guerra di gran lunga più gravi di quelli commessi individualmente dai singoli soldati americani.
Fonte
Libano - hariri si fa da parte
di Michele Giorgio – il Manifesto
Se, come annunciato, il capo dello Stato Michel Aoun comincerà oggi le consultazioni per la nomina del premier incaricato, un po’ tutte le forze politiche dovrebbero indicare il nome di Samir Khatib, un imprenditore a capo del gigante Khatib & Alami Engineering. Khatib è un buon amico del primo ministro sunnita dimissionario Saad Hariri che l’altra sera si è chiamato fuori dalla formazione del nuovo governo.
Khatib si è detto pronto a fare la sua parte. Si dice convinto di poter guidare il paese «bene come fa con la sua impresa». Considerare il Libano solo un’azienda da risanare è miope. Accanto ai conti da mettere in ordine e al contenimento del debito pubblico (86 miliardi di dollari, pari al 150% del Pil) occorre redistribuire la ricchezza, mettere fine ai monopoli e allo strapotere degli istituti di credito e finanziari se si vuole dare una risposta vera ai bisogni delle centinaia di migliaia di libanesi che dal 17 ottobre in poi sono scesi in strada a Beirut e in altre città per chiedere pane e lavoro per tutti, la fine della corruzione, del carovita, degli sprechi, della mancanza di servizi essenziali e del confessionalismo che paralizza l’economia e il sistema politico. Una protesta che all’inizio ha visto insieme cristiani, sunniti e sciiti puntare il dito contro tutti i partiti e i leader politici, dal premier filo-Usa Hariri al segretario generale del movimento sciita Hezbollah, Hassan Nasrallah, alleato dell’Iran. Ma che sta gradualmente perdendo la sua spontaneità per rientrare nei binari del perenne scontro tra le forze schierate con gli Usa, l’Arabia Saudita e l’Occidente e quelle che fanno riferimento a Siria e Iran.
Non sfugge che mentre la maggior parte dei manifestanti, specie i più giovani, continui ad accusare tutti i partiti del disastro libanese, alcuni media locali e quelli globali finanziati da Arabia Saudita e del Golfo appaiono impegnati, con un evidente fine politico, ad attribuire ad Hezbollah e all’altro partito sciita Amal le responsabilità principali. Senza alcun dubbio anche Hezbollah ha colpe importanti. Fra queste l’aver avallato, nel rispetto del sistema settario, le posizioni di potere a più livelli di altre forze politiche, anche avversarie, in modo da conservare e rafforzare le proprie. Ma la sua responsabilità non è superiore a quella degli altri partiti. Non certo più di quella di Hariri e del sistema di controllo politico ed economico messo in piedi dalla sua famiglia. Non più dei libanesi che hanno esportato all’estero diversi miliardi di dollari sottraendo ricchezza al paese. Andrebbe ricordato che le rigide sanzioni finanziarie e bancarie varate dall’Amministrazione Trump contro Hezbollah quest’anno hanno contribuito a far calare le rimesse annuali dei libanesi che lavorano all’estero, da 8,5 ad 3 miliardi di dollari. Fondi vitali che assicurano la sopravvivenza di decine di migliaia di famiglie.
Il clima che si respira è pesante. Se qualche giorno fa si erano registrate aggressioni ai manifestanti che bloccavano la tangenziale di Beirut compiute da attivisti di Hezbollah e Amal, martedì sera a scagliarsi pietre e a prendersi a pugni e a bastonate, a cavallo tra il sobborgo sciita di Chiyah e l’adiacente area cristiana di Ein Rummaneh, sono stati giovani di Hezbollah e delle Forze Libanesi, una formazione di destra non rappresentativa delle ragioni delle proteste popolari. Questi e altri scontri – avvenuti anche a Tripoli – hanno provocato decine di feriti. Un brutto segnale per un paese che ha pagato con 150mila morti una guerra civile durata 15 anni. Ieri le donne dei due sobborghi hanno risposto all’accaduto manifestando insieme contro la violenza.
Fonte
Se, come annunciato, il capo dello Stato Michel Aoun comincerà oggi le consultazioni per la nomina del premier incaricato, un po’ tutte le forze politiche dovrebbero indicare il nome di Samir Khatib, un imprenditore a capo del gigante Khatib & Alami Engineering. Khatib è un buon amico del primo ministro sunnita dimissionario Saad Hariri che l’altra sera si è chiamato fuori dalla formazione del nuovo governo.
Khatib si è detto pronto a fare la sua parte. Si dice convinto di poter guidare il paese «bene come fa con la sua impresa». Considerare il Libano solo un’azienda da risanare è miope. Accanto ai conti da mettere in ordine e al contenimento del debito pubblico (86 miliardi di dollari, pari al 150% del Pil) occorre redistribuire la ricchezza, mettere fine ai monopoli e allo strapotere degli istituti di credito e finanziari se si vuole dare una risposta vera ai bisogni delle centinaia di migliaia di libanesi che dal 17 ottobre in poi sono scesi in strada a Beirut e in altre città per chiedere pane e lavoro per tutti, la fine della corruzione, del carovita, degli sprechi, della mancanza di servizi essenziali e del confessionalismo che paralizza l’economia e il sistema politico. Una protesta che all’inizio ha visto insieme cristiani, sunniti e sciiti puntare il dito contro tutti i partiti e i leader politici, dal premier filo-Usa Hariri al segretario generale del movimento sciita Hezbollah, Hassan Nasrallah, alleato dell’Iran. Ma che sta gradualmente perdendo la sua spontaneità per rientrare nei binari del perenne scontro tra le forze schierate con gli Usa, l’Arabia Saudita e l’Occidente e quelle che fanno riferimento a Siria e Iran.
Non sfugge che mentre la maggior parte dei manifestanti, specie i più giovani, continui ad accusare tutti i partiti del disastro libanese, alcuni media locali e quelli globali finanziati da Arabia Saudita e del Golfo appaiono impegnati, con un evidente fine politico, ad attribuire ad Hezbollah e all’altro partito sciita Amal le responsabilità principali. Senza alcun dubbio anche Hezbollah ha colpe importanti. Fra queste l’aver avallato, nel rispetto del sistema settario, le posizioni di potere a più livelli di altre forze politiche, anche avversarie, in modo da conservare e rafforzare le proprie. Ma la sua responsabilità non è superiore a quella degli altri partiti. Non certo più di quella di Hariri e del sistema di controllo politico ed economico messo in piedi dalla sua famiglia. Non più dei libanesi che hanno esportato all’estero diversi miliardi di dollari sottraendo ricchezza al paese. Andrebbe ricordato che le rigide sanzioni finanziarie e bancarie varate dall’Amministrazione Trump contro Hezbollah quest’anno hanno contribuito a far calare le rimesse annuali dei libanesi che lavorano all’estero, da 8,5 ad 3 miliardi di dollari. Fondi vitali che assicurano la sopravvivenza di decine di migliaia di famiglie.
Il clima che si respira è pesante. Se qualche giorno fa si erano registrate aggressioni ai manifestanti che bloccavano la tangenziale di Beirut compiute da attivisti di Hezbollah e Amal, martedì sera a scagliarsi pietre e a prendersi a pugni e a bastonate, a cavallo tra il sobborgo sciita di Chiyah e l’adiacente area cristiana di Ein Rummaneh, sono stati giovani di Hezbollah e delle Forze Libanesi, una formazione di destra non rappresentativa delle ragioni delle proteste popolari. Questi e altri scontri – avvenuti anche a Tripoli – hanno provocato decine di feriti. Un brutto segnale per un paese che ha pagato con 150mila morti una guerra civile durata 15 anni. Ieri le donne dei due sobborghi hanno risposto all’accaduto manifestando insieme contro la violenza.
Fonte
Iran - Arrestate 8 persone legate alla CIA
Le autorità iraniane hanno arrestato la scorsa settimane almeno 8
persone collegate alla Cia. A dirlo è stata ieri l’agenzia ufficiale
iraniana Irna. “Questi elementi – scrive Irna riportando le parole del
ministro dell’Intelligence iraniano – hanno ricevuto un addestramento
finanziato dalla Cia in vari paesi mentre erano sotto copertura come
giornalisti-cittadini. Sei di loro sono stati arrestati mentre
partecipano ai disordini ed eseguivano gli ordini [della Cia]. Gli altri
due mentre tentavano di mandare informazioni all’estero”.
La notizia degli arresti giungeva qualche ora dopo all'annuncio in cui la Guida Suprema Ali Khamenei descriveva le due settimane di protesta anti-governative come una “cospirazione molto pericolosa”. “Il popolo ha sventato un vasto e profondo complotto su cui sono stati spesi molti soldi per la distruzione, la crudeltà e l’omicidio di persone” ha spiegato la massima figura religiosa del Paese partecipando ad un raduno dei Basij, la forza volontaria della Guardia rivoluzionaria iraniana che sarebbe stata in prima linea nel reprimere le proteste degli scorsi giorni. Una repressione dai contorni ancora poco chiari: il governo non ha infatti ancora presentato numeri ufficiali sui morti e i feriti delle manifestazioni antigovernative scoppiate a metà novembre. L’ong internazionale per i diritti umani Amnesty International ha accusato Teheran di aver ucciso almeno 143 persone, dato che è stato duramente criticato dalle autorità iraniane in quanto privo di prove.
Duro è anche il commento di Human Rights Watch (Hrw) che ha accusato ieri il governo Rouhani di aver “deliberatamente insabbiato” l’entità della repressione. Hrw ha pertanto invitato le autorità a fornire “immediatamente il numero di morti, gli arresti e permettere una inchiesta indipendente sui presunti abusi compiuti”. Michael Page, vice direttore per il Medio Oriente di Human Rights Watch, ha poi spiegato che “tenere le famiglie all’oscuro su quanto accaduto ai loro cari, mantenendo vivo un clima di paura e rappresaglia, è una deliberata strategia da parte del governo per soffocare il dissenso”. Per molti giorni, a partire dal 16 novembre, Teheran ha bloccato Internet limitando le comunicazioni con il mondo esterno nel tentativo così di limitare la diffusione delle proteste. La situazione sembra essere migliorata, sebbene la presenza della rete sui telefoni cellulari resti ancora difficile.
Proprio alla rete, e per la precisione a Twitter, ieri si era affidato la Guida Suprema per esprimere “la sua sincera gratitudine e apprezzamento” agli iraniani. “Il popolo – ha cinguettato – ha dimostrato di nuovo di essere potente e grande e sconfiggendo con la sua presenza il grande complotto del nemico”. Il tweet puntava il dito precisamente contro “l’arroganza globale e il sionismo” in un chiaro riferimento ai due principali rivali iraniani, gli Stati Uniti d’America e Israele.
Dopo quasi due settimane di silenzio, intanto, ieri è arrivata una prima conferma da parte di Teheran sulla consistenza delle dimostrazioni anti-governative, le più grandi da almeno 10 anni a questa parte (nel 2009 fu il Movimento verde a portare in piazza migliaia di giovani contro l’allora presidente Ahmadinejad). Il ministro degli Interni Abdolreza Rahmani Fazli ha detto infatti che almeno 200.000 persone hanno preso parte alle proteste. Secondo quanto dichiarato da Fazli, i dimostranti hanno danneggiato 50 stazioni di polizia, 34 ambulanze, 731 banche e 70 stazioni di benzina. Citato dall’agenzia Iran, il ministro ha detto che “abbiamo individui uccisi da coltelli colpi di pistola e incendi”.
E mentre la situazione resta tesa nella Repubblica islamica a causa della difficile condizione economica resa insostenibile dal recente aumento dei prezzi del carburante – su cui pesano fortemente le sanzioni e i blocchi statunitensi decisi dall’Amministrazione Usa di Donald Trump dopo il ritiro dall’accordo sul nucleare iraniano – continuano le manifestazioni contro il governo in Iraq. Proteste che spesso hanno avuto palesi tratti anti-iraniani. L’ultimo caso evidente ieri quando un gruppo di dimostranti ha assaltato il consolato iraniano nella città di Najaf (non si sono registrate vittime). L’attacco ha mandato su tutte le furie Teheran che, tramite il portavoce del ministero degli esteri Abbas Moussavi, ha chiesto a Baghdad “una risposta ferma contro gli aggressori”.
Le autorità irachene, responsabili finora dell’uccisione di oltre 320 dimostranti, hanno subito decretato il coprifuoco nell’area. Molti manifestanti iracheni accusano le forze straniere – soprattutto l’Iran – del baratro economico e sociale in cui versa il loro Paese.
Fonte
La notizia degli arresti giungeva qualche ora dopo all'annuncio in cui la Guida Suprema Ali Khamenei descriveva le due settimane di protesta anti-governative come una “cospirazione molto pericolosa”. “Il popolo ha sventato un vasto e profondo complotto su cui sono stati spesi molti soldi per la distruzione, la crudeltà e l’omicidio di persone” ha spiegato la massima figura religiosa del Paese partecipando ad un raduno dei Basij, la forza volontaria della Guardia rivoluzionaria iraniana che sarebbe stata in prima linea nel reprimere le proteste degli scorsi giorni. Una repressione dai contorni ancora poco chiari: il governo non ha infatti ancora presentato numeri ufficiali sui morti e i feriti delle manifestazioni antigovernative scoppiate a metà novembre. L’ong internazionale per i diritti umani Amnesty International ha accusato Teheran di aver ucciso almeno 143 persone, dato che è stato duramente criticato dalle autorità iraniane in quanto privo di prove.
Duro è anche il commento di Human Rights Watch (Hrw) che ha accusato ieri il governo Rouhani di aver “deliberatamente insabbiato” l’entità della repressione. Hrw ha pertanto invitato le autorità a fornire “immediatamente il numero di morti, gli arresti e permettere una inchiesta indipendente sui presunti abusi compiuti”. Michael Page, vice direttore per il Medio Oriente di Human Rights Watch, ha poi spiegato che “tenere le famiglie all’oscuro su quanto accaduto ai loro cari, mantenendo vivo un clima di paura e rappresaglia, è una deliberata strategia da parte del governo per soffocare il dissenso”. Per molti giorni, a partire dal 16 novembre, Teheran ha bloccato Internet limitando le comunicazioni con il mondo esterno nel tentativo così di limitare la diffusione delle proteste. La situazione sembra essere migliorata, sebbene la presenza della rete sui telefoni cellulari resti ancora difficile.
Proprio alla rete, e per la precisione a Twitter, ieri si era affidato la Guida Suprema per esprimere “la sua sincera gratitudine e apprezzamento” agli iraniani. “Il popolo – ha cinguettato – ha dimostrato di nuovo di essere potente e grande e sconfiggendo con la sua presenza il grande complotto del nemico”. Il tweet puntava il dito precisamente contro “l’arroganza globale e il sionismo” in un chiaro riferimento ai due principali rivali iraniani, gli Stati Uniti d’America e Israele.
Dopo quasi due settimane di silenzio, intanto, ieri è arrivata una prima conferma da parte di Teheran sulla consistenza delle dimostrazioni anti-governative, le più grandi da almeno 10 anni a questa parte (nel 2009 fu il Movimento verde a portare in piazza migliaia di giovani contro l’allora presidente Ahmadinejad). Il ministro degli Interni Abdolreza Rahmani Fazli ha detto infatti che almeno 200.000 persone hanno preso parte alle proteste. Secondo quanto dichiarato da Fazli, i dimostranti hanno danneggiato 50 stazioni di polizia, 34 ambulanze, 731 banche e 70 stazioni di benzina. Citato dall’agenzia Iran, il ministro ha detto che “abbiamo individui uccisi da coltelli colpi di pistola e incendi”.
E mentre la situazione resta tesa nella Repubblica islamica a causa della difficile condizione economica resa insostenibile dal recente aumento dei prezzi del carburante – su cui pesano fortemente le sanzioni e i blocchi statunitensi decisi dall’Amministrazione Usa di Donald Trump dopo il ritiro dall’accordo sul nucleare iraniano – continuano le manifestazioni contro il governo in Iraq. Proteste che spesso hanno avuto palesi tratti anti-iraniani. L’ultimo caso evidente ieri quando un gruppo di dimostranti ha assaltato il consolato iraniano nella città di Najaf (non si sono registrate vittime). L’attacco ha mandato su tutte le furie Teheran che, tramite il portavoce del ministero degli esteri Abbas Moussavi, ha chiesto a Baghdad “una risposta ferma contro gli aggressori”.
Le autorità irachene, responsabili finora dell’uccisione di oltre 320 dimostranti, hanno subito decretato il coprifuoco nell’area. Molti manifestanti iracheni accusano le forze straniere – soprattutto l’Iran – del baratro economico e sociale in cui versa il loro Paese.
Fonte
Brancaccio - I guasti delle "soluzioni di mercato"
RAI Radio Uno, 26 novembre 2019 – Nelle crisi di Alitalia, di ILVA e di
altri settori chiave dell’economia, da oltre un ventennio i governi
italiani di ogni colore politico privilegiano le cosiddette “soluzioni
di mercato”, basate sulla individuazione di acquirenti privati disposti a
gestirle. Ciò nonostante le crisi non si risolvono e lo Stato, pur non
essendo proprietario, continua a rimetterci. Una soluzione alternativa
potrebbe allora consistere nella partecipazione pubblica diretta nella
compagine azionaria delle aziende strategiche in crisi. L’intervento
statale, tra l’altro, consentirebbe di partecipare ai processi mondiali
di concentrazione industriale e alle connesse decisioni di liquidazione,
acquisizione e ristrutturazione con un maggior peso politico-economico,
come del resto altri paesi già fanno. Intervista a Emiliano Brancaccio
(Università del Sannio).
Fonte
Fonte
28/11/2019
Europa e retorica europeista
di Marco Veronese Passarella
Ci riflettevo oggi. Il mio dissenso con la maggioranza degli economisti critici italiani non riguarda, in realtà, la specifica risposta alla questione “Uscita sì? Uscita no?” da Unione Europea e sottoinsiemi. Io stesso non ho una posizione così netta su questo punto, essendo l’uscita semmai una conseguenza (dagli esiti incerti) e non la causa di politiche economiche radicali.
Il mio dissenso è invece legato ad una triplice riduzione o identificazione che gli unionisti fanno e che io trovo invece infondata e fuorviante: quella tra Area Euro e Unione Europea, quella tra Unione Europea ed Europa, e infine quella tra Europa e Bene Assoluto.
Non mi soffermo sulla prima, perché sapete tutti a cosa mi riferisco. Passo dunque alla seconda identificazione, Unione Europea=Europa, che non è solo un’inesattezza sul piano storico, geografico e politico.
Il richiamo emotivo all’Europa (sia esso giocato in positivo, “l’unione dei popoli europei come reazione all’orrore delle guerre mondiali”, ovvero in negativo, “la riproposizione con altri mezzi del Terzo Reich”) impedisce di guardare all’Unione Europea per quello che è: un’area di libera circolazione di merci e capitali dotata di un coordinamento macroeconomico deflazionista – sigillato dall’obbligo di adozione della valuta unica, che vale ad impedire qualsivoglia riallineamento dei tassi di cambio reali attraverso un aggiustamento dei cambi nominali.
Evito, invece, di entrare qui nel merito del rapporto di gemellanza siamese, e sia pure non priva di contraddizioni, tra Unione Europea e dispositivo di difesa atlantico in chiave anti-russa.
Nota a margine per gli amanti del “ce lo impone la globalizzazione”. Non vi è alcuna evidenza empirica che la maggior dimensione geografica si associ a migliori condizioni di vita e di lavoro, o a migliori risposte tecnologiche alle tanto strombazzate sfide globali, essendo i primi paesi in Europa per reddito pro-capite, uguaglianza e innovazioni tutte piccole economie che hanno aderito a condizioni speciali o non aderito affatto all’Unione Europea (Danimarca, Svezia e Norvegia).
D’altra parte, un Green New Deal su scala continentale, o anche solo nazionale, è in questo momento impedito, non incentivato, dalle regole comunitarie. Le quali non sono state fatte per incentivare la collaborazione tra paesi, ma per favorire la centralizzazione-concentrazione di capitali e tecnologie lungo l’asse franco-tedesco.
Ecco perché faremmo meglio a relegare il feticismo della dimensione ad altri e più gratificanti (si spera) ambiti della nostra vita associata.
Venendo alla terza identificazione, Europa=Bene Assoluto, non ho da obiettare se per qualcuno Europa significa, che so, i capolavori della musica classica, l’illuminismo e, perché no, la fondazione della Prima Internazionale. Va da sé che Europa significa anche questo.
Ma “anche questo” non vuol dire “solo questo”. Europa significa altresì deportazione di schiavi, colonialismo e campi di concentramento. Significa bombardamenti su Belgrado, appoggio ai nazisti ucraini contro il nemico r(u)sso e finanziamenti a bande criminali in Turchia e Libia per bloccare i flussi migratori.
Insomma, anche a voler accettare le prime due riduzioni, non vi è alcunché di intrinsecamente positivo (o negativo) nell’essere europei. Così come non vi è nulla di intrinsecamente positivo (o negativo) nell’essere italiani, catalani o tedeschi. A meno di non rispolverare vecchie suggestioni che faremmo bene a lasciare nel dimenticatoio della storia.
Ecco perché se non possiamo non dirci europei, possiamo ed anzi dobbiamo rifuggire ogni retorica europeista. Ma su questo, a quanto pare, sono in pochi a pensarla come me.
Fonte
Ci riflettevo oggi. Il mio dissenso con la maggioranza degli economisti critici italiani non riguarda, in realtà, la specifica risposta alla questione “Uscita sì? Uscita no?” da Unione Europea e sottoinsiemi. Io stesso non ho una posizione così netta su questo punto, essendo l’uscita semmai una conseguenza (dagli esiti incerti) e non la causa di politiche economiche radicali.
Il mio dissenso è invece legato ad una triplice riduzione o identificazione che gli unionisti fanno e che io trovo invece infondata e fuorviante: quella tra Area Euro e Unione Europea, quella tra Unione Europea ed Europa, e infine quella tra Europa e Bene Assoluto.
Non mi soffermo sulla prima, perché sapete tutti a cosa mi riferisco. Passo dunque alla seconda identificazione, Unione Europea=Europa, che non è solo un’inesattezza sul piano storico, geografico e politico.
Il richiamo emotivo all’Europa (sia esso giocato in positivo, “l’unione dei popoli europei come reazione all’orrore delle guerre mondiali”, ovvero in negativo, “la riproposizione con altri mezzi del Terzo Reich”) impedisce di guardare all’Unione Europea per quello che è: un’area di libera circolazione di merci e capitali dotata di un coordinamento macroeconomico deflazionista – sigillato dall’obbligo di adozione della valuta unica, che vale ad impedire qualsivoglia riallineamento dei tassi di cambio reali attraverso un aggiustamento dei cambi nominali.
Evito, invece, di entrare qui nel merito del rapporto di gemellanza siamese, e sia pure non priva di contraddizioni, tra Unione Europea e dispositivo di difesa atlantico in chiave anti-russa.
Nota a margine per gli amanti del “ce lo impone la globalizzazione”. Non vi è alcuna evidenza empirica che la maggior dimensione geografica si associ a migliori condizioni di vita e di lavoro, o a migliori risposte tecnologiche alle tanto strombazzate sfide globali, essendo i primi paesi in Europa per reddito pro-capite, uguaglianza e innovazioni tutte piccole economie che hanno aderito a condizioni speciali o non aderito affatto all’Unione Europea (Danimarca, Svezia e Norvegia).
D’altra parte, un Green New Deal su scala continentale, o anche solo nazionale, è in questo momento impedito, non incentivato, dalle regole comunitarie. Le quali non sono state fatte per incentivare la collaborazione tra paesi, ma per favorire la centralizzazione-concentrazione di capitali e tecnologie lungo l’asse franco-tedesco.
Ecco perché faremmo meglio a relegare il feticismo della dimensione ad altri e più gratificanti (si spera) ambiti della nostra vita associata.
Venendo alla terza identificazione, Europa=Bene Assoluto, non ho da obiettare se per qualcuno Europa significa, che so, i capolavori della musica classica, l’illuminismo e, perché no, la fondazione della Prima Internazionale. Va da sé che Europa significa anche questo.
Ma “anche questo” non vuol dire “solo questo”. Europa significa altresì deportazione di schiavi, colonialismo e campi di concentramento. Significa bombardamenti su Belgrado, appoggio ai nazisti ucraini contro il nemico r(u)sso e finanziamenti a bande criminali in Turchia e Libia per bloccare i flussi migratori.
Insomma, anche a voler accettare le prime due riduzioni, non vi è alcunché di intrinsecamente positivo (o negativo) nell’essere europei. Così come non vi è nulla di intrinsecamente positivo (o negativo) nell’essere italiani, catalani o tedeschi. A meno di non rispolverare vecchie suggestioni che faremmo bene a lasciare nel dimenticatoio della storia.
Ecco perché se non possiamo non dirci europei, possiamo ed anzi dobbiamo rifuggire ogni retorica europeista. Ma su questo, a quanto pare, sono in pochi a pensarla come me.
Fonte
Iscriviti a:
Commenti (Atom)