Presentazione
Analisi, opinioni, fatti e (più di rado) arte da una prospettiva di classe.
30/06/2020
Boeri, Gualtieri, e la dignità a tempo determinato
Se è vero, come sosteneva Thomas Eliot,
che aprile è il mese più crudele, potremmo avere il sospetto, aprendo La
Repubblica di qualche giorno fa, che giugno non sia da meno. Ci
imbatteremmo infatti in un articolo dell’ex presidente INPS, Tito Boeri,
dal titolo piuttosto eloquente: “Per frenare la perdita di posti di lavoro servono più contratti a tempo determinato”.
Il dubbio verrebbe ulteriormente accresciuto se a fare da eco alle
parole di Boeri si unissero il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, il PD e Italia Viva,
oltre che il giornalismo filo-padronale accompagnato dalla
Confindustria e dal centrodestra. A quel punto, i sospetti si
tramuterebbero in certezza e la triste verità verrebbe inesorabilmente a
galla: Thomas Eliot si sbagliava. Ma andiamo con ordine.
Passata la sfuriata della prima lettura, l’articolo di Boeri ci offre alcuni spunti di riflessione su due questioni che lo stesso autore ritiene strettamente legate tra loro in termini di causa-effetto. Da un lato, la perdita dei posti di lavoro a seguito delle misure di contrasto all’epidemia da Covid-19: dato il blocco dei licenziamenti per motivi economici, tale perdita sarebbe imputabile ai mancati rinnovi dei contratti a termine, e potrà essere ancora più marcata una volta che il blocco scadrà. Dall’altro, quelli che per Boeri si configureranno nella fase post lockdown come degli ostacoli alle assunzioni e ai mancati rinnovi dei contratti di lavoro a tempo determinato.
Senza troppi giri di parole, Boeri sostiene che per contenere le ulteriori perdite occupazionali che inevitabilmente si verificheranno una volta rimosso il blocco dei licenziamenti è necessario stimolare i rinnovi dei contratti a tempo determinato. In che modo? Abbattendo la presunta “burocrazia” del Decreto Dignità, la causa principale dello stop alle assunzioni e dei rinnovi in questa ‘fase 2’. Cosa intende, però, Boeri per “burocrazia”?
La risposta ce la fornisce il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, che, da perfetto portavoce degli interessi del mondo imprenditoriale ha affermato come sia evidente che se in questa fase non si eliminano temporaneamente le causali per il rinnovo e la proroga dei contratti a tempo determinato reintrodotte a suo tempo dal Decreto Dignità, si rischia di avere un impatto negativo sull’occupazione. Evidentissimo. E questo perché, ha ribadito Gualtieri, “È evidente che non possiamo semplicemente limitarci a prorogare la cassa integrazione e il blocco dei licenziamenti per tutti, all’infinito, senza un punto di arrivo. Utilizzare questi strumenti è stato giusto”, ma secondo Gualtieri occorre “cominciare ad affrontare le problematiche che [questi strumenti] non sono in grado risolvere”.
L’idea di Gualtieri, che ha ovviamente trovato il placet di tutta l’area PD da sempre avversa al Decreto Dignità, prevede di prolungare la sospensione delle causali per i rinnovi dei contratti a termine contenuta nel Decreto Rilancio dal 30 agosto 2020 a fine dicembre 2020. Ad oggi, infatti, sulla base delle misure contenute nel Decreto Rilancio, fino al 30 agosto 2020 le imprese potranno rinnovare i contratti a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020 anche in assenza delle causali previste dal Decreto Dignità.
Ricapitolando: Gualtieri e Boeri ci raccontano che per combattere la disoccupazione servono più contratti a tempo determinato, ma se non si eliminano quei brutti e sporchi orpelli burocratici (altrimenti denominati causali), le imprese non sono incentivate ad assumere a tempo determinato. Ma cosa saranno mai queste tanto vituperate causali? Si tratta di alcuni pallidi argini introdotti dal Decreto Dignità per contrastare il ricorso ai contratti a tempo determinato: il decreto ha infatti previsto che in assenza di causale la durata dei contratti a tempo determinato non può essere superiore a 12 mesi, e che se il rapporto di lavoro a termine dovesse proseguire per un periodo più lungo (comunque non oltre il limite massimo di 24 mesi), l’impresa è chiamata a motivare, tramite le causali, le ragioni per cui quel contratto di lavoro dovrebbe continuare a prevedere un termine di durata piuttosto che trasformarsi in un contratto a tempo indeterminato.
Il Decreto Dignità indica due categorie di motivazioni che l’impresa può addurre per giustificare una durata di un contratto a termine superiore a 12 mesi:
a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.
Entrambe le casistiche non sembrano rappresentare, specialmente in questa fase post-emergenza caratterizzata da dilagante incertezza e nessun particolare incremento di produzione, un insormontabile ostacolo alle scelte delle imprese. Piuttosto, l’accanimento contro queste causali sembra essere motivato da una sostanziale presa di posizione del mondo padronale sulle regole del gioco. Se, da un lato, le imprese non perdono l’occasione di approfittare di questa crisi per radere al suolo quel poco che resta delle tutele ai contratti a tempo indeterminato, dall’altro Boeri, Gualtieri e il centrosinistra all’unisono da ormai trent’anni hanno sposato l’idea per cui la disoccupazione si combatte flessibilizzando il mercato del lavoro, ossia incentivando i contratti a termine. Oltre a non essere supportati da alcuna evidenza empirica, tali orientamenti si scontrano con il fatto che la disoccupazione e la perdita dei posti di lavoro, così come, all’opposto, la quantità di lavoratori impiegati, sono determinati dalla domanda aggregata, ossia da quanto le famiglie, le imprese e lo Stato spendono per acquistare beni e servizi. Ciò sta a significare che se il settore privato e/o la pubblica amministrazione non spendono a sufficienza, una porzione della popolazione rimarrà senza lavoro. Oppure, se per qualche ragione (come ad esempio un’epidemia), le famiglie e le imprese decidono di spendere meno di prima, una parte dei lavoratori perderà il posto di lavoro.
Eliminare le causali o facilitare le condizioni per l’assunzione a termine non ha alcun effetto diretto, specialmente in questa fase, sui livelli di occupazione: in altre parole, agire sul mercato del lavoro non consente a chi è disoccupato di trovare un lavoro. La questione della tipologia dei contratti di lavoro è rilevante perché può influenzare la composizione dell’occupazione, ossia la fetta di impiegati con un contratto a termine. Questa composizione, insieme ai livelli di occupazione e disoccupazione, può altresì modificare il potere contrattuale dei lavoratori e, per questa via, i livelli salariali. In sostanza, più lavoratori precari ci sono, meno potere contrattuale questi avranno nei confronti dei datori di lavoro sulla contrattazione dei salari e sulle condizioni di lavoro.
Ecco allora che proposte come quella di Boeri e Gualtieri si configurano come l’ennesimo tentativo di spostare ulteriormente i rapporti di forza tra le classi in una direzione che avvantaggia esclusivamente il padrone. La strategia di qualificare un blando strumento di tutela del lavoro quale il Decreto Dignità come un problema ci dimostra plasticamente come in questa lotta di classe Boeri & C. abbiano deciso di non fare prigionieri: approfittare della crisi per spostare l’asticella ancora più in alto e per cercare di normalizzare l’assenza di causali per contratti a termine ci fa vedere come anche un’emergenza del genere possa rappresentare un’occasione per fare un ulteriore passo verso la precarietà, verso condizioni peggiorative per i lavoratori e più favorevoli per le imprese. Il contratto a tempo determinato è un contratto di lavoro che in quanto tale implica il licenziamento ad una certa data, e la causale è un timido tentativo di far moderare ai padroni l’uso e l’abuso di questi contratti con licenziamento, costringendoli ad esplicitare il motivo del licenziamento previsto alla data di scadenza. Le uscite degli alfieri delle classi dominanti ci dimostrano, qualora ce ne fosse ancora bisogno, come i padroni vogliono sfruttare il pretesto di questa crisi per abbattere qualsiasi timido palliativo a sostegno del lavoro e della buona occupazione.
Fonte
Passata la sfuriata della prima lettura, l’articolo di Boeri ci offre alcuni spunti di riflessione su due questioni che lo stesso autore ritiene strettamente legate tra loro in termini di causa-effetto. Da un lato, la perdita dei posti di lavoro a seguito delle misure di contrasto all’epidemia da Covid-19: dato il blocco dei licenziamenti per motivi economici, tale perdita sarebbe imputabile ai mancati rinnovi dei contratti a termine, e potrà essere ancora più marcata una volta che il blocco scadrà. Dall’altro, quelli che per Boeri si configureranno nella fase post lockdown come degli ostacoli alle assunzioni e ai mancati rinnovi dei contratti di lavoro a tempo determinato.
Senza troppi giri di parole, Boeri sostiene che per contenere le ulteriori perdite occupazionali che inevitabilmente si verificheranno una volta rimosso il blocco dei licenziamenti è necessario stimolare i rinnovi dei contratti a tempo determinato. In che modo? Abbattendo la presunta “burocrazia” del Decreto Dignità, la causa principale dello stop alle assunzioni e dei rinnovi in questa ‘fase 2’. Cosa intende, però, Boeri per “burocrazia”?
La risposta ce la fornisce il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, che, da perfetto portavoce degli interessi del mondo imprenditoriale ha affermato come sia evidente che se in questa fase non si eliminano temporaneamente le causali per il rinnovo e la proroga dei contratti a tempo determinato reintrodotte a suo tempo dal Decreto Dignità, si rischia di avere un impatto negativo sull’occupazione. Evidentissimo. E questo perché, ha ribadito Gualtieri, “È evidente che non possiamo semplicemente limitarci a prorogare la cassa integrazione e il blocco dei licenziamenti per tutti, all’infinito, senza un punto di arrivo. Utilizzare questi strumenti è stato giusto”, ma secondo Gualtieri occorre “cominciare ad affrontare le problematiche che [questi strumenti] non sono in grado risolvere”.
L’idea di Gualtieri, che ha ovviamente trovato il placet di tutta l’area PD da sempre avversa al Decreto Dignità, prevede di prolungare la sospensione delle causali per i rinnovi dei contratti a termine contenuta nel Decreto Rilancio dal 30 agosto 2020 a fine dicembre 2020. Ad oggi, infatti, sulla base delle misure contenute nel Decreto Rilancio, fino al 30 agosto 2020 le imprese potranno rinnovare i contratti a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020 anche in assenza delle causali previste dal Decreto Dignità.
Ricapitolando: Gualtieri e Boeri ci raccontano che per combattere la disoccupazione servono più contratti a tempo determinato, ma se non si eliminano quei brutti e sporchi orpelli burocratici (altrimenti denominati causali), le imprese non sono incentivate ad assumere a tempo determinato. Ma cosa saranno mai queste tanto vituperate causali? Si tratta di alcuni pallidi argini introdotti dal Decreto Dignità per contrastare il ricorso ai contratti a tempo determinato: il decreto ha infatti previsto che in assenza di causale la durata dei contratti a tempo determinato non può essere superiore a 12 mesi, e che se il rapporto di lavoro a termine dovesse proseguire per un periodo più lungo (comunque non oltre il limite massimo di 24 mesi), l’impresa è chiamata a motivare, tramite le causali, le ragioni per cui quel contratto di lavoro dovrebbe continuare a prevedere un termine di durata piuttosto che trasformarsi in un contratto a tempo indeterminato.
Il Decreto Dignità indica due categorie di motivazioni che l’impresa può addurre per giustificare una durata di un contratto a termine superiore a 12 mesi:
a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.
Entrambe le casistiche non sembrano rappresentare, specialmente in questa fase post-emergenza caratterizzata da dilagante incertezza e nessun particolare incremento di produzione, un insormontabile ostacolo alle scelte delle imprese. Piuttosto, l’accanimento contro queste causali sembra essere motivato da una sostanziale presa di posizione del mondo padronale sulle regole del gioco. Se, da un lato, le imprese non perdono l’occasione di approfittare di questa crisi per radere al suolo quel poco che resta delle tutele ai contratti a tempo indeterminato, dall’altro Boeri, Gualtieri e il centrosinistra all’unisono da ormai trent’anni hanno sposato l’idea per cui la disoccupazione si combatte flessibilizzando il mercato del lavoro, ossia incentivando i contratti a termine. Oltre a non essere supportati da alcuna evidenza empirica, tali orientamenti si scontrano con il fatto che la disoccupazione e la perdita dei posti di lavoro, così come, all’opposto, la quantità di lavoratori impiegati, sono determinati dalla domanda aggregata, ossia da quanto le famiglie, le imprese e lo Stato spendono per acquistare beni e servizi. Ciò sta a significare che se il settore privato e/o la pubblica amministrazione non spendono a sufficienza, una porzione della popolazione rimarrà senza lavoro. Oppure, se per qualche ragione (come ad esempio un’epidemia), le famiglie e le imprese decidono di spendere meno di prima, una parte dei lavoratori perderà il posto di lavoro.
Eliminare le causali o facilitare le condizioni per l’assunzione a termine non ha alcun effetto diretto, specialmente in questa fase, sui livelli di occupazione: in altre parole, agire sul mercato del lavoro non consente a chi è disoccupato di trovare un lavoro. La questione della tipologia dei contratti di lavoro è rilevante perché può influenzare la composizione dell’occupazione, ossia la fetta di impiegati con un contratto a termine. Questa composizione, insieme ai livelli di occupazione e disoccupazione, può altresì modificare il potere contrattuale dei lavoratori e, per questa via, i livelli salariali. In sostanza, più lavoratori precari ci sono, meno potere contrattuale questi avranno nei confronti dei datori di lavoro sulla contrattazione dei salari e sulle condizioni di lavoro.
Ecco allora che proposte come quella di Boeri e Gualtieri si configurano come l’ennesimo tentativo di spostare ulteriormente i rapporti di forza tra le classi in una direzione che avvantaggia esclusivamente il padrone. La strategia di qualificare un blando strumento di tutela del lavoro quale il Decreto Dignità come un problema ci dimostra plasticamente come in questa lotta di classe Boeri & C. abbiano deciso di non fare prigionieri: approfittare della crisi per spostare l’asticella ancora più in alto e per cercare di normalizzare l’assenza di causali per contratti a termine ci fa vedere come anche un’emergenza del genere possa rappresentare un’occasione per fare un ulteriore passo verso la precarietà, verso condizioni peggiorative per i lavoratori e più favorevoli per le imprese. Il contratto a tempo determinato è un contratto di lavoro che in quanto tale implica il licenziamento ad una certa data, e la causale è un timido tentativo di far moderare ai padroni l’uso e l’abuso di questi contratti con licenziamento, costringendoli ad esplicitare il motivo del licenziamento previsto alla data di scadenza. Le uscite degli alfieri delle classi dominanti ci dimostrano, qualora ce ne fosse ancora bisogno, come i padroni vogliono sfruttare il pretesto di questa crisi per abbattere qualsiasi timido palliativo a sostegno del lavoro e della buona occupazione.
Fonte
Decreto Semplificazioni, politica ai piedi degli industriali
C’è una sola linea di politica economica, in questa zona del mondo. È folle, distruttiva, devastante e la detta Confindustria. Il cosiddetto centrosinistra e la destra la condividono in pieno, battagliando – chi sguaiatamente, chi meno – semplicemente sul chi debba gestirla e incassare un dividendo.
La prova giunge con il “decreto semplificazioni”, la cui bozza sta circolando in queste ore. L’ha elaborata il governo giallo-rosé, con la partecipazione addirittura della “sinistra” targata Leu, ma avrebbe potuto benissimo presentarla la Lega o Forza Italia (da soli o in consorzio con la Meloni).
Chi ricorda più le proposte di Salvini, sul “zero burocrazia”, “modello Genova” (la ricostruzione del ponte senza gare e in affidamento diretto ad una impresa, la solita Salini Impregilo), “aprire tutti i cantieri”?
Fatto! L’unica limitazione è l’entità degli appalti pubblici. Fino a 150.000 euro sono liberamente firmabili da ogni amministrazione pubblica (vista la cifra, riguarda soprattutto i piccoli Comuni), mentre al di sotto dei 5 milioni di euro si procede lo stesso senza gara ma interpellando almeno cinque imprese diverse.
La destra avrebbe fatto di più, certo, ma parliamo di dettagli. La logica complessiva è identica: “per far ripartire l’economia bisogna permettere alle imprese private di fare quello che vogliono”. In tema di appalti, vincoli ambientali, corruzione, controlli e – va da sé, anche se non c’è ancora scritto – in materia di contratti e condizioni di lavoro.
Controlli zero e “andrà tutto bene”. È la stessa logica sotto cui stanno marcendo per l’epidemia Usa, Brasile, Gran Bretagna, Russia e in genere i fautori dell’ultra-liberismo.
Basta vedere quel che avverrà in termini di “burocrazia” in difesa dell’ambiente. Com’è noto alcune grandi opere infrastrutturali, prima di iniziare realmente, debbono attendere il Via (la “valutazione di impatto ambientale”).
La procedura è sicuramente farraginosa, i tempi sono spesso assai lunghi, anche perché intorno a questa “valutazione” si accalcano spesso esperti di ogni genere, rappresentanti diretti o indiretti (palesi o occulti) delle aziende. Basta vedere quel che è accaduto tra epidemiologi, virologi e persino anestesisti in materia di coronavirus...
Ma c’è modo e modo per sciogliere certe ruggini. Quello scritto nella bozza è certamente uno dei peggiori. Riprendiamo direttamente il commento entusiasta di Italia Oggi:
Non manca neppure un vecchio classico dei tempi democristiani e berlusconiani: il condono edilizio. Per gli “abusi leggeri” sarebbe prevista solo una mini-sanzione.
Un paradiso dell’iniziativa privata, libera come mai prima, senza vincoli né controparti. Era questa in fondo, l’idea di “democrazia negoziale” nella testa del neo presidente di Confindustria, Carlo Bonomi. Con sullo sfondo la gestione delle decine di miliardi che potrebbero arrivare dai fondi europei per la “ricostruzione”, dal Mes, ecc.
Alla “politica”, in questo schema, resta solo il ruolo dell’esecutore, possibilmente ben retribuito...
Fonte
La prova giunge con il “decreto semplificazioni”, la cui bozza sta circolando in queste ore. L’ha elaborata il governo giallo-rosé, con la partecipazione addirittura della “sinistra” targata Leu, ma avrebbe potuto benissimo presentarla la Lega o Forza Italia (da soli o in consorzio con la Meloni).
Chi ricorda più le proposte di Salvini, sul “zero burocrazia”, “modello Genova” (la ricostruzione del ponte senza gare e in affidamento diretto ad una impresa, la solita Salini Impregilo), “aprire tutti i cantieri”?
Fatto! L’unica limitazione è l’entità degli appalti pubblici. Fino a 150.000 euro sono liberamente firmabili da ogni amministrazione pubblica (vista la cifra, riguarda soprattutto i piccoli Comuni), mentre al di sotto dei 5 milioni di euro si procede lo stesso senza gara ma interpellando almeno cinque imprese diverse.
La destra avrebbe fatto di più, certo, ma parliamo di dettagli. La logica complessiva è identica: “per far ripartire l’economia bisogna permettere alle imprese private di fare quello che vogliono”. In tema di appalti, vincoli ambientali, corruzione, controlli e – va da sé, anche se non c’è ancora scritto – in materia di contratti e condizioni di lavoro.
Controlli zero e “andrà tutto bene”. È la stessa logica sotto cui stanno marcendo per l’epidemia Usa, Brasile, Gran Bretagna, Russia e in genere i fautori dell’ultra-liberismo.
Basta vedere quel che avverrà in termini di “burocrazia” in difesa dell’ambiente. Com’è noto alcune grandi opere infrastrutturali, prima di iniziare realmente, debbono attendere il Via (la “valutazione di impatto ambientale”).
La procedura è sicuramente farraginosa, i tempi sono spesso assai lunghi, anche perché intorno a questa “valutazione” si accalcano spesso esperti di ogni genere, rappresentanti diretti o indiretti (palesi o occulti) delle aziende. Basta vedere quel che è accaduto tra epidemiologi, virologi e persino anestesisti in materia di coronavirus...
Ma c’è modo e modo per sciogliere certe ruggini. Quello scritto nella bozza è certamente uno dei peggiori. Riprendiamo direttamente il commento entusiasta di Italia Oggi:
Per conseguire la certezza dei tempi di chiusura del procedimento si propone: previsione dell’obbligo di presentazione sin dall’avvio del procedimento da parte del proponente del progetto di fattibilità o del progetto definitivo (in luogo degli attuali elaborati progettuali); riduzione dei termini attualmente previsti; esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia nella conclusione del procedimento.Ma anche la “digitalizzazione della pubblica amministrazione” è interpretata in maniera singolare, quando si tratta di rapporti con le imprese. Queste infatti potranno “autocertificare via app” la liceità o non pericolosità di quel che vogliono fare, e solo dopo, a babbo morto, ci potrà essere un’attivazione dei controlli da parte degli organi pubblici di controllo (spesso svuotati di personale e senza reali poteri).
Insomma, il titolare del potere sostitutivo deve provvedere all’adozione del provvedimento entro un termine prefissato; è anche prevista la creazione di una procedura speciale accelerata (fast-track) dedicata all’espletamento delle procedure Via delle opere ricomprese nel Programma Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC).
Non manca neppure un vecchio classico dei tempi democristiani e berlusconiani: il condono edilizio. Per gli “abusi leggeri” sarebbe prevista solo una mini-sanzione.
Un paradiso dell’iniziativa privata, libera come mai prima, senza vincoli né controparti. Era questa in fondo, l’idea di “democrazia negoziale” nella testa del neo presidente di Confindustria, Carlo Bonomi. Con sullo sfondo la gestione delle decine di miliardi che potrebbero arrivare dai fondi europei per la “ricostruzione”, dal Mes, ecc.
Alla “politica”, in questo schema, resta solo il ruolo dell’esecutore, possibilmente ben retribuito...
Fonte
Il concerto di Bob Marley non fu solo un concerto
Io c’ero, al concerto di Bob Marley allo Stadio Comunale di Torino, il 28 giugno del 1980. Non per la musica, che non amavo, bensì per l’importanza dell’evento.
Andai davanti ai cancelli dello stadio senza biglietto, ben sapendo che alcuni di loro erano controllati da “compagni” del Movimento, che conoscevo e che mi fecero, insieme ad altre centinaia di persone, entrare gratis.
Mi misi ai lati del prato, all’altezza del centro campo, non troppo distante dal palcoscenico, sotto il quale si era formata una nuvola di polvere dolciastra a causa del numero spropositato di “canne”.
Di quel concerto, ricordo il piacere di stare in mezzo a quella folla variegata di persone: quella diversità mi affascinava e, al contempo, mi turbava. Mi sembrava impossibile che l’euforia che la folla sprigionava fosse depressiva, sterile, incapace di trasformarsi in una grande eresia collettiva.
Lo ricordo davvero: tutto intorno a me stavano, con gli occhi dilatati dalla gioia, migliaia di persone, dei piccoli soli che splendevano senza però bruciare. Mi sembrava di assistere a una funzione mistica, a una sorta di rito collettivo della dimenticanza. Divinità dello sballo.
Stava per essere sferrato il colpo di grazia al grande movimento di trasformazione iniziato nel biennio 1968-69.
Soltanto alcuni mesi prima del concerto di Bob Marley, nell’ottobre del 1979, la Fiat licenziò 69 sindacalisti accusati di violenza e di contiguità con il terrorismo. Le accuse erano false – e tali si rivelarono anche in sede processuale; ma segnarono l’inizio della grande offensiva padronale contro i diritti dei lavoratori.
Nel maggio del 1980 la Fiat annunciò la cassa integrazione per 78mila operai e, nel mese di settembre, il licenziamento di oltre 14mila lavoratori. Iniziò uno sciopero eroico, durato 35 giorni, che culminò con la famigerata “marcia dei quarantamila” (quadri e impiegati che si mobilitarono contro lo sciopero) e con la firma di un accordo favorevole alla Fiat, che infatti fu contestato duramente dalla base.
Ricordo molto bene la manifestazione che si svolse, subito dopo la firma dell’accordo, davanti ai cancelli e che si spostò sino alla palazzina principale di Fiat Mirafiori, quella dei dirigenti. Fu una manifestazione molto dura, ma che portava a spasso, insieme alla rabbia, la certezza di una sconfitta epocale. Mille, forse duemila persone, non di più.
Nessuna nuvola dolciastra, quel giorno; e nessuna euforia. Cominciavano gli Anni 80, quelli “del riflusso”. E cominciava la ristrutturazione della società in chiave liberista.
Il concerto di Bob Marley non fu solo un concerto. Quella folla saltellante non si accorse dello schiaffo che, facendoci cadere malamente, ci consegnò a uno dei periodi più bui della nostra storia – che non a caso culminerà in due eventi anch’essi epocali: l’avvento della televisione commerciale, che contribuirà a degradare immaginario e linguaggio, e la precarizzazione del lavoro.
Cosa importa poi che il concerto sia stato piacevole?
Fonte
Andai davanti ai cancelli dello stadio senza biglietto, ben sapendo che alcuni di loro erano controllati da “compagni” del Movimento, che conoscevo e che mi fecero, insieme ad altre centinaia di persone, entrare gratis.
Mi misi ai lati del prato, all’altezza del centro campo, non troppo distante dal palcoscenico, sotto il quale si era formata una nuvola di polvere dolciastra a causa del numero spropositato di “canne”.
Di quel concerto, ricordo il piacere di stare in mezzo a quella folla variegata di persone: quella diversità mi affascinava e, al contempo, mi turbava. Mi sembrava impossibile che l’euforia che la folla sprigionava fosse depressiva, sterile, incapace di trasformarsi in una grande eresia collettiva.
Lo ricordo davvero: tutto intorno a me stavano, con gli occhi dilatati dalla gioia, migliaia di persone, dei piccoli soli che splendevano senza però bruciare. Mi sembrava di assistere a una funzione mistica, a una sorta di rito collettivo della dimenticanza. Divinità dello sballo.
Stava per essere sferrato il colpo di grazia al grande movimento di trasformazione iniziato nel biennio 1968-69.
Soltanto alcuni mesi prima del concerto di Bob Marley, nell’ottobre del 1979, la Fiat licenziò 69 sindacalisti accusati di violenza e di contiguità con il terrorismo. Le accuse erano false – e tali si rivelarono anche in sede processuale; ma segnarono l’inizio della grande offensiva padronale contro i diritti dei lavoratori.
Nel maggio del 1980 la Fiat annunciò la cassa integrazione per 78mila operai e, nel mese di settembre, il licenziamento di oltre 14mila lavoratori. Iniziò uno sciopero eroico, durato 35 giorni, che culminò con la famigerata “marcia dei quarantamila” (quadri e impiegati che si mobilitarono contro lo sciopero) e con la firma di un accordo favorevole alla Fiat, che infatti fu contestato duramente dalla base.
Ricordo molto bene la manifestazione che si svolse, subito dopo la firma dell’accordo, davanti ai cancelli e che si spostò sino alla palazzina principale di Fiat Mirafiori, quella dei dirigenti. Fu una manifestazione molto dura, ma che portava a spasso, insieme alla rabbia, la certezza di una sconfitta epocale. Mille, forse duemila persone, non di più.
Nessuna nuvola dolciastra, quel giorno; e nessuna euforia. Cominciavano gli Anni 80, quelli “del riflusso”. E cominciava la ristrutturazione della società in chiave liberista.
Il concerto di Bob Marley non fu solo un concerto. Quella folla saltellante non si accorse dello schiaffo che, facendoci cadere malamente, ci consegnò a uno dei periodi più bui della nostra storia – che non a caso culminerà in due eventi anch’essi epocali: l’avvento della televisione commerciale, che contribuirà a degradare immaginario e linguaggio, e la precarizzazione del lavoro.
Cosa importa poi che il concerto sia stato piacevole?
Fonte
Venezuela - Messo alla porta l’ambasciatore dell’Unione Europea
Il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, ha concesso 72 ore al capo della delegazione Ue a Caracas per lasciare il Paese, in risposta alle sanzioni adottate ieri contro 11 funzionari venezuelani. Il capo di Stato venezuelano ha annunciato l’espulsione della rappresentante dell’Unione europea Isabel Brilhante Pedrosa durante un discorso al palazzo presidenziale di Miraflores.
“Chi sono per tentare di imporsi con le minacce? Chi sono? Basta! Questo è il motivo per cui ho deciso di concedere all’ambasciatore dell’Unione europea 72 ore per lasciare il nostro Paese”, ha detto Maduro. “Sistemeremo la questione in 72 ore, le forniremo un aereo per andarsene, ma sistemeremo i nostri affari con l’Unione europea”.
Maduro ha anche affermato che il Venezuela si riserva azioni diplomatiche verso l’ambasciatore di Spagna per la sua partecipazione all’incursione armata di Macuto e per la sua complicità con le azioni criminali denunciate sul Wall Street Journal da Leopoldo Lopez.
Ieri il Consiglio Europeo ha aggiunto 11 alti funzionari venezuelani alla lista delle persone soggette a sanzioni, portando a 36 il numero dei funzionari venezuelani colpiti dalle misure interdittive della Ue.
Le personalità venezuelane sanzionate, si legge in una nota diramata dall’Ue, “sono responsabili per avere agito contro il funzionamento democratico dell’Assemblea Nazionale inclusa la rimozione dell’immunità parlamentare a diversi suoi membri”.
La misura include il divieto di viaggio e il congelamento dei beni. Tra le persone incluse nella lista ci sono Juan Jose Mendoza, presidente del Tribunale supremo di giustizia del Venezuela (Tsj) e Josè Ornelas, capo del Consiglio di difesa nazionale.
Le sanzioni della Ue sono state varate dopo le recenti decisioni del Tsj, di sospendere i vertici di due partiti di opposizione e di nominare i nuovi membri del Consiglio nazionale elettorale (Cne). Lo scorso 16 giugno il Tsj ha ordinato la sospensione dei vertici del partito di opposizione Prima la Giustizia (Primero Justicia, PJ).
La Corte, si legge in una nota diffusa sui canali social, nomina una giunta direttiva “ad hoc per portare avanti il processo di ristrutturazione democratica” del partito di Tomas Ignacio Guanipa, deputato in carica presso l’Assemblea Nazionale. Il partito viene messo nelle mani di José Dionisio Brito, ex membro di Pj, cui spetterà il compito di riempire le altre caselle dirigenziali a livello nazionale e locale. La decisione della corte surriscalda il dibattito sull’avvio del processo che dovrebbe riportare il paese alle urne, dopo la nomina di un nuovo Consiglio nazionale elettorale (Cne) da parte dello stesso Tsj. Il provvedimento segue la sospensione della giunta direttiva di Azione democratica (Accion democratica, Ad), uno dei principali partiti della destra.
Fonte
“Chi sono per tentare di imporsi con le minacce? Chi sono? Basta! Questo è il motivo per cui ho deciso di concedere all’ambasciatore dell’Unione europea 72 ore per lasciare il nostro Paese”, ha detto Maduro. “Sistemeremo la questione in 72 ore, le forniremo un aereo per andarsene, ma sistemeremo i nostri affari con l’Unione europea”.
Maduro ha anche affermato che il Venezuela si riserva azioni diplomatiche verso l’ambasciatore di Spagna per la sua partecipazione all’incursione armata di Macuto e per la sua complicità con le azioni criminali denunciate sul Wall Street Journal da Leopoldo Lopez.
Ieri il Consiglio Europeo ha aggiunto 11 alti funzionari venezuelani alla lista delle persone soggette a sanzioni, portando a 36 il numero dei funzionari venezuelani colpiti dalle misure interdittive della Ue.
Le personalità venezuelane sanzionate, si legge in una nota diramata dall’Ue, “sono responsabili per avere agito contro il funzionamento democratico dell’Assemblea Nazionale inclusa la rimozione dell’immunità parlamentare a diversi suoi membri”.
La misura include il divieto di viaggio e il congelamento dei beni. Tra le persone incluse nella lista ci sono Juan Jose Mendoza, presidente del Tribunale supremo di giustizia del Venezuela (Tsj) e Josè Ornelas, capo del Consiglio di difesa nazionale.
Le sanzioni della Ue sono state varate dopo le recenti decisioni del Tsj, di sospendere i vertici di due partiti di opposizione e di nominare i nuovi membri del Consiglio nazionale elettorale (Cne). Lo scorso 16 giugno il Tsj ha ordinato la sospensione dei vertici del partito di opposizione Prima la Giustizia (Primero Justicia, PJ).
La Corte, si legge in una nota diffusa sui canali social, nomina una giunta direttiva “ad hoc per portare avanti il processo di ristrutturazione democratica” del partito di Tomas Ignacio Guanipa, deputato in carica presso l’Assemblea Nazionale. Il partito viene messo nelle mani di José Dionisio Brito, ex membro di Pj, cui spetterà il compito di riempire le altre caselle dirigenziali a livello nazionale e locale. La decisione della corte surriscalda il dibattito sull’avvio del processo che dovrebbe riportare il paese alle urne, dopo la nomina di un nuovo Consiglio nazionale elettorale (Cne) da parte dello stesso Tsj. Il provvedimento segue la sospensione della giunta direttiva di Azione democratica (Accion democratica, Ad), uno dei principali partiti della destra.
Fonte
Gallera un assessore sotto tutela
Gran brutto periodo per l’assessore al welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera. All’inizio della pandemia si parlava di lui come futuro candidato per la destra a sindaco di Milano, oggi, dopo pochi mesi, è praticamente sotto tutela come assessore.
Infatti, il presidente della Regione, Attilio Fontana, ha deciso di nominare un comitato di “saggi” che avrà il compito di esaminare quanto in Lombardia non ha funzionato durante la pandemia, proponendo gli adattamenti ritenuti necessari.
Tale comitato riferirà le sue proposte direttamente al presidente Fontana, con un chiaro scavalcamento delle competenze di Gallera. Di tale comitato di “saggi” fanno parte, quasi ovviamente, diverse personalità di orientamento compatibile con le scelte praticate dalle destre sulla sanità negli ultimi decenni: Gianluca Vago, ex rettore della Statale di Milano e attualmente professore ordinario di Anatomia patologica sempre alla Statale, Giuseppe Remuzzi, direttore dell’Istituto Mario Negri, Gianluigi Spata, presidente dell’Ordine dei medici della Lombardia, Alberto Mantovani, direttore scientifico dell’Irccs Humanitas e Rosanna Tarricone, professore associato in Economia delle pubbliche amministrazioni all’Università Bocconi (tanto perché un bocconiano o una bocconiana non devono mancare mai).
Non c’è quindi da aspettarsi molto da questo comitato di “saggi” quanto amici, se non qualche osservazione marginale a amichevole che consenta alla giunta di tentare di ripulire la propria immagine indelebilmente macchiata dalla strage verificati in Lombardia.
Tuttavia, è chiaro che all’interno della giunta lombarda le acque sono agitate, di fronte alle richieste di commissariamento, alla quantità di denunce presentate alla Magistratura e alle manifestazioni che ogni giorno riempiono il piazzale antistante il palazzo della Regione.
Una situazione difficile da reggere, nella quale alla fine, forse, far cadere qualche testa per salvare il “sistema” può essere una scelta accettabile.
Che dire del futuro del traballante Gallera, quello che diceva in televisione, per spiegare l’indice di contagio, che ci “ci vuole che incontri contemporaneamente due positivi per contagiarmi” e che ha fatto gli elogi delle cliniche private che hanno ospitato nelle loro “lussuose” camere pazienti “ordinari”?
Probabilmente non ha molto da preoccuparsi, visto che i padroni della sanità lombarda sanno come compensare gli amici e adesso hanno anche imparato come farlo senza procurargli anni di prigione, come con Formigoni.
È di ieri la notizia che Roberto Maroni, ex presidente della Regione Lombardia, ispiratore della legge regionale 23/2015 che fa enormi regali al privato, è stato nominato nel consiglio d’amministrazione del gruppo San Donato, proprietario di una quantità di “eccellenze” private nella sanità del Nord Italia.
Del gruppo è presidente, per la cronaca, l’ex ministro Angelino Alfano.
Fonte
Infatti, il presidente della Regione, Attilio Fontana, ha deciso di nominare un comitato di “saggi” che avrà il compito di esaminare quanto in Lombardia non ha funzionato durante la pandemia, proponendo gli adattamenti ritenuti necessari.
Tale comitato riferirà le sue proposte direttamente al presidente Fontana, con un chiaro scavalcamento delle competenze di Gallera. Di tale comitato di “saggi” fanno parte, quasi ovviamente, diverse personalità di orientamento compatibile con le scelte praticate dalle destre sulla sanità negli ultimi decenni: Gianluca Vago, ex rettore della Statale di Milano e attualmente professore ordinario di Anatomia patologica sempre alla Statale, Giuseppe Remuzzi, direttore dell’Istituto Mario Negri, Gianluigi Spata, presidente dell’Ordine dei medici della Lombardia, Alberto Mantovani, direttore scientifico dell’Irccs Humanitas e Rosanna Tarricone, professore associato in Economia delle pubbliche amministrazioni all’Università Bocconi (tanto perché un bocconiano o una bocconiana non devono mancare mai).
Non c’è quindi da aspettarsi molto da questo comitato di “saggi” quanto amici, se non qualche osservazione marginale a amichevole che consenta alla giunta di tentare di ripulire la propria immagine indelebilmente macchiata dalla strage verificati in Lombardia.
Tuttavia, è chiaro che all’interno della giunta lombarda le acque sono agitate, di fronte alle richieste di commissariamento, alla quantità di denunce presentate alla Magistratura e alle manifestazioni che ogni giorno riempiono il piazzale antistante il palazzo della Regione.
Una situazione difficile da reggere, nella quale alla fine, forse, far cadere qualche testa per salvare il “sistema” può essere una scelta accettabile.
Che dire del futuro del traballante Gallera, quello che diceva in televisione, per spiegare l’indice di contagio, che ci “ci vuole che incontri contemporaneamente due positivi per contagiarmi” e che ha fatto gli elogi delle cliniche private che hanno ospitato nelle loro “lussuose” camere pazienti “ordinari”?
Probabilmente non ha molto da preoccuparsi, visto che i padroni della sanità lombarda sanno come compensare gli amici e adesso hanno anche imparato come farlo senza procurargli anni di prigione, come con Formigoni.
È di ieri la notizia che Roberto Maroni, ex presidente della Regione Lombardia, ispiratore della legge regionale 23/2015 che fa enormi regali al privato, è stato nominato nel consiglio d’amministrazione del gruppo San Donato, proprietario di una quantità di “eccellenze” private nella sanità del Nord Italia.
Del gruppo è presidente, per la cronaca, l’ex ministro Angelino Alfano.
Fonte
La Scuola si cala le braghe davanti a Microsoft
Ieri mattina presto tutte le scuole d’Italia hanno ricevuto l’avviso che le loro caselle mail istituzionali sono state migrate a Office365. Si tratta delle caselle che noi cittadini usiamo per comunicare con la scuola dei nostri figli, e che le scuole usano per comunicare tra loro e con il resto del mondo.
Da quel che si può capire sino ad oggi, la migrazione ha riguardato le sole caselle istituzionali, ovvero le caselle dei Dirigenti Scolastici, Dei Direttori amministrativi e le caselle legate al codice meccanografico della scuola.
Il ministero precisa che «I DS e i DSGA e le scuole accedono usando l’user-name completo e il suffisso @istruzione.gov.it (per esempio mario.rossi@istruzione.gov.it.). Per quanto riguarda il personale dell’amministrazione (MI e MIM) l’accesso è garantito dalle credenziali composte da user-name completo e dal suffisso @istruzione.it (per esempio mi12345@istruzione.it)».
Il motivo del cambiamento non è ancora chiaro, e non si capisce se esso si inquadri nel più generale impegno del Ministero dell’Istruzione verso la Didattica a Distanza (DaD).
Nel Piano Scuola 2020/2021, nel capitolo che riguarda la Didattica digitale integrata, si dice che «Il Ministero dell’Istruzione ha avviato uno studio approfondito per la progettazione (sic!) di una piattaforma finalizzata all’erogazione di contenuti didattici a distanza, sulla quale saranno fornite successivamente le opportune informazioni di dettaglio».
Office365, con i suoi annessi e connessi (Teams, OneDrive, Microsoft SharePoint, Microsoft Bookings, Word, Excel, PowerPoint, etc), è anche – e visti i tempi, soprattutto – una piattaforma di Didattica digitale integrata.
Non c’è nulla da dire contro questa piattaforma. Se noi, in Italia, non siamo capaci di mettere in piedi due server con uno strumento di E-Learning, oppure se ne siamo capaci, ma a costi esorbitanti, allora è giusto che si esternalizzi questo servizio e lo si affidi a Microsoft.
Se invece queste competenze in Italia ci sono, se abbiamo i mezzi e le opportunità, è bene che questo servizio ce lo costruiamo da soli. Anche se queste competenze dovessero essere più scadenti di quelle dei concorrenti esteri – ripeto – è bene, anche in questo caso, che il servizio venga realizzato in Italia, con forza lavoro e intelligenza nostrana.
Sarà un’occasione per mettersi alla prova e crescere, per dare lavoro a impiegati e programmatori italiani, eccetera. Sarà un’opportunità per il nostro Stato di crescere e di far crescere competenze diffuse. La gran parte delle industrie che in Italia si occupano di IT sono legate in qualche modo alla vecchia SIP, l’azienda PUBBLICA dei telefoni.
In più, Office365 non è gratis. In ogni caso, non è gratis. Non c’è niente di gratis sul mercato. Bisogna pagare un prezzo, e anche salato – si parla di 5 euro (minimo) ad account, al mese, che moltiplicati per i milioni di alunni e professori delle scuole fanno un bel malloppo.
Pensiamoci bene prima di fare una scelta del genere.
Infine, c’è una questione più grossa, che riguarda la nostra dimensione giurisdizionale.
Il sistema mail della scuola non è un sistema tra gli altri. È un cosiddetto Big Data. Per iscrivere il figlio a scuola il genitore deve obbligatoriamente registrarsi sul portale del Ministero e ottenere le credenziali («Le iscrizioni on line sono obbligatorie per le scuole statali» – istruzione.it). Senza queste credenziali non si può iscrivere il figlio a scuola.
Ergo, tutti i genitori d’Italia hanno un account del Ministero, e se non hanno un account, debbono munirsi di un account Spid – e qui (con lo Spid) le cose si complicano, invece di semplificarsi (come viene promesso). Perché a gestire lo Spid sono ancora una pluralità di soggetti privati, dei quali non si conoscono bene le ramificazioni. In particolare, non si conosce la gestione e allocazione delle macchine fisiche, dei computer, dell’hardware.
Dove si trovano le nostre informazioni, dove sono locate?
Dopo anni di ubriacatura sui benefici della de-territorializzazione e del modello rizomatico (alla Deleuze) oggi torna di attualità la domanda sul territorio, sul perimetro giurisdizionale.
Non si tratta di questioni di lana caprina o di filosofia. Se domani, per un motivo qualsiasi, si dovesse interrompere la comunicazione tra l’Italia e questo luogo di conservazione (che non è una nuvola – cloud – non sta nell’iperuranio), come ci si connette con la scuola? Come ci si connette con la pubblica amministrazione?
Si tratta di una questione maledettamente vecchia e barbosa, che ha a che fare con il territorio, con le frontiere, con le dorsali di comunicazione. Va bene che siamo in un mondo globalizzato, va bene che ormai per ogni più minuta sciocchezza dipendiamo da questo e quest’altro sub-fornitore, e che anche la Germania se vuole mettere in strada le sue macchine deve aspettare che dall’Italia gli arrivino i bulloni e i cerchioni.
Va tutto bene, non vogliamo tornare indietro, non siamo nostalgici della campagna, di montagne verdi e conigli dal muso nero. Abbiamo il senso del tempo.
Tuttavia, abbiamo sperimentato la frustrazione di non saper fare una cosa stupida come le mascherine. Non bisogna arrivare al punto di mordersi le mani quando, in questo mondo multi-polare, un piccolo staterello satellite della Germania si appropria della nostra commessa di mascherine provenienti dalla Cina.
Fonte
Da quel che si può capire sino ad oggi, la migrazione ha riguardato le sole caselle istituzionali, ovvero le caselle dei Dirigenti Scolastici, Dei Direttori amministrativi e le caselle legate al codice meccanografico della scuola.
Il ministero precisa che «I DS e i DSGA e le scuole accedono usando l’user-name completo e il suffisso @istruzione.gov.it (per esempio mario.rossi@istruzione.gov.it.). Per quanto riguarda il personale dell’amministrazione (MI e MIM) l’accesso è garantito dalle credenziali composte da user-name completo e dal suffisso @istruzione.it (per esempio mi12345@istruzione.it)».
Il motivo del cambiamento non è ancora chiaro, e non si capisce se esso si inquadri nel più generale impegno del Ministero dell’Istruzione verso la Didattica a Distanza (DaD).
Nel Piano Scuola 2020/2021, nel capitolo che riguarda la Didattica digitale integrata, si dice che «Il Ministero dell’Istruzione ha avviato uno studio approfondito per la progettazione (sic!) di una piattaforma finalizzata all’erogazione di contenuti didattici a distanza, sulla quale saranno fornite successivamente le opportune informazioni di dettaglio».
Office365, con i suoi annessi e connessi (Teams, OneDrive, Microsoft SharePoint, Microsoft Bookings, Word, Excel, PowerPoint, etc), è anche – e visti i tempi, soprattutto – una piattaforma di Didattica digitale integrata.
Non c’è nulla da dire contro questa piattaforma. Se noi, in Italia, non siamo capaci di mettere in piedi due server con uno strumento di E-Learning, oppure se ne siamo capaci, ma a costi esorbitanti, allora è giusto che si esternalizzi questo servizio e lo si affidi a Microsoft.
Se invece queste competenze in Italia ci sono, se abbiamo i mezzi e le opportunità, è bene che questo servizio ce lo costruiamo da soli. Anche se queste competenze dovessero essere più scadenti di quelle dei concorrenti esteri – ripeto – è bene, anche in questo caso, che il servizio venga realizzato in Italia, con forza lavoro e intelligenza nostrana.
Sarà un’occasione per mettersi alla prova e crescere, per dare lavoro a impiegati e programmatori italiani, eccetera. Sarà un’opportunità per il nostro Stato di crescere e di far crescere competenze diffuse. La gran parte delle industrie che in Italia si occupano di IT sono legate in qualche modo alla vecchia SIP, l’azienda PUBBLICA dei telefoni.
In più, Office365 non è gratis. In ogni caso, non è gratis. Non c’è niente di gratis sul mercato. Bisogna pagare un prezzo, e anche salato – si parla di 5 euro (minimo) ad account, al mese, che moltiplicati per i milioni di alunni e professori delle scuole fanno un bel malloppo.
Pensiamoci bene prima di fare una scelta del genere.
Infine, c’è una questione più grossa, che riguarda la nostra dimensione giurisdizionale.
Il sistema mail della scuola non è un sistema tra gli altri. È un cosiddetto Big Data. Per iscrivere il figlio a scuola il genitore deve obbligatoriamente registrarsi sul portale del Ministero e ottenere le credenziali («Le iscrizioni on line sono obbligatorie per le scuole statali» – istruzione.it). Senza queste credenziali non si può iscrivere il figlio a scuola.
Ergo, tutti i genitori d’Italia hanno un account del Ministero, e se non hanno un account, debbono munirsi di un account Spid – e qui (con lo Spid) le cose si complicano, invece di semplificarsi (come viene promesso). Perché a gestire lo Spid sono ancora una pluralità di soggetti privati, dei quali non si conoscono bene le ramificazioni. In particolare, non si conosce la gestione e allocazione delle macchine fisiche, dei computer, dell’hardware.
Dove si trovano le nostre informazioni, dove sono locate?
Dopo anni di ubriacatura sui benefici della de-territorializzazione e del modello rizomatico (alla Deleuze) oggi torna di attualità la domanda sul territorio, sul perimetro giurisdizionale.
Non si tratta di questioni di lana caprina o di filosofia. Se domani, per un motivo qualsiasi, si dovesse interrompere la comunicazione tra l’Italia e questo luogo di conservazione (che non è una nuvola – cloud – non sta nell’iperuranio), come ci si connette con la scuola? Come ci si connette con la pubblica amministrazione?
Si tratta di una questione maledettamente vecchia e barbosa, che ha a che fare con il territorio, con le frontiere, con le dorsali di comunicazione. Va bene che siamo in un mondo globalizzato, va bene che ormai per ogni più minuta sciocchezza dipendiamo da questo e quest’altro sub-fornitore, e che anche la Germania se vuole mettere in strada le sue macchine deve aspettare che dall’Italia gli arrivino i bulloni e i cerchioni.
Va tutto bene, non vogliamo tornare indietro, non siamo nostalgici della campagna, di montagne verdi e conigli dal muso nero. Abbiamo il senso del tempo.
Tuttavia, abbiamo sperimentato la frustrazione di non saper fare una cosa stupida come le mascherine. Non bisogna arrivare al punto di mordersi le mani quando, in questo mondo multi-polare, un piccolo staterello satellite della Germania si appropria della nostra commessa di mascherine provenienti dalla Cina.
Fonte
Francia - Elezioni comunali, disfatta per Macron
Domenica 28 giugno si è svolto il secondo turno delle elezioni municipali in Francia, segnate dalla scarsa affluenza al voto con un un tasso d’astensione attorno al 60%.
Già durante il primo turno, il 15 marzo, meno di un elettore su due (il 44,3%) si era recato alle urne, contro il 63,5% delle precedenti elezioni municipali del 2014.
Un astensione storica per questo tipo di elezioni locali, ma non per ciò che concerne la disaffezione al voto nella Francia recente, in cui il primo partito delle classi popolari è per così dire da tempo quello “astensionista”.
Alle elezioni europee della scorsa estate – sebbene si fosse registrato un aumento dei votanti – solo una persona su due, circa, si era recato alle urne, avvicinando la partecipazione del 1994 – al 52,7% – con un 8,3% in più rispetto 2014.
Nel 2009 i votanti erano stati solo il 40,6% degli aventi diritto.
Tra il 1990 e il 2014, tra i paesi della UE, la Francia è stata in testa per il tasso medio di astensione (40%), decisamente avanti rispetto al gruppo mediano (Olanda, Spagna, Germania). Inoltre era il solo paese in cui la “non partecipazione” al voto ha conosciuto una progressione lineare.
Certamente ci sono delle ragioni “congiunturali” che contribuiscono a spiegare in parte l’astensione, come la situazione sanitaria e il lungo lasso di tempo tra i due turni, dovuto al lockdown; ma è innegabile che anche le elezioni comunali, per lungo tempo sfuggite al “dégagisme”, ne sono state travolte.
Tutti gli attori politici s’interrogano su questa crisi del sistema della rappresentanza e dei suoi tradizionali vettori, che ora ha toccato l’unica istituzione della quinta repubblica che ne era stata risparmiata. C’è chi lo fa “strumentalmente” per coprire la propria débâcle (come LREM, l’organizzazione politica creata da Macron) o il proprio parziale insuccesso – come Marine Le Pen del RN (ex FN) – oppure in maniera più sincera, come Jean-Luc Mélenchon, leader di LFI. In un intervento diffuso su You Tube ha evocato un “un nulla civico”.
“La massa del popolo francese è in guerra civica”, ha spiegato.
Un paradosso apparente vista la vivacità delle mobilitazioni che ha caratterizzato la Francia nell’ultimo anno, riprese subito dopo la fine del “Lock-down”.
Al primo turno delle elezioni presidenziali del 2017, proprio gli Insoumis.es erano riusciti in parte a colmare questo deficit di “rappresentanza” tra le classi popolari, sfiorando il 20% e giungendo ad un passo dal ballottaggio, offrendo un output politico in particolare alle mobilitazioni contro la “lois travaille” – il “job act” francese – voluta dal presidente socialista Hollande.
Sembra un secolo fa.
La LFI era riuscita insieme ad altre formazioni – tra cui il PCF – a dare vita ad un’opposizione “a geometria variabile”, che talvolta aveva incluso sia i socialisti sia i verdi, ed a fungere da “delegato politico” dei vari movimenti che si sono fin qui succeduti: dai “gilets jaunes” alle recenti riforme contro la riforma pensionistica, così come a quelle del personale sanitario.
Non è pero riuscita a capitalizzare – così come la destra – il sentimento di sfiducia nei confronti dell’attuale compagine governativa ed in generale l’approfondirsi della frattura tra élite e classi popolari, né a darsi una struttura organizzativa che le permettesse di radicarsi.
Paradossalmente ha conosciuto una “parabola discendente” di cui è un sintomo la diluizione della propria presenza nelle elezioni municipali dentro coalizioni più ampie. A parte il ruolo di primo piano giocato a Marsiglia e che ha contribuito al successo di “Primetemps Marseilleise”, forse la nota più positiva dell’intero panorama elettorale per modalità di costruzione, programmi e capacità di interpretare una aspettativa di cambiamento.
La batosta per LREM è pesantissima, e dimostra come in questi tre anni la creazione politica di Macron non sia stata capace di radicarsi, nonostante alla sua creazione abbiano contribuito sia notabili locali del Partito Socialista – come il più volte ex sindaco di Lione e poi ministro, Gérard Collomb – sia membri della vecchia nomenclatura gaullista.
“En Marche!” ha dilapidato ben presto il suo consenso, divenendo sempre più solo espressione delle classi medio-alte, e ha progressivamente “virato a destra”. A nulla è servita la sua alleanza in questo secondo turno con i gaullisti di Les Républicains di Laurent Wauquiez, che non ha sbarrato la strada all’“onda verde”.
Gli unici “successi” di quest’asse politico sono stati a Le Havre, dove il primo ministro E.Philippe ha conquistato la città, e a Tolosa...
A Parigi, dove è stata confermata Anne Hidalgo, la capolista di Lrem, Agnès Buzyn, ha fatto meno del 15% e non siederà in consiglio comunale; a Lione Collomb è stato sconfitto, così come a Strasburgo.
I verdi – EELV – sono i veri vincitori di questa competizione elettorale. I sindaci provenienti dalle loro fila sono stati spesso eletti con l’appoggio di ampie coalizioni – come a Tours, Bordeaux o Lione – o andando contro i socialisti, come a Strasburgo.
Sono sintomo della necessità di una transizione ecologica che è cresciuta in questi anni nel corso di importanti mobilitazioni specifiche e circoscritte, così come di più ampie mobilitazioni di massa – “gli scioperi per il clima”, prima del fenomeno Greta, erano nati in Belgio e Francia – ed una interessante convergenze nel corso della marea gialla sintetizzata dallo slogan. “fine del mese, fine del mondo: stessa lotta”.
Lo tsunami verde è la traduzione di questa spinta sul piano della rappresentanza politica locale. Qualcosa di analogo a ciò che è avvenuto in Germania ed in Belgio tra le classi medie urbane giovani e scolarizzate.
Un risultato anche della pandemia, come sembra suggerire J. Fourquet, direttore di un dipartimento dell’istituto di rivelazioni statistiche IFOP: “la griglia di lettura dell’epidemia si è costituita attorno all’ecologia, con degli interrogativi riguardo ai nostri modi di vita e di consumo che mettono troppo a dura prova i nostri ecosistemi”.
Il passaggio di fase è interessante, perché pone quello che era un “partito d’opinione” – EELV, conosciuto più che altro per gli exploit alle europee (avevano ottenuto il 13,5% circa alle ultime elezioni) e l’ambiguo politicismo della sua storica direzione – al governo di importanti amministrazioni che saranno il banco di prova concreto per le politiche ecologiche: Lione, Strasburgo, Bordeaux, Poitiers, Bencançons, Tours, Annecy, per non citare che i principali.
A Lione conquistano città e “area metropolitana”, in cui gestiranno 3 miliardi di budget di una delle più potenti collettività francesi che concentra su di sé affari sociali, infrastrutture ed alloggi.
Prima di conquistare Grenoble nel 2014 con Eric Piolle – confermato con ampissimo margine – i verdi non avevano mai governato una città con più di 100 mila abitanti, a parte Montreuil tra il 2008 ed il 2014.
Al suo interno si scontrano due orientamenti differenti: gli “autonomi” alla Y. Jadot, che preferiscono “correre da soli” e che possano vantare successi di questa strategia e deplorare le sconfitte altrui, e i “rassembleurs”, fautori di una strategia di coalizione che possono vantare successi importanti.
È abbastanza evidente la frattura generazionale tra la vecchia classe dirigente “ecologista” e le nuove generazioni di sindaci.
Sono divenuti il nuovo “ago della bilancia” a sinistra, come ha ben compreso il leader del PS O. Faure.
“Qualcosa sta nascendo” – ha affermato il leader socialista – “un blocco sociale ed ecologista”.
I socialisti hanno dimostrato una certa “resilienza” in queste elezioni dopo una crisi, che sembrava irreversibile, successiva alla Presidenza Hollande, la diaspora in direzione di Macron di molti suoi esponenti e la mancata presentazione di un candidato nel 2017.
Confermano Parigi – esito per nulla scontato fino a poco tempo fa – e conquistano Lille sfidando gli ecologisti, e vincono – dopo essere giunti ad un accordo con i verdi al secondo turno – a Rennes e Nantes. Riconquistano dei comuni che erano loro bastioni, persi nel 2014, e ne conquistano di nuovi come a Nancy, od in ampie alleanze come a Montpellier.
Dopo l’exploit del 2014, la destra di LR conferma sostanzialmente le sue posizioni a livello locale, con due “pezzi da novanta” persi come Marsiglia – probabilmente – governata per 25 anni, Bordeaux e canta in parte vittoria.
“È tre anni che inanelliamo sconfitte”, ha dichiarato Christian Jacob, patron di LR che ha parlato di “vittoria”. Ma sembra più il tentativo di dare un nuovo slancio ad un progetto politico le cui direttive a livello centrale sono sempre più cooptate da LREM.
L’ex FN, ora RN, conquista un comune importante come Perpignan, con più di 100 mila abitanti, ma subisce comunque sconfitte come a Lunel, Vauvert…
I numeri parlano chiaro e fanno terra bruciata di tutte le chiacchiere sul pericolo dell’“onda nera” di cui hanno straparlato a lungo i media nostrani.
Nel 2014 aveva conquistato 1438 seggi in 463 comuni, stavolta solo 840 in 258, e governeranno in meno di una decina di comuni.
Il PCF vede ridimensionato il successo del primo turno, come a Montreuil – nella prima periferia parigina – perdendo alcuni suoi bastioni storici come a Saint-Denis e Aubervilliers, ma riconquistando Bobigny, sempre nella regione parigina.
Un risultato, nel complesso, fatto più di ombre che di luci, in cui perdono a Le Havre ed Arles, oltre a Saint-Denis, le città più importanti di questa battaglia.
Sono più di 20 i comuni sopra i 3.500 abitanti “persi” dai comunisti, mentre sono una quarantina quelli conservati o conquistati.
Queste elezioni – che si concluderanno con un “terzo turno” tra gli eletti, a Marsiglia, che decideranno il futuro sindaco della seconda città dell’Esagono – ci consegnano un quadro complesso della società francese uscita dalla pandemia.
Un governo senza consenso; i vettori della politica, sia tradizionali che “nuovi” – tranne i verdi e alcune coalizioni politiche molto variabili – incapaci di catalizzare la disaffezione per l’establishment compresi, ai poli opposti, La France Insoumise e l’ex Front National – ora RN –, con un marcato scetticismo nei confronti della UE, come certifica un recente sondaggio condotto da un think tank del Consiglio Europeo citato dal “The Guardian”.
Il 58% degli intervistati in Francia pensa che l’UE sia stata irrilevante nella crisi pandemica – ponendo questo paese al primo posto per sfiducia nella UE – mentre il 61% dei francesi pensava, a fine aprile, che il proprio governo non fosse stato all’altezza nell’affrontare l’emergenza e si sentiva più disilluso rispetto a prima dell’arrivo del Covid-19.
Non proprio un dato incoraggiante per un governo che si pone come perno fondamentale del rilancio dell’Unione Europea.
Fonte
Già durante il primo turno, il 15 marzo, meno di un elettore su due (il 44,3%) si era recato alle urne, contro il 63,5% delle precedenti elezioni municipali del 2014.
Un astensione storica per questo tipo di elezioni locali, ma non per ciò che concerne la disaffezione al voto nella Francia recente, in cui il primo partito delle classi popolari è per così dire da tempo quello “astensionista”.
Alle elezioni europee della scorsa estate – sebbene si fosse registrato un aumento dei votanti – solo una persona su due, circa, si era recato alle urne, avvicinando la partecipazione del 1994 – al 52,7% – con un 8,3% in più rispetto 2014.
Nel 2009 i votanti erano stati solo il 40,6% degli aventi diritto.
Tra il 1990 e il 2014, tra i paesi della UE, la Francia è stata in testa per il tasso medio di astensione (40%), decisamente avanti rispetto al gruppo mediano (Olanda, Spagna, Germania). Inoltre era il solo paese in cui la “non partecipazione” al voto ha conosciuto una progressione lineare.
Certamente ci sono delle ragioni “congiunturali” che contribuiscono a spiegare in parte l’astensione, come la situazione sanitaria e il lungo lasso di tempo tra i due turni, dovuto al lockdown; ma è innegabile che anche le elezioni comunali, per lungo tempo sfuggite al “dégagisme”, ne sono state travolte.
Tutti gli attori politici s’interrogano su questa crisi del sistema della rappresentanza e dei suoi tradizionali vettori, che ora ha toccato l’unica istituzione della quinta repubblica che ne era stata risparmiata. C’è chi lo fa “strumentalmente” per coprire la propria débâcle (come LREM, l’organizzazione politica creata da Macron) o il proprio parziale insuccesso – come Marine Le Pen del RN (ex FN) – oppure in maniera più sincera, come Jean-Luc Mélenchon, leader di LFI. In un intervento diffuso su You Tube ha evocato un “un nulla civico”.
“La massa del popolo francese è in guerra civica”, ha spiegato.
Un paradosso apparente vista la vivacità delle mobilitazioni che ha caratterizzato la Francia nell’ultimo anno, riprese subito dopo la fine del “Lock-down”.
Al primo turno delle elezioni presidenziali del 2017, proprio gli Insoumis.es erano riusciti in parte a colmare questo deficit di “rappresentanza” tra le classi popolari, sfiorando il 20% e giungendo ad un passo dal ballottaggio, offrendo un output politico in particolare alle mobilitazioni contro la “lois travaille” – il “job act” francese – voluta dal presidente socialista Hollande.
Sembra un secolo fa.
La LFI era riuscita insieme ad altre formazioni – tra cui il PCF – a dare vita ad un’opposizione “a geometria variabile”, che talvolta aveva incluso sia i socialisti sia i verdi, ed a fungere da “delegato politico” dei vari movimenti che si sono fin qui succeduti: dai “gilets jaunes” alle recenti riforme contro la riforma pensionistica, così come a quelle del personale sanitario.
Non è pero riuscita a capitalizzare – così come la destra – il sentimento di sfiducia nei confronti dell’attuale compagine governativa ed in generale l’approfondirsi della frattura tra élite e classi popolari, né a darsi una struttura organizzativa che le permettesse di radicarsi.
Paradossalmente ha conosciuto una “parabola discendente” di cui è un sintomo la diluizione della propria presenza nelle elezioni municipali dentro coalizioni più ampie. A parte il ruolo di primo piano giocato a Marsiglia e che ha contribuito al successo di “Primetemps Marseilleise”, forse la nota più positiva dell’intero panorama elettorale per modalità di costruzione, programmi e capacità di interpretare una aspettativa di cambiamento.
La batosta per LREM è pesantissima, e dimostra come in questi tre anni la creazione politica di Macron non sia stata capace di radicarsi, nonostante alla sua creazione abbiano contribuito sia notabili locali del Partito Socialista – come il più volte ex sindaco di Lione e poi ministro, Gérard Collomb – sia membri della vecchia nomenclatura gaullista.
“En Marche!” ha dilapidato ben presto il suo consenso, divenendo sempre più solo espressione delle classi medio-alte, e ha progressivamente “virato a destra”. A nulla è servita la sua alleanza in questo secondo turno con i gaullisti di Les Républicains di Laurent Wauquiez, che non ha sbarrato la strada all’“onda verde”.
Gli unici “successi” di quest’asse politico sono stati a Le Havre, dove il primo ministro E.Philippe ha conquistato la città, e a Tolosa...
A Parigi, dove è stata confermata Anne Hidalgo, la capolista di Lrem, Agnès Buzyn, ha fatto meno del 15% e non siederà in consiglio comunale; a Lione Collomb è stato sconfitto, così come a Strasburgo.
I verdi – EELV – sono i veri vincitori di questa competizione elettorale. I sindaci provenienti dalle loro fila sono stati spesso eletti con l’appoggio di ampie coalizioni – come a Tours, Bordeaux o Lione – o andando contro i socialisti, come a Strasburgo.
Sono sintomo della necessità di una transizione ecologica che è cresciuta in questi anni nel corso di importanti mobilitazioni specifiche e circoscritte, così come di più ampie mobilitazioni di massa – “gli scioperi per il clima”, prima del fenomeno Greta, erano nati in Belgio e Francia – ed una interessante convergenze nel corso della marea gialla sintetizzata dallo slogan. “fine del mese, fine del mondo: stessa lotta”.
Lo tsunami verde è la traduzione di questa spinta sul piano della rappresentanza politica locale. Qualcosa di analogo a ciò che è avvenuto in Germania ed in Belgio tra le classi medie urbane giovani e scolarizzate.
Un risultato anche della pandemia, come sembra suggerire J. Fourquet, direttore di un dipartimento dell’istituto di rivelazioni statistiche IFOP: “la griglia di lettura dell’epidemia si è costituita attorno all’ecologia, con degli interrogativi riguardo ai nostri modi di vita e di consumo che mettono troppo a dura prova i nostri ecosistemi”.
Il passaggio di fase è interessante, perché pone quello che era un “partito d’opinione” – EELV, conosciuto più che altro per gli exploit alle europee (avevano ottenuto il 13,5% circa alle ultime elezioni) e l’ambiguo politicismo della sua storica direzione – al governo di importanti amministrazioni che saranno il banco di prova concreto per le politiche ecologiche: Lione, Strasburgo, Bordeaux, Poitiers, Bencançons, Tours, Annecy, per non citare che i principali.
A Lione conquistano città e “area metropolitana”, in cui gestiranno 3 miliardi di budget di una delle più potenti collettività francesi che concentra su di sé affari sociali, infrastrutture ed alloggi.
Prima di conquistare Grenoble nel 2014 con Eric Piolle – confermato con ampissimo margine – i verdi non avevano mai governato una città con più di 100 mila abitanti, a parte Montreuil tra il 2008 ed il 2014.
Al suo interno si scontrano due orientamenti differenti: gli “autonomi” alla Y. Jadot, che preferiscono “correre da soli” e che possano vantare successi di questa strategia e deplorare le sconfitte altrui, e i “rassembleurs”, fautori di una strategia di coalizione che possono vantare successi importanti.
È abbastanza evidente la frattura generazionale tra la vecchia classe dirigente “ecologista” e le nuove generazioni di sindaci.
Sono divenuti il nuovo “ago della bilancia” a sinistra, come ha ben compreso il leader del PS O. Faure.
“Qualcosa sta nascendo” – ha affermato il leader socialista – “un blocco sociale ed ecologista”.
I socialisti hanno dimostrato una certa “resilienza” in queste elezioni dopo una crisi, che sembrava irreversibile, successiva alla Presidenza Hollande, la diaspora in direzione di Macron di molti suoi esponenti e la mancata presentazione di un candidato nel 2017.
Confermano Parigi – esito per nulla scontato fino a poco tempo fa – e conquistano Lille sfidando gli ecologisti, e vincono – dopo essere giunti ad un accordo con i verdi al secondo turno – a Rennes e Nantes. Riconquistano dei comuni che erano loro bastioni, persi nel 2014, e ne conquistano di nuovi come a Nancy, od in ampie alleanze come a Montpellier.
Dopo l’exploit del 2014, la destra di LR conferma sostanzialmente le sue posizioni a livello locale, con due “pezzi da novanta” persi come Marsiglia – probabilmente – governata per 25 anni, Bordeaux e canta in parte vittoria.
“È tre anni che inanelliamo sconfitte”, ha dichiarato Christian Jacob, patron di LR che ha parlato di “vittoria”. Ma sembra più il tentativo di dare un nuovo slancio ad un progetto politico le cui direttive a livello centrale sono sempre più cooptate da LREM.
L’ex FN, ora RN, conquista un comune importante come Perpignan, con più di 100 mila abitanti, ma subisce comunque sconfitte come a Lunel, Vauvert…
I numeri parlano chiaro e fanno terra bruciata di tutte le chiacchiere sul pericolo dell’“onda nera” di cui hanno straparlato a lungo i media nostrani.
Nel 2014 aveva conquistato 1438 seggi in 463 comuni, stavolta solo 840 in 258, e governeranno in meno di una decina di comuni.
Il PCF vede ridimensionato il successo del primo turno, come a Montreuil – nella prima periferia parigina – perdendo alcuni suoi bastioni storici come a Saint-Denis e Aubervilliers, ma riconquistando Bobigny, sempre nella regione parigina.
Un risultato, nel complesso, fatto più di ombre che di luci, in cui perdono a Le Havre ed Arles, oltre a Saint-Denis, le città più importanti di questa battaglia.
Sono più di 20 i comuni sopra i 3.500 abitanti “persi” dai comunisti, mentre sono una quarantina quelli conservati o conquistati.
Queste elezioni – che si concluderanno con un “terzo turno” tra gli eletti, a Marsiglia, che decideranno il futuro sindaco della seconda città dell’Esagono – ci consegnano un quadro complesso della società francese uscita dalla pandemia.
Un governo senza consenso; i vettori della politica, sia tradizionali che “nuovi” – tranne i verdi e alcune coalizioni politiche molto variabili – incapaci di catalizzare la disaffezione per l’establishment compresi, ai poli opposti, La France Insoumise e l’ex Front National – ora RN –, con un marcato scetticismo nei confronti della UE, come certifica un recente sondaggio condotto da un think tank del Consiglio Europeo citato dal “The Guardian”.
Il 58% degli intervistati in Francia pensa che l’UE sia stata irrilevante nella crisi pandemica – ponendo questo paese al primo posto per sfiducia nella UE – mentre il 61% dei francesi pensava, a fine aprile, che il proprio governo non fosse stato all’altezza nell’affrontare l’emergenza e si sentiva più disilluso rispetto a prima dell’arrivo del Covid-19.
Non proprio un dato incoraggiante per un governo che si pone come perno fondamentale del rilancio dell’Unione Europea.
Fonte
29/06/2020
Brancaccio - La lotta alla “casta”? Solo un alibi per l’austerity
l’Espresso, 28 giugno 2020
Sostenuta dai potentati mediatici e finanziari, la propaganda anti-casta di questi anni è stata soltanto una delle forme fenomeniche della reazione anti-statuale. In essa non c’è nessuna rivoluzione giacobina, nessun furore rosso. Solo bieca vandea liberista.
di Emiliano Brancaccio
Meno di un euro, nemmeno un caffè all’anno. È questo il risparmio che ogni cittadino italiano potrà attendersi dal taglio dei parlamentari che sarà oggetto di referendum confermativo il 20 e 21 settembre prossimi.
Iniziata una dozzina di anni fa come puritana ribellione verso un ceto politico ingordo di privilegi, la lotta alla casta giunge così al suo infimo epilogo. In origine la crociata poteva rivendicare risparmi un po’ più consistenti, come ad esempio la stretta di 700 milioni sulle famigerate auto blu. Oggi deve accontentarsi di un più magro bottino: dall’annunciato taglio dei parlamentari verranno meno di 60 milioni. Ma a ben guardare, nemmeno ai suoi esordi la guerra alla casta ha avuto la benché minima rilevanza macroeconomica. I tagli più rilevanti ai privilegi del ceto politico, effettuati sotto l’austerico governo Monti, non hanno mai raggiunto il millesimo della spesa pubblica nazionale. Una roboante propaganda su risibili voci di contabilità, insomma.
Si potrebbe obiettare che per soddisfare la brama popolare di vendetta contro un ceto politico reputato inetto e distante, la rilevanza macroeconomica dei tagli sia in fondo secondaria. Ma allora, perché questa risibile insistenza sul risparmio per le casse pubbliche? Il motivo è presto detto.
La verità è che le strette sulle poltrone, sui viaggi e sulle buvettes dell’odiata casta politica sono state un alibi ingegnoso per far passare ben altri tagli ai fondi pubblici, che hanno provocato danni incalcolabili alle infrastrutture, alla ricerca, all’istruzione e anche alla sanità pubblica, come ormai purtroppo sappiamo. Sapere dei tagli al ristorante di Montecitorio ha reso più tollerabile il clima generale di austerity, ridurre l’odiato parlamentare alla questua ha reso più accettabile la dura quaresima per tutti.
Le rivalse anti-casta vanno quindi valutate per quel che sono: un oppio del popolo per intorpidire le menti e giustificare il più reazionario ordine di politica economica che si sia imposto nella storia repubblicana. Oggi è il turno dei pentastellati, peraltro appoggiati da quasi tutto l’arco parlamentare. Ma dai democratici alle destre forcaiole, appoggiate dalla grande stampa tutte le forze di governo hanno abusato in questi anni del venefico oppiaceo. E gli effetti sono sotto i nostri occhi. I politici si ritroveranno pure con meno scranni e meno rimborsi, ma è solo un diversivo: quel che conta è che la politica generale di austerity ha allargato la forbice macroeconomica tra ricchi e poveri, in particolare tra percettori di profitti e rendite da un lato e lavoratori salariati dall’altro. Alla fine, la vendetta sociale ha operato in direzione esattamente contraria a quel che si crede.
Eppure a quanto pare non ci siamo ancora svegliati dal torpore. La drogante propaganda anti-casta continua a circolare e c’è il rischio che faccia i suoi danni anche al prossimo appuntamento referendario. Con un risvolto particolarmente ridicolo, questa volta. Andremo infatti a votare nel mezzo di una colossale crisi economica, che sta determinando la più rapida caduta della produzione e del reddito che si sia registrata nella storia del capitalismo. Per arginare la catastrofe i governi hanno dovuto per forza dare sfogo alla spesa pubblica e al deficit di bilancio. Nella sola Italia il disavanzo statale aumenterà di un centinaio di miliardi rispetto all’anno scorso. E non si immagini che le cose torneranno rapidamente al loro posto. Persino l’ex presidente della BCE ha ammesso che con l’esplosione dei debiti pubblici dovremo convivere e che per lungo tempo toccherà alle banche centrali governare i mercati per garantire la sostenibilità dei bilanci. In questo gigantesco rivolgimento della politica economica, la scena dei tagliatori di scranni parlamentari che si rallegrano per un risparmio di un euro scarso all’anno per ogni cittadino risulta semplicemente patetica.
Per giunta, se la riforma costituzionale sarà approvata, ci ritroveremo con un solo parlamentare ogni 151 mila cittadini, il più basso livello di rappresentanza politica in rapporto alla popolazione nell’Unione europea. Sappiamo bene che la crisi della rappresentanza si può risolvere solo con una espansione e un radicamento capillare della democrazia: un tempo si parlava di democrazia progressiva, di conquista delle casematte dello Stato. Invece a settembre ci toccherà votare sull’ennesima ipotesi di restringimento del perimetro democratico. Se al referendum vincerà il sì brinderanno solo le oligarchie finanziarie: meno deputati ci saranno, meno costerà fare lobbying.
Sostenuta dai potentati mediatici e finanziari, la propaganda anti-casta di questi anni è stata dunque solo una delle forme fenomeniche della reazione anti-statuale. In essa non c’è nessuna rivoluzione giacobina, nessun furore rosso. Se non si ferma questa bieca vandea liberista, al prossimo giro qualcuno magari proporrà di trasformare l’aula sorda e grigia in un bivacco di manipoli. E ci mostrerà fiero gli spicci risparmiati, mentre distrugge quel che resta dello stato sociale.
Fonte
Sostenuta dai potentati mediatici e finanziari, la propaganda anti-casta di questi anni è stata soltanto una delle forme fenomeniche della reazione anti-statuale. In essa non c’è nessuna rivoluzione giacobina, nessun furore rosso. Solo bieca vandea liberista.
di Emiliano Brancaccio
Meno di un euro, nemmeno un caffè all’anno. È questo il risparmio che ogni cittadino italiano potrà attendersi dal taglio dei parlamentari che sarà oggetto di referendum confermativo il 20 e 21 settembre prossimi.
Iniziata una dozzina di anni fa come puritana ribellione verso un ceto politico ingordo di privilegi, la lotta alla casta giunge così al suo infimo epilogo. In origine la crociata poteva rivendicare risparmi un po’ più consistenti, come ad esempio la stretta di 700 milioni sulle famigerate auto blu. Oggi deve accontentarsi di un più magro bottino: dall’annunciato taglio dei parlamentari verranno meno di 60 milioni. Ma a ben guardare, nemmeno ai suoi esordi la guerra alla casta ha avuto la benché minima rilevanza macroeconomica. I tagli più rilevanti ai privilegi del ceto politico, effettuati sotto l’austerico governo Monti, non hanno mai raggiunto il millesimo della spesa pubblica nazionale. Una roboante propaganda su risibili voci di contabilità, insomma.
Si potrebbe obiettare che per soddisfare la brama popolare di vendetta contro un ceto politico reputato inetto e distante, la rilevanza macroeconomica dei tagli sia in fondo secondaria. Ma allora, perché questa risibile insistenza sul risparmio per le casse pubbliche? Il motivo è presto detto.
La verità è che le strette sulle poltrone, sui viaggi e sulle buvettes dell’odiata casta politica sono state un alibi ingegnoso per far passare ben altri tagli ai fondi pubblici, che hanno provocato danni incalcolabili alle infrastrutture, alla ricerca, all’istruzione e anche alla sanità pubblica, come ormai purtroppo sappiamo. Sapere dei tagli al ristorante di Montecitorio ha reso più tollerabile il clima generale di austerity, ridurre l’odiato parlamentare alla questua ha reso più accettabile la dura quaresima per tutti.
Le rivalse anti-casta vanno quindi valutate per quel che sono: un oppio del popolo per intorpidire le menti e giustificare il più reazionario ordine di politica economica che si sia imposto nella storia repubblicana. Oggi è il turno dei pentastellati, peraltro appoggiati da quasi tutto l’arco parlamentare. Ma dai democratici alle destre forcaiole, appoggiate dalla grande stampa tutte le forze di governo hanno abusato in questi anni del venefico oppiaceo. E gli effetti sono sotto i nostri occhi. I politici si ritroveranno pure con meno scranni e meno rimborsi, ma è solo un diversivo: quel che conta è che la politica generale di austerity ha allargato la forbice macroeconomica tra ricchi e poveri, in particolare tra percettori di profitti e rendite da un lato e lavoratori salariati dall’altro. Alla fine, la vendetta sociale ha operato in direzione esattamente contraria a quel che si crede.
Eppure a quanto pare non ci siamo ancora svegliati dal torpore. La drogante propaganda anti-casta continua a circolare e c’è il rischio che faccia i suoi danni anche al prossimo appuntamento referendario. Con un risvolto particolarmente ridicolo, questa volta. Andremo infatti a votare nel mezzo di una colossale crisi economica, che sta determinando la più rapida caduta della produzione e del reddito che si sia registrata nella storia del capitalismo. Per arginare la catastrofe i governi hanno dovuto per forza dare sfogo alla spesa pubblica e al deficit di bilancio. Nella sola Italia il disavanzo statale aumenterà di un centinaio di miliardi rispetto all’anno scorso. E non si immagini che le cose torneranno rapidamente al loro posto. Persino l’ex presidente della BCE ha ammesso che con l’esplosione dei debiti pubblici dovremo convivere e che per lungo tempo toccherà alle banche centrali governare i mercati per garantire la sostenibilità dei bilanci. In questo gigantesco rivolgimento della politica economica, la scena dei tagliatori di scranni parlamentari che si rallegrano per un risparmio di un euro scarso all’anno per ogni cittadino risulta semplicemente patetica.
Per giunta, se la riforma costituzionale sarà approvata, ci ritroveremo con un solo parlamentare ogni 151 mila cittadini, il più basso livello di rappresentanza politica in rapporto alla popolazione nell’Unione europea. Sappiamo bene che la crisi della rappresentanza si può risolvere solo con una espansione e un radicamento capillare della democrazia: un tempo si parlava di democrazia progressiva, di conquista delle casematte dello Stato. Invece a settembre ci toccherà votare sull’ennesima ipotesi di restringimento del perimetro democratico. Se al referendum vincerà il sì brinderanno solo le oligarchie finanziarie: meno deputati ci saranno, meno costerà fare lobbying.
Sostenuta dai potentati mediatici e finanziari, la propaganda anti-casta di questi anni è stata dunque solo una delle forme fenomeniche della reazione anti-statuale. In essa non c’è nessuna rivoluzione giacobina, nessun furore rosso. Se non si ferma questa bieca vandea liberista, al prossimo giro qualcuno magari proporrà di trasformare l’aula sorda e grigia in un bivacco di manipoli. E ci mostrerà fiero gli spicci risparmiati, mentre distrugge quel che resta dello stato sociale.
Fonte
Dal Tav alla pedemontana lombarda, la lotta contro le grandi opere inutili
Domenica 21 giugno in Valsusa le ruspe sono tornate al lavoro e dal giorno seguente il movimento no TAV è in presidio permanente per fermare la ripresa dei lavori e l’allargamento del cantiere di quella che è la grande opera per antonomasia.
Contestata da una popolazione in lotta da oltre vent’anni contro un modello di sviluppo caratterizzato dal conseguimento del profitto dei pochi soliti, noti a costo della devastazione di interi territori, con uno spreco di denaro pubblico che potrebbe essere ben diversamente utilizzato.
Il tutto nonostante l’ormai dimostrata inutilità dell’opera rispetto agli scopi dichiarati, e nonostante le bocciature che arrivano anche dalla Corte dei conti europea.
Ma il partito trasversale del PIL non sta mai con le mani in mano. È il partito a cui hanno da sempre aderito Confindustria, il PD, la Lega, CL, onnipresente in particolare nella gestione degli affari lombardi, e a cui è iscritto a buon diritto ormai anche il Movimento 5 Stelle, come dimostra la disinvolta retromarcia governista proprio sulla TAV Torino-Lione.
Prima ancora che il comitato di esperti guidato da Colao rendesse pubblico il ‘piano per il rilancio del paese’ che ha, guarda caso, tra i punti fondanti la realizzazione di infrastrutture strategiche e l’approvazione di un nuovo codice degli appalti “liberi tutti”, la Giunta lombarda – nel mese di aprile, in piena epidemia da Covid-19 – trovava il tempo per infilare tra le delibere con cui ha gestito catastroficamente la crisi anche la ricapitalizzazione per 150 milioni di euro, diluiti in 5 anni, della società Milano – Serravalle.
Una società controllata dalla Regione stessa, affinché possa ‘girarli’ a sua volta ad un’altra delle proprie controllate, la Società Autostrada Pedemontana Lombarda.
Così, proprio nel momento più critico dell’epidemia da Covid-19 che ha visto in Italia, e non solo, il triste primato della Lombardia per numero di morti e di contagiati e per l’assoluta incapacità della sua classe dirigente, Confindustria non solo trovava terreno fertile nell’evitare il più possibile il fermo delle attività produttive, ma riusciva ad incassare un successo anche in proiezione futura.
La ricapitalizzazione dovrebbe infatti servire a far ripartire l’autostrada che nelle intenzioni collegherebbe gli aeroporti di Malpensa e Orio al Serio, mettendo in comunicazione, nel nord della Lombardia, la provincia di Varese con quella di Bergamo attraverso un percorso di circa 90 km, di cui solo 22 ultimati nel 2015 e oggi in funzione, fino a Lentate sul Seveso.
Da allora i lavori per l’autostrada, già inserita nel dossier infrastrutture di Expo 2015, e ora nel dossier sulle Olimpiadi Invernali del 2026 sono rimasti fermi.
Il progetto dal costo complessivo preventivato (fonte L’Espresso) vicino ai 5 miliardi di euro (di cui 1,2 miliardi già spesi), con i suoi circa 57 milioni di euro a Km, si inserisce al primo posto tra le autostrade più costose d’Italia.
Nel tratto realizzato il traffico, già nel 2017, risultava essere la metà di quello previsto, a causa del pedaggio a km percorso più caro d’Italia, ancora più della BreBeMi disertata dagli utenti per lo stesso motivo. E così i finanziatori privati sono svaniti nel nulla, lasciando il costo interamente sulle spalle della collettività.
Un altro successo del project financing, insomma, al pari della metro M4 milanese, dove il Comune ha dovuto mettere le toppe (leggesi: i milioni di euro) per rimediare agli errori di progettazione dei privati.
Il tratto non ancora realizzato della Pedemontana dovrebbe sorgere in un territorio caratterizzato da elevata densità abitativa, con presenza di importanti vincoli ambientali e con seri rischi per la salute degli abitanti.
Per la realizzazione dell’opera, infatti, andrebbero fatti scavi nelle zone dove sono seppelliti residui di diossina fuoriusciti dal disastro del 10 Luglio 1976 nell’azienda ICMESA di Meda.
A tal proposito i sindaci di Seveso, Barlassina, Cesano Maderno, Bovisio Masciago e Desio, territori che verranno attraversati proprio dalla tratta B2 dell’autostrada ancora non realizzata – di diversi orientamenti politici ma uniti nella difesa del diritto alla salute dei loro concittadini che, detto per inciso, sono forse non a caso quelli che dovrebbero rieleggerli – hanno ottenuto nel settembre del 2019 da un lato una modifica nella metodologia del campionamento del terreno da bonificare e dall’altro che la bonifica venga effettuata oltre i 20 centimetri di scavo nelle maglie, qualora l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale riscontrasse nell’aliquota del campione da essa acquisita concentrazioni elevate di contaminante.
Ma la bonifica ad oggi non risulta iniziata. La tratta B2 da costruire avrà inoltre un forte impatto sull’inquinamento ambientale, in una zona già nota per essere tra le più inquinate di Italia e dove l’elevata concentrazione di polveri sottili ha favorito la diffusione del covid-19, e comporta uno spropositato consumo di suolo.
Per evidenziare tutte queste criticità, ma ancor di più per chiedere che i fondi vengano destinati non a questo tipo di opere, non al servizio del modello di sviluppo che finora è stato praticato, ma alla sanità, all’istruzione, al trasporto locale, partendo da quelli che sono i reali bisogni dei cittadini troppo a lungo trascurati, il Coordinamento No Pedemontana ha organizzato domenica 21 giugno, davanti all’ospedale di Desio, un partecipato presidio, a cui ha preso parte anche Potere al Popolo Milano, che ha poi raggiunto anche Cesano.
Un primo passo per ripartire e cercare di dare nuova linfa a chi intende opporsi al modello delle grandi opere.
Il percorso da fare non sarà semplice e quale sarà il livello dello scontro risulta chiaro già dalle dichiarazioni del governatore Fontana, il 24 giugno, nel corso degli Stati Generali per il patto per lo sviluppo organizzati dalla Regione.
Le entrate correnti nel 2020 si sono ridotte già di 320 milioni di euro per i mancati introiti derivanti dal Bollo auto, dall’Irap e dall’addizionale IRPEF e, se non ci sarà una compartecipazione dello Stato, saranno necessari tagli alle politiche sociali, all’istruzione, alla cultura e alla formazione.
Fonte
Contestata da una popolazione in lotta da oltre vent’anni contro un modello di sviluppo caratterizzato dal conseguimento del profitto dei pochi soliti, noti a costo della devastazione di interi territori, con uno spreco di denaro pubblico che potrebbe essere ben diversamente utilizzato.
Il tutto nonostante l’ormai dimostrata inutilità dell’opera rispetto agli scopi dichiarati, e nonostante le bocciature che arrivano anche dalla Corte dei conti europea.
Ma il partito trasversale del PIL non sta mai con le mani in mano. È il partito a cui hanno da sempre aderito Confindustria, il PD, la Lega, CL, onnipresente in particolare nella gestione degli affari lombardi, e a cui è iscritto a buon diritto ormai anche il Movimento 5 Stelle, come dimostra la disinvolta retromarcia governista proprio sulla TAV Torino-Lione.
Prima ancora che il comitato di esperti guidato da Colao rendesse pubblico il ‘piano per il rilancio del paese’ che ha, guarda caso, tra i punti fondanti la realizzazione di infrastrutture strategiche e l’approvazione di un nuovo codice degli appalti “liberi tutti”, la Giunta lombarda – nel mese di aprile, in piena epidemia da Covid-19 – trovava il tempo per infilare tra le delibere con cui ha gestito catastroficamente la crisi anche la ricapitalizzazione per 150 milioni di euro, diluiti in 5 anni, della società Milano – Serravalle.
Una società controllata dalla Regione stessa, affinché possa ‘girarli’ a sua volta ad un’altra delle proprie controllate, la Società Autostrada Pedemontana Lombarda.
Così, proprio nel momento più critico dell’epidemia da Covid-19 che ha visto in Italia, e non solo, il triste primato della Lombardia per numero di morti e di contagiati e per l’assoluta incapacità della sua classe dirigente, Confindustria non solo trovava terreno fertile nell’evitare il più possibile il fermo delle attività produttive, ma riusciva ad incassare un successo anche in proiezione futura.
La ricapitalizzazione dovrebbe infatti servire a far ripartire l’autostrada che nelle intenzioni collegherebbe gli aeroporti di Malpensa e Orio al Serio, mettendo in comunicazione, nel nord della Lombardia, la provincia di Varese con quella di Bergamo attraverso un percorso di circa 90 km, di cui solo 22 ultimati nel 2015 e oggi in funzione, fino a Lentate sul Seveso.
Da allora i lavori per l’autostrada, già inserita nel dossier infrastrutture di Expo 2015, e ora nel dossier sulle Olimpiadi Invernali del 2026 sono rimasti fermi.
Il progetto dal costo complessivo preventivato (fonte L’Espresso) vicino ai 5 miliardi di euro (di cui 1,2 miliardi già spesi), con i suoi circa 57 milioni di euro a Km, si inserisce al primo posto tra le autostrade più costose d’Italia.
Nel tratto realizzato il traffico, già nel 2017, risultava essere la metà di quello previsto, a causa del pedaggio a km percorso più caro d’Italia, ancora più della BreBeMi disertata dagli utenti per lo stesso motivo. E così i finanziatori privati sono svaniti nel nulla, lasciando il costo interamente sulle spalle della collettività.
Un altro successo del project financing, insomma, al pari della metro M4 milanese, dove il Comune ha dovuto mettere le toppe (leggesi: i milioni di euro) per rimediare agli errori di progettazione dei privati.
Il tratto non ancora realizzato della Pedemontana dovrebbe sorgere in un territorio caratterizzato da elevata densità abitativa, con presenza di importanti vincoli ambientali e con seri rischi per la salute degli abitanti.
Per la realizzazione dell’opera, infatti, andrebbero fatti scavi nelle zone dove sono seppelliti residui di diossina fuoriusciti dal disastro del 10 Luglio 1976 nell’azienda ICMESA di Meda.
A tal proposito i sindaci di Seveso, Barlassina, Cesano Maderno, Bovisio Masciago e Desio, territori che verranno attraversati proprio dalla tratta B2 dell’autostrada ancora non realizzata – di diversi orientamenti politici ma uniti nella difesa del diritto alla salute dei loro concittadini che, detto per inciso, sono forse non a caso quelli che dovrebbero rieleggerli – hanno ottenuto nel settembre del 2019 da un lato una modifica nella metodologia del campionamento del terreno da bonificare e dall’altro che la bonifica venga effettuata oltre i 20 centimetri di scavo nelle maglie, qualora l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale riscontrasse nell’aliquota del campione da essa acquisita concentrazioni elevate di contaminante.
Ma la bonifica ad oggi non risulta iniziata. La tratta B2 da costruire avrà inoltre un forte impatto sull’inquinamento ambientale, in una zona già nota per essere tra le più inquinate di Italia e dove l’elevata concentrazione di polveri sottili ha favorito la diffusione del covid-19, e comporta uno spropositato consumo di suolo.
Per evidenziare tutte queste criticità, ma ancor di più per chiedere che i fondi vengano destinati non a questo tipo di opere, non al servizio del modello di sviluppo che finora è stato praticato, ma alla sanità, all’istruzione, al trasporto locale, partendo da quelli che sono i reali bisogni dei cittadini troppo a lungo trascurati, il Coordinamento No Pedemontana ha organizzato domenica 21 giugno, davanti all’ospedale di Desio, un partecipato presidio, a cui ha preso parte anche Potere al Popolo Milano, che ha poi raggiunto anche Cesano.
Un primo passo per ripartire e cercare di dare nuova linfa a chi intende opporsi al modello delle grandi opere.
Il percorso da fare non sarà semplice e quale sarà il livello dello scontro risulta chiaro già dalle dichiarazioni del governatore Fontana, il 24 giugno, nel corso degli Stati Generali per il patto per lo sviluppo organizzati dalla Regione.
Le entrate correnti nel 2020 si sono ridotte già di 320 milioni di euro per i mancati introiti derivanti dal Bollo auto, dall’Irap e dall’addizionale IRPEF e, se non ci sarà una compartecipazione dello Stato, saranno necessari tagli alle politiche sociali, all’istruzione, alla cultura e alla formazione.
Fonte
Il “presidente” del Kosovo accusato di crimini di guerra. Uno spettro per le cancellerie occidentali
Il presidente del Kosovo Hashim Thaci è stato accusato di crimini di guerra e contro l’umanità dalla Corte speciale dell’Aja (la Kosovo Special Chambers).
Thaci, con altri nove comandanti dell’Uck, tra cui Kadri Veseli, ex speaker del Parlamento e leader del partito democratico (Pdk), sono accusati di oltre 100 omicidi, soprattutto di cittadini serbi e rom. L’inchiesta su questi crimini era cominciata sei anni fa.
Le accuse della Corte formulate in aprile e non ancora formalizzate, sono state rese pubbliche nei giorni scorsi dallo Special Prosecutor’s Office (Spo).
Tra le vittime ci sarebbero serbi e rom, ma anche oppositori politici albanesi. I dirigenti del Kosovo e dell’Uck sono inoltre accusati di torture, persecuzioni e sparizioni forzate.
Un giudice del tribunale incaricato di indagare sui crimini commessi dall’Esercito di Liberazione del Kosovo (Uck) durante la guerra avvenuta tra il gennaio 1998 e il dicembre 1999 (con i bombardamenti e le menzogne della Nato come fattore decisivo dei suoi esiti) dovrà decidere entro i prossimi sei mesi se confermare le accuse, procedendo con un rinvio a giudizio e l’apertura di un processo.
Secondo l’Ufficio del Procuratore, Thaci e Veseli avrebbero ostacolato il lavoro di indagine della Corte Speciale. “Con queste azioni – si legge nel comunicato reso noto dalla Corte – Thaci e Veseli hanno messo i loro interessi personali davanti alle vittime dei loro crimini, dello stato di diritto e di tutto il popolo del Kosovo”.
Non è la prima volta che il presidente del Kosovo viene accusato di crimini di guerra e altri reati. Sospettato di aver gestito un traffico d’armi, droga e perfino di organi umani attraverso l’Europa dell’Est, Thaci finì nel mirino del Consiglio d’Europa nel 2010 e prima ancora in quello dell’ex procuratrice capo del Tribunale penale internazionale per l’ex Jugoslavia (TPIJ), Carla Dal Ponte. Ma all’epoca le accuse contro di lui non ebbero alcun seguito giudiziario. Al contrario dell’accanimento della stessa Corte contro i dirigenti serbi, tra cui Slobodan Milosevic, condannato e “morto” nel carcere dell’Aja nel 2006.
La notizia dell’incriminazione di Thaci ha provocato un terremoto politico nei Balcani ma non solo. Thaci, infatti era atteso a Washington dal presidente Donald Trump per un delicato incontro con il presidente della Serbia Vucic, nell’ambito del negoziato di pace che l’amministrazione Usa avrebbe voluto come fiore all’occhiello.
Thaci, già in viaggio per la capitale degli Stati Uniti, è dovuto rientrare precipitosamente a Pristina e finora non ha commentato le accuse.
Il Kosovo si è dichiarato indipendente ed è stato riconosciuto come tale nel 2008 da molti Stati (tra cui l’Italia), ma paesi come Spagna, Serbia e Russia non lo hanno riconosciuto. Per molti osservatori il Kosovo è di fatto un narco-stato piazzato in Europa. Per altri è solo il territorio che si estende intorno alla base militare statunitense di Camp Bondsteel sorta subito dopo l’aggressione Nato alla Serbia nel 1999, per altri ancora è una sorta di califfato islamico nei Balcani visto che nei suoi aeroporti transitano molti dei mercenari e dei miliziani dell’Isis diretti o rientranti da Siria e Iraq.
Il Kosovo è sicuramente il risultato della deliberata aggressione della Nato alla ex Jugoslavia e della disgregazione di quel paese. Di recente un film su questa vicenda era diventato oggetto di polemica internazionale. Uno scheletro in più negli armadi delle cancellerie europee, incluse quelle dell’Italia.
Fonte
I Rolling Stones contro Trump: “Non usare la nostra musica”
I Rolling Stones hanno intimato al presidente statunitense Trump, di non usare più le loro canzoni nei suoi comizi o per la sua campagna elettorale.
Nel comizio elettorale di Trump a Tulsa la scorsa settimana, il suo staff ha utilizzato come musica la canzone You Can’t Always Get What You Want.
Lo stesso brano venne utilizzato anche nella prima campagna di Trump per le elezioni americane del 2016. Già allora la band prese le distanze “I Rolling Stones non appoggiano Donald Trump”, twittarono gli esponenti della band. Ma il braccio di ferro ora rischia di diventare una battaglia legale.
Il team di avvocati del gruppo ha infatti reso noto che sta lavorando con l’organizzazione per i diritti dello spettacolo, l’Imc, per fermare l’uso non autorizzato della loro musica. “Ulteriori passi per impedire a Trump l’uso del materiale dei Rolling Stones in future campagne presidenziali sono diventati necessari dopo che le precedenti richieste e direttive erano state ignorate”.
Secondo quanto riferito dalla Bbc, l’Imc ha notificato alla campagna di Trump per conto degli Stones che l’uso delle loro canzoni senza autorizzazione costituirà una violazione dell’accordo di licenza e sarà soggetto ad azioni legali.
Il fronte dei musicisti che stanno negando le loro canzoni per la campagna elettorale di Trump è diventato piuttosto ampio. Qualche settimana fa sono stati i R.E.M annunciando di voler impedire legalmente al presidente di usare la loro musica. Era avvenuto anche per un comizio a Minneapolis, quando lo staff di Trump fece precedere il suo discorso da “Purple Rain” intervennero gli eredi di Prince sottolineando che non avrà mai il permesso di usare le sue canzoni.
A questi nomi si sono aggiunti via via una lunga lista di artisti e gruppi musicali che hanno diffidato Trump dall’utilizzare le loro canzoni nei suoi comizi: da Neil Young, a Rihanna, Elton John, Earth Wind and Fire, Adele, Guns N Roses, Pharrell Williams, Queen, Aerosmith.
Fonte
Nel comizio elettorale di Trump a Tulsa la scorsa settimana, il suo staff ha utilizzato come musica la canzone You Can’t Always Get What You Want.
Lo stesso brano venne utilizzato anche nella prima campagna di Trump per le elezioni americane del 2016. Già allora la band prese le distanze “I Rolling Stones non appoggiano Donald Trump”, twittarono gli esponenti della band. Ma il braccio di ferro ora rischia di diventare una battaglia legale.
Il team di avvocati del gruppo ha infatti reso noto che sta lavorando con l’organizzazione per i diritti dello spettacolo, l’Imc, per fermare l’uso non autorizzato della loro musica. “Ulteriori passi per impedire a Trump l’uso del materiale dei Rolling Stones in future campagne presidenziali sono diventati necessari dopo che le precedenti richieste e direttive erano state ignorate”.
Secondo quanto riferito dalla Bbc, l’Imc ha notificato alla campagna di Trump per conto degli Stones che l’uso delle loro canzoni senza autorizzazione costituirà una violazione dell’accordo di licenza e sarà soggetto ad azioni legali.
Il fronte dei musicisti che stanno negando le loro canzoni per la campagna elettorale di Trump è diventato piuttosto ampio. Qualche settimana fa sono stati i R.E.M annunciando di voler impedire legalmente al presidente di usare la loro musica. Era avvenuto anche per un comizio a Minneapolis, quando lo staff di Trump fece precedere il suo discorso da “Purple Rain” intervennero gli eredi di Prince sottolineando che non avrà mai il permesso di usare le sue canzoni.
A questi nomi si sono aggiunti via via una lunga lista di artisti e gruppi musicali che hanno diffidato Trump dall’utilizzare le loro canzoni nei suoi comizi: da Neil Young, a Rihanna, Elton John, Earth Wind and Fire, Adele, Guns N Roses, Pharrell Williams, Queen, Aerosmith.
Fonte
Mattarella a Bergamo, ma i familiari delle vittime restano a casa
C’è un fatto importante, che è stato taciuto praticamente da tutta la stampa, nella cronaca della doverosa visita del Presidente Mattarella a Bergamo. Si tratta dell’assenza dalla commemorazione dei familiari delle vittime della pandemia, che non sono stati invitati, nemmeno attraverso una rappresentanza.
Eppure, il luogo in cui si è tenuta la cerimonia, il cimitero di Bergamo, uno spazio grande e aperto, avrebbe certamente consentito la partecipazione almeno di una rappresentanza dei familiari delle vittime. Si consideri tra l’altro che il posto per i ben 243 sindaci della provincia di è trovato.
Delle oltre 6000 famiglie – cifra ufficiale che si teme debba essere realisticamente raddoppiata – che hanno avuto dei morti nella provincia di Bergamo, era presente solo Luca Fusco, portavoce del comitato “Verità e Giustizia”, il quale ha chiarito che avrebbe partecipato per un sentimento istituzionale, ma che riteneva inopportuna la presenza di Attilio Fontana, presidente della Lombardia, responsabile delle scelte politiche e degli errori tecnici che hanno provocato oltre 16.000 decessi nella regione.
Quanto a Mattarella, Fusco ha dichiarato che, pur rispettandone gli impegni istituzionali, avrebbe preferito che il Presidente non si fosse limitato a una “toccata e fuga” a Bergamo, ma avesse scelto di fare una visita più approfondita, intima e raccolta.
Tra l’altro, l’avvocato Consuelo Locati, legale del comitato “Noi denunceremo” e figlia di una delle vittime, aveva esplicitamente richiesto che fosse previsto un incontro tra il Presidente e le famiglie che hanno perso i loro cari.
La cerimonia si è svolta così in un clima decisamente istituzionale, compresa la scopertura di una lapide su cui è incisa una preghiera-poesia del fondatore di un’associazione di volontariato cattolico di Bergamo.
Siamo purtroppo abituati a questa costante prepotenza istituzional-cattolica per cui esiste la presunzione che tutti gli italiani siano devoti alla Chiesa di Roma e gradiscano essere ricordati e commemorare i propri cari con preghiere.
In seguito, dopo l’esecuzione della Messa da Requiem di Donizetti, il Presidente ha pronunciato un breve discorso in cui ha accennato anche a “riflettere, seriamente, con rigorosa precisione, su ciò che non ha funzionato, sulle carenze di sistema, sugli errori da evitare di ripetere“. Un riferimento davvero troppo vago e disarmante rispetto a quanto successo in Lombardia.
Si è detto di Fontana che è stata una presenza davvero inopportuna sino all’indecenza, anche a fronte del fatto che il Presidente lombardo continua a ripetere che in regione tutto è stato fatto bene e che non ha nulla da rimproverarsi.
Ancor più indecenti le dichiarazioni di qualche giorno fa dell’assessore Gallera. Costui è giunto a rivolgere un ringraziamento alle cliniche private che, nell’emergenza, hanno ricoverato nelle loro “lussuose camere” dei pazienti “ordinari”. Una dichiarazione disgustosamente classista, ma soprattutto falsa, poiché il contributo dei privati è stato enormemente secondario rispetto a quanto fatto dalle strutture pubbliche, che hanno dovuto reggere la quasi totalità dell’impatto dell’epidemia.
Non va tra l’altro dimenticato che le strutture private, a parte alcuni posti di terapia intensiva, non sono adatte a fronteggiare un’epidemia, perché progettate per offrire solo prestazioni lucrative.
Tutte queste dichiarazioni fanno ben intendere che purtroppo la giunta regionale lombarda non ha nessuna intenzione di cambiare linea rispetto a quella, fallimentare, seguita negli ultimi decenni, che è la causa ultima della strage avvenuta in Lombardia.
Una regione quest’ultima, in cui ancora oggi, pure in una fase meno acuta della pandemia, si verifica circa la metà dei contagi di tutta Italia.
Siamo in un momento in cui la pandemia sembra, nel nostro paese, concedere un momento di relativa tregua. Ciò significa che sono importanti i pochi mesi che precedono l’autunno durante i quali – sottolineano gli esperti più avveduti – si deve approfittare del momento per cercare di predisporre le misure necessarie per un’eventuale, probabile recrudescenza autunnale.
In Lombardia nulla si sa di cosa stia facendo l’assessorato al welfare, salvo scappellarsi di fronte alle cliniche private e progettare, nel caso di Fontana, una nuova passerella mediatica a fianco del Papa.
Non si dica poi, in autunno, nel malaugurato caso di un’altra strage, che si è fatto tutto il possibile. L’impresentabile giunta Fontana deve andarsene, non può più tenere in ostaggio la salute di dieci milioni di cittadini.
Fonte
“Mes o morte”, grida l’establishment
È partita l’offensiva finale per imporre al governo di richiedere l’accesso alle linee di credito del famigerato Mes. Il panorama dei media, in proposito, è impressionante. Il Corriere della Sera, in particolare, da giorni martella senza tregua, fino a mobilitare un suo vicedirettore, Federico Fubini, per “spiegare cos’è il Mes” e ovviamente concluderne che è da scemi non richiederlo. Con tanto di “simulazioni” sui fantastici benefici che si avrebbero...
Ultimo è arrivato il “pezzo grosso”, ossia il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, il che pone un’ipoteca pesante sull’esecutivo e sul suo presidente, il mediatore estremo Giuseppe Conte. Non per far cadere un governo che più esitante non si può, ma per condizionarne definitivamente le scelte fondamentali.
La cosa divertente – in realtà fa incazzare per la sfrontatezza – è che sul piano politico Zingaretti recita la parte del “riformista progressista”, mentre lo strumento di cui perora l’adozione è nato per imporre un “riformismo” di segno diametralmente opposto.
Fa impressione, in effetti, veder sventolare lo straccio con su scritto “quasi 40 miliardi per la spesa sanitaria” dal capo temporaneo di un partito che – scambiandosi a volte la poltrona con leghisti e berlusconiani – ha contribuito a ridurre la spesa per la sanità... di 37 miliardi in dieci anni.
Alcuni argomenti addotti da Zingaretti, infatti, sembrano una presa d’atto di aver sbagliato tutto nel recente passato (lui personalmente è stato “commissario alla sanità” della regione Lazio, decidendo la chiusura di numerosi ospedali e il taglio di innumerevoli servizi).
Per esempio: “questi mesi ci hanno mostrato quanto sia fondamentale investire nei sistemi sanitari e nelle scienze della vita per poter garantire il diritto a cure di qualità. È evidente la necessità di promuovere il potenziamento e l’ammodernamento del nostro sistema sanitario: rafforzare gli ospedali, puntare sulle tecnologie digitali, aumentare la presenza sui territori, l’assistenza domiciliare, la prevenzione, sostenere la ricerca e costruire un nuovo sistema di presa in carico delle persone, a cominciare dagli anziani. Il sistema sanitario ha risposto ed è stato capace di uno sforzo immane”.
Ma l’autocritica non arriva, neanche quando auspica un “salto nel futuro per costruire un nuovo modello: l’attuale sistema di cura e presa in carico fondato su tre politiche distinte che spesso non comunicano – sanità, sociale e terzo settore – ha mostrato tutti i suoi limiti, non va più bene, è inadeguato. Rinascita è anche questo: avere una visione nuova, fondata su un modello di integrazione delle politiche sanitarie e sociosanitarie da realizzare con idee e investimenti”.
Insomma: sei stato protagonista nell’applicazione di un “modello sbagliato”, ti presenti come quello che vuole “un salto nel futuro” e poi chiedi che si chiami in causa un “meccanismo” nato esattamente per far trionfare di quel “modello sbagliato” nella sanità e ovunque?
Ovvio che l’immagine di quel meccanismo vara passata a un trattamento di photoshop radicale: “Il Mes è stato criticato e combattuto da molti, ma ora è uno strumento finanziario totalmente diverso da quello del passato”.
Credibilità zero, ma potenza di fuoco mediatica assordante.
Fubini si prende il poco onorevole incarico di spiegare “cos’è il Mes” per farne il paradiso in terra.
Parte col dizionario in mano, come fanno i bravi giornalisti: “il Meccanismo europeo di stabilità è un ente intergovernativo la cui base legale è un trattato fra i Paesi dell’area euro, che ne sono azionisti in quote più o meno pari al loro peso economico: ed esiste legalmente dal 27 settembre del 2012.”
Sorvoliamo sul fatto che i soldi del Mes non sono creati da nulla, ma costituiscono “quote azionarie” messe dai singoli Stati (17% nel caso dell’Italia, circa 70 miliardi). Seguiamo la sua esposizione sulle “nuove caratteristiche” di quel fondo che dovrebbero cancellarne l’immagine terroristica (“Forse perché fra il 2010 e il 2012 il Fesf e il Mes hanno concesso circa 98 miliardi di prestiti al Portogallo, oltre 200 miliardi alla Grecia, 76 miliardi all’Irlanda, 41 miliardi alla Spagna: e in quel caso ci fu una «verifica esterna» dei programmi di risanamento dei Paesi da parte delle autorità europee". Ossia il “Memorandum” che ha messo in ginocchio soprattutto la Grecia, riducendola in miseria).
È certamente vero che le condizioni finanziarie sono migliori di quelle che si incontrano generalmente sui mercati (“Il tasso d’interesse sarebbe negativo nel caso di una scadenza a sette anni; e praticamente zero – 0,08% – nel caso di una scadenza a dieci anni. Un prestito a dieci anni del Mes, ai rendimenti attuali dei titoli di Stato, farebbe dunque risparmiare all’Italia 4,8 miliardi rispetto a un prestito che l’Italia dovesse cercare sul mercato collocando titoli di Stato”).
Così come è vero che quei soldi sarebbero erogati “quasi subito” (nell’arco di un anno) e alla condizione che vengano spesi solo per la sanità in generale (“spese dirette e indirette”, facendo sognare possibili “deroghe” in virtù di quell’”indirette”).
Ed è vero persino che l’analisi relativa alla sostenibilità del debito – con l’aggiunta del Mes – è già stata fatta, ha avuto “esisto positivo”.
L’unica cosa falsa è quella decisiva: che non ci sarebbero problemi derivanti dall’intreccio, sul breve e medio periodo, tra condizioni di funzionamento del Mes e altri trattati europei. Su questo Fubini è particolarmente netto, anche se non porta altra prova che la sua parola: “Non c’è niente nei Trattati dell’Unione europea che obblighi il Mes a fare o non fare qualunque scelta. Il Trattato del Mes prevede sì «condizionalità» sui prestiti. Ma, appunto, essa in questo caso prevede solo che il denaro sia investito in spesa sociale. Nient’altro.”
Messa così, chi rifiuta il Mes è un cretino che agita problemi “idologici”. Tanto più che neppure l’altra usuale obiezione (“nessun Paese sta chiedendo i prestiti del Mes”) viene dallo stesso Fubini smontata – molto fiaccamente, sul piano logico – ricordando che “Cipro lo sta facendo”.
Sappiamo per esperienza che la conoscenza dei trattati europei è inesistente nell’opinione pubblica (come nei giornalisti che ne parlano quasi sempre), anche perché – come in tutti i “contratti commerciali” vengono scritti in una lingua per iniziati.
Proprio per questo abbiamo pubblicato numerosi interventi in materia, tentando di spiegare anche ai profani alcuni dei meccanismi più pericolosi.
A tagliare la testa al toro (e anche al disperato tentativo di Fubini-Zingaretti) era del resto arrivata una lettera di Klaus Regling – il Direttore del Mes in persona – alla fine di aprile. Un passaggio chiarissimo, quasi in linguaggio corrente:“La Commissione Europea chiarirà monitoraggio e sorveglianza in accordo con le regole del Two Pack” (un trattato europeo relativamente recente che regola ulteriormente le modalità di stesura della “legge di stabilità” di ogni Paese dell’Unione).
Non è una cattiveria, ma una delle regole fondamentali del Mes, il cui Trattato istitutivo prevede che tutti i Paesi richiedenti l’accesso al prestito siano sottoposti a “sorveglianza rafforzata” da parte della Commissione e della Bce. Manca solo il Fmi e sarebbe riapparso il fantasma della Troika...
La “sorveglianza rafforzata” significa un più stringente controllo sulla spesa pubblica degli Stati che, in determinate condizioni, può tranquillamente portare a un “doloroso programma di aggiustamento macroeconomico”.
Siamo sicuri che Fubini ha letto quella lettera con la stessa nostra attenzione. E che capisca anche meglio di noi i meccanismi interni all’Unione Europea e la stessa logica dei trattati.
Solo che noi contrastiamo quei meccanismi e quella logica, e dunque possiamo permetterci di dire la verità. Chi li difende, invece, è costretto alla recita opposta.
Il giornale inglese The Guardian ha pubblicato i risultati di un sondaggio europeo piuttosto interessante su come i cittadini del Vecchio Continente vedono l’operato dell’Unione Europea di fronte alla pandemia.
“I numeri che percepivano la performance dell’Ue come scarsa (più della metà in Francia) sono superati da chi ha detto che il blocco era “irrilevante”, perché l’impennata del numero di morti ha lasciato alcune comunità in difficoltà per seppellire i loro morti. Le grandi maggioranze di tutte le nazioni intervistate – nove, con due terzi dei cittadini europei – ritengono che il loro paese sia stato lasciato solo o che non sappiano chi sia il loro alleato più utile.”
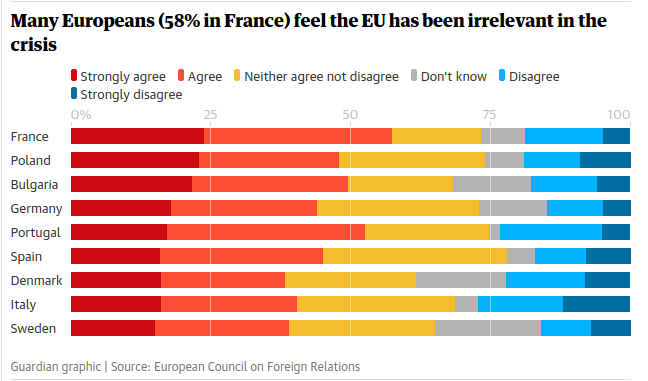
Addirittura “In Italia, uno dei Paesi colpiti per primo dal virus, il 63% ha dichiarato che l’UE ha abbandonato i suoi cittadini mentre la pandemia dilaniava l’Europa meridionale e, alla domanda su chi fosse stato il loro alleato più utile nei giorni più bui della crisi, solo il 4% degli italiani ha citato l’UE, mentre il 25% ha dichiarato la Cina.”
Poi, certo, la confusione generale produce anche risposte che sembrerebbero dire il contrario: “Tuttavia, il diffuso disappunto per la risposta dell’UE non si è finora tradotto in una spinta per il populismo euroscettico. Una maggioranza convincente, il 63%, di cui il 55% in Germania, l’80% in Spagna e il 91% in Portogallo, ritiene che la pandemia abbia mostrato la necessità che i governi dell’UE agiscano in modo più coeso.”
Per far questo, va da sé, occorrerebbe una svolta socialista, non certo il ritorno all’austerità nelle politiche di bilancio. Dunque c’è da lavorare parecchio...
Fonte
Ultimo è arrivato il “pezzo grosso”, ossia il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, il che pone un’ipoteca pesante sull’esecutivo e sul suo presidente, il mediatore estremo Giuseppe Conte. Non per far cadere un governo che più esitante non si può, ma per condizionarne definitivamente le scelte fondamentali.
La cosa divertente – in realtà fa incazzare per la sfrontatezza – è che sul piano politico Zingaretti recita la parte del “riformista progressista”, mentre lo strumento di cui perora l’adozione è nato per imporre un “riformismo” di segno diametralmente opposto.
Fa impressione, in effetti, veder sventolare lo straccio con su scritto “quasi 40 miliardi per la spesa sanitaria” dal capo temporaneo di un partito che – scambiandosi a volte la poltrona con leghisti e berlusconiani – ha contribuito a ridurre la spesa per la sanità... di 37 miliardi in dieci anni.
Alcuni argomenti addotti da Zingaretti, infatti, sembrano una presa d’atto di aver sbagliato tutto nel recente passato (lui personalmente è stato “commissario alla sanità” della regione Lazio, decidendo la chiusura di numerosi ospedali e il taglio di innumerevoli servizi).
Per esempio: “questi mesi ci hanno mostrato quanto sia fondamentale investire nei sistemi sanitari e nelle scienze della vita per poter garantire il diritto a cure di qualità. È evidente la necessità di promuovere il potenziamento e l’ammodernamento del nostro sistema sanitario: rafforzare gli ospedali, puntare sulle tecnologie digitali, aumentare la presenza sui territori, l’assistenza domiciliare, la prevenzione, sostenere la ricerca e costruire un nuovo sistema di presa in carico delle persone, a cominciare dagli anziani. Il sistema sanitario ha risposto ed è stato capace di uno sforzo immane”.
Ma l’autocritica non arriva, neanche quando auspica un “salto nel futuro per costruire un nuovo modello: l’attuale sistema di cura e presa in carico fondato su tre politiche distinte che spesso non comunicano – sanità, sociale e terzo settore – ha mostrato tutti i suoi limiti, non va più bene, è inadeguato. Rinascita è anche questo: avere una visione nuova, fondata su un modello di integrazione delle politiche sanitarie e sociosanitarie da realizzare con idee e investimenti”.
Insomma: sei stato protagonista nell’applicazione di un “modello sbagliato”, ti presenti come quello che vuole “un salto nel futuro” e poi chiedi che si chiami in causa un “meccanismo” nato esattamente per far trionfare di quel “modello sbagliato” nella sanità e ovunque?
Ovvio che l’immagine di quel meccanismo vara passata a un trattamento di photoshop radicale: “Il Mes è stato criticato e combattuto da molti, ma ora è uno strumento finanziario totalmente diverso da quello del passato”.
Credibilità zero, ma potenza di fuoco mediatica assordante.
Fubini si prende il poco onorevole incarico di spiegare “cos’è il Mes” per farne il paradiso in terra.
Parte col dizionario in mano, come fanno i bravi giornalisti: “il Meccanismo europeo di stabilità è un ente intergovernativo la cui base legale è un trattato fra i Paesi dell’area euro, che ne sono azionisti in quote più o meno pari al loro peso economico: ed esiste legalmente dal 27 settembre del 2012.”
Sorvoliamo sul fatto che i soldi del Mes non sono creati da nulla, ma costituiscono “quote azionarie” messe dai singoli Stati (17% nel caso dell’Italia, circa 70 miliardi). Seguiamo la sua esposizione sulle “nuove caratteristiche” di quel fondo che dovrebbero cancellarne l’immagine terroristica (“Forse perché fra il 2010 e il 2012 il Fesf e il Mes hanno concesso circa 98 miliardi di prestiti al Portogallo, oltre 200 miliardi alla Grecia, 76 miliardi all’Irlanda, 41 miliardi alla Spagna: e in quel caso ci fu una «verifica esterna» dei programmi di risanamento dei Paesi da parte delle autorità europee". Ossia il “Memorandum” che ha messo in ginocchio soprattutto la Grecia, riducendola in miseria).
È certamente vero che le condizioni finanziarie sono migliori di quelle che si incontrano generalmente sui mercati (“Il tasso d’interesse sarebbe negativo nel caso di una scadenza a sette anni; e praticamente zero – 0,08% – nel caso di una scadenza a dieci anni. Un prestito a dieci anni del Mes, ai rendimenti attuali dei titoli di Stato, farebbe dunque risparmiare all’Italia 4,8 miliardi rispetto a un prestito che l’Italia dovesse cercare sul mercato collocando titoli di Stato”).
Così come è vero che quei soldi sarebbero erogati “quasi subito” (nell’arco di un anno) e alla condizione che vengano spesi solo per la sanità in generale (“spese dirette e indirette”, facendo sognare possibili “deroghe” in virtù di quell’”indirette”).
Ed è vero persino che l’analisi relativa alla sostenibilità del debito – con l’aggiunta del Mes – è già stata fatta, ha avuto “esisto positivo”.
L’unica cosa falsa è quella decisiva: che non ci sarebbero problemi derivanti dall’intreccio, sul breve e medio periodo, tra condizioni di funzionamento del Mes e altri trattati europei. Su questo Fubini è particolarmente netto, anche se non porta altra prova che la sua parola: “Non c’è niente nei Trattati dell’Unione europea che obblighi il Mes a fare o non fare qualunque scelta. Il Trattato del Mes prevede sì «condizionalità» sui prestiti. Ma, appunto, essa in questo caso prevede solo che il denaro sia investito in spesa sociale. Nient’altro.”
Messa così, chi rifiuta il Mes è un cretino che agita problemi “idologici”. Tanto più che neppure l’altra usuale obiezione (“nessun Paese sta chiedendo i prestiti del Mes”) viene dallo stesso Fubini smontata – molto fiaccamente, sul piano logico – ricordando che “Cipro lo sta facendo”.
Sappiamo per esperienza che la conoscenza dei trattati europei è inesistente nell’opinione pubblica (come nei giornalisti che ne parlano quasi sempre), anche perché – come in tutti i “contratti commerciali” vengono scritti in una lingua per iniziati.
Proprio per questo abbiamo pubblicato numerosi interventi in materia, tentando di spiegare anche ai profani alcuni dei meccanismi più pericolosi.
A tagliare la testa al toro (e anche al disperato tentativo di Fubini-Zingaretti) era del resto arrivata una lettera di Klaus Regling – il Direttore del Mes in persona – alla fine di aprile. Un passaggio chiarissimo, quasi in linguaggio corrente:“La Commissione Europea chiarirà monitoraggio e sorveglianza in accordo con le regole del Two Pack” (un trattato europeo relativamente recente che regola ulteriormente le modalità di stesura della “legge di stabilità” di ogni Paese dell’Unione).
Non è una cattiveria, ma una delle regole fondamentali del Mes, il cui Trattato istitutivo prevede che tutti i Paesi richiedenti l’accesso al prestito siano sottoposti a “sorveglianza rafforzata” da parte della Commissione e della Bce. Manca solo il Fmi e sarebbe riapparso il fantasma della Troika...
La “sorveglianza rafforzata” significa un più stringente controllo sulla spesa pubblica degli Stati che, in determinate condizioni, può tranquillamente portare a un “doloroso programma di aggiustamento macroeconomico”.
Siamo sicuri che Fubini ha letto quella lettera con la stessa nostra attenzione. E che capisca anche meglio di noi i meccanismi interni all’Unione Europea e la stessa logica dei trattati.
Solo che noi contrastiamo quei meccanismi e quella logica, e dunque possiamo permetterci di dire la verità. Chi li difende, invece, è costretto alla recita opposta.
*****
Il giornale inglese The Guardian ha pubblicato i risultati di un sondaggio europeo piuttosto interessante su come i cittadini del Vecchio Continente vedono l’operato dell’Unione Europea di fronte alla pandemia.
“I numeri che percepivano la performance dell’Ue come scarsa (più della metà in Francia) sono superati da chi ha detto che il blocco era “irrilevante”, perché l’impennata del numero di morti ha lasciato alcune comunità in difficoltà per seppellire i loro morti. Le grandi maggioranze di tutte le nazioni intervistate – nove, con due terzi dei cittadini europei – ritengono che il loro paese sia stato lasciato solo o che non sappiano chi sia il loro alleato più utile.”
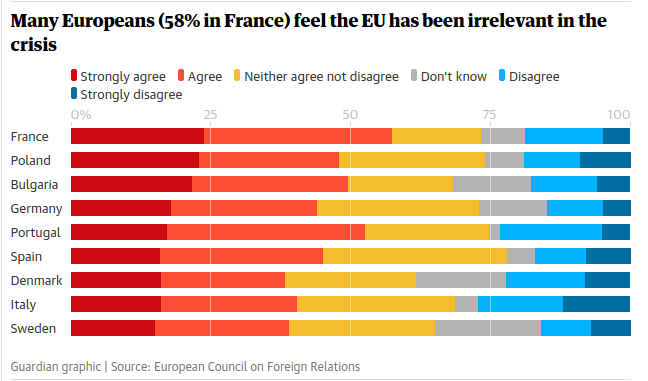
Addirittura “In Italia, uno dei Paesi colpiti per primo dal virus, il 63% ha dichiarato che l’UE ha abbandonato i suoi cittadini mentre la pandemia dilaniava l’Europa meridionale e, alla domanda su chi fosse stato il loro alleato più utile nei giorni più bui della crisi, solo il 4% degli italiani ha citato l’UE, mentre il 25% ha dichiarato la Cina.”
Poi, certo, la confusione generale produce anche risposte che sembrerebbero dire il contrario: “Tuttavia, il diffuso disappunto per la risposta dell’UE non si è finora tradotto in una spinta per il populismo euroscettico. Una maggioranza convincente, il 63%, di cui il 55% in Germania, l’80% in Spagna e il 91% in Portogallo, ritiene che la pandemia abbia mostrato la necessità che i governi dell’UE agiscano in modo più coeso.”
Per far questo, va da sé, occorrerebbe una svolta socialista, non certo il ritorno all’austerità nelle politiche di bilancio. Dunque c’è da lavorare parecchio...
Fonte
Le linee guida per la scuola-azienda
Data la valanga di critiche giunta al Ministero, le manifestazioni in oltre sessanta città di lavoratori della scuola e genitori, era lecito attendersi che la bozza di Linee guida per il rientro a scuola di settembre sarebbe stata sensibilmente modificata nella sua stesura finale.
Così non è stato. Confrontando la bozza e la stesura finale si trovano due sole significative differenze: sparisce il riferimento alle figure educative che conducono attività integrative che non saranno più chiamate a essere responsabili delle classi e il metro di distanza tra i banchi diventa un metro tra le “rime buccali” (!).
Quest’ultima bizzarra correzione è fatta, in sostanza, per guadagnare qualche centimetro dal metro di distanza e far entrare qualche alunno in più in aula. A questo proposito, la ministra ha annunciato pomposamente che sarà predisposta una app che permetterà di incrociare i dati sulle situazioni edilizie di vari istituti. Se funzionerà e servirà a qualcosa, lo vedremo.
Nonostante tutto questo, ciò che sembra avere destato una certa soddisfazione nei presidenti di regione, quale l’emiliano Bonaccini, è l’aumento dello stanziamento di fondi per la scuola promesso ma non ancora esattamente quantificato dal Presidente del Consiglio.
Destinare maggiori fondi alla scuola è senz’altro una buona cosa, ma non può bastare a dare un giudizio positivo su come il governo intende la ripresa settembrina. Ciò anche perché tali fondi non si tradurranno in un’entrata di docenti e personale ATA in più, poiché, come ha detto la Ministra, le assunzioni saranno a tempo determinato e, aggiungiamo noi, riguardano per la maggior parte personale precario già in servizio, quindi aumenteranno solo in minima parte l’organico delle scuole.
Inoltre, una parte del movimento “priorità alla scuola” non ha esitato a richiedere piuttosto acriticamente che all’istruzione fosse destinata una parte dei fondi che si presume arriveranno dalla Commissione Europea, che non sono ancora sicuri e che soprattutto non saranno certo un gentile regalo, ma saranno legati in gran parte a impegni di restituzione e soprattutto a riforme strutturali da apportare al nostro paese, magari anche alla scuola.
E le precedenti esperienze, Grecia compresa, fanno tremare.
Giova anche ricordare che la crisi della scuola italiana non è dovuta solo ai tagli di bilancio, pur gravi, ma in buona parte all’impianto dell’organizzazione del lavoro e della didattica imposto negli ultimi venti anni, con cui le Linee guida si pongono in una continuità che è rimasta completamente intatta, nonostante le tante critiche espresse da pedagogisti e insegnanti.
In particolare, tutto il documento, che utilizza alcune indicazioni del Comitato Colao e della Commissione Bianchi, è impostato sulla commistione tra pubblico e privato, nel nome della sussidiarietà.
L’approdo al concetto di sussidiarietà sembra essere la continuazione del lungo percorso iniziato nel 1997 con il varo dell’autonomia scolastica e giunto a un punto di svolta decisivo con la legge 107/2015, la “Buona scuola“ di Renzi.
Tale commistione, naturalmente, viene presentata come una pulsione al volontariato, alla filantropia, alla beneficenza da parte dei privati, occultando che ciò, in realtà, non può che significare un’indebita ingerenza se non un totale asservimento della scuola alle esigenze del capitale.
Non è un caso che si siano già sperimentate, nel nostro paese, alcune situazioni di sponsorizzazione di scuole e progetti di scuole che hanno sempre avuto come sbocco la torsione verso un modello produttivistico dell’offerta formativa.
L’autonomia scolastica è, ancora una volta, il brodo di coltura all’interno del quale si possono sviluppare tali attività di carattere aziendalista e privatista. In tale contesto, la scuola non appare certamente tutelata dal fatto che sia stato escluso dalle Linee guida che figure che non fanno parte dell’organico docente non possano avere ruoli di responsabilità nella vigilanza degli alunni, poiché sicuramente aziende e associazioni private potranno inviare i loro “esperti” ad affiancare i docenti.
Appare anche pericolosa la formulazione del “Patto educativo di comunità” che tanto piace al Ministero, in cui dovrebbero convergere i contributi delle regioni, del cosiddetto volontariato e dei privati. Una commistione e una compromissione rischiosa, in cui i ruoli e soprattutto il senso delle istituzioni si stemperano.
La scuola è una colonna istituzionale pubblica dello stato italiano, non può essere frammentata e smembrata in “patti educativi di comunità” locali in cui entrano interessi privati, sponsorizzazioni, esperti aziendali, associazioni di “volontariato” magari confessionali.
Una frammentazione istituzionale, magari spacciata per aderenza alle esigenze del territorio (leggasi imprese) accrescerebbe tra l’altro le differenze già provocate dall’autonomia scolastica.
Queste riflessioni sorgono anche perché, come ho scritto, le Linee guida si collegano ad alcune sollecitazioni della Commissione di esperti del Miur presieduta da Patrizio Bianchi, che guarda ben oltre la ripresa di settembre, nell’intenzione di un “miglioramento del sistema di istruzione nazionale”.
Una questione su cui la Ministra non sembra proprio avere le idee chiare è quella di dove mettere quel 15% di alunni e studenti che, secondo le sue dichiarazioni, in classe proprio non troveranno posto. L’indicazione è di usare musei, teatri, spazi di istituzioni varie per attività educative.
La Ministra non sembra rendersi conto che non tutte le scuole si trovano a Roma, Milano o Napoli, dove il patrimonio culturale è molto vasto ed esistono plurime attività, ma sono collocate in piccoli centri o paesi dove musei e teatri nemmeno ci sono.
In ogni caso, anche nei grandi centri non appare edificante che le scolaresche siano costrette a pencolare per la città alla ricerca di luoghi dove svolgere attività che non si riesce a fare a scuola e gli insegnanti a programmare compulsivamente uscite didattiche dettate più da esigenze di spazio che da un progetto pedagogico.
Certamente, in alcuni casi, si potrebbe pensare di riutilizzare edifici dismessi nel periodo della grande decrescita demografica degli anni '90, ma tali sedi sono state spesso lasciate in stato d’abbandono e inoltre, non si deve dimenticare che la scuola d’oggi richiede attrezzature, laboratori e aule multimediali non essendo, a dispetto di quanto scrivono molti giornali, la scuola della cattedra e dei banchi.
Qualche giorno fa, ho letto su un giornale che gli insegnanti, per sicurezza, avrebbero dovuto fare lezione “stando in cattedra”, evitando persino di spostarsi tra i banchi. Mi chiedo quale sia la concezione della scuola di quel giornalista. Ho insegnato per decenni, e nella mia aula la cattedra nemmeno c’era.
Tuttavia, facciamo attenzione agli imbrogli. Se taluni esprimono una concezione della scuola puramente trasmissiva, che peraltro ha trovato una buona realizzazione in molte esperienze improvvisate di didattica a distanza, ben diverso è il linguaggio che si parla al Ministero, un misto di didattichese e aziendalese associato a teorie sull’innovazione didattica in cui quest’ultima coincide con digitalizzazione.
Personalmente ho sempre pensato che il digitale possa avere molte potenzialità nella scuola, ma nella direzione esattamente contraria a quella immaginata al Ministero.
Infatti, l’uso delle nuove tecnologie nella scuola dovrebbe essere destinato allo sviluppo della creatività nelle attività artistiche, come l’arte e la musica, il teatro, il cinema, dove possono dare un notevole contributo, oltre che naturalmente nelle materie tecnico-scientifiche. Ciò significa però, per converso, anche opporsi alla digitalizzazione degli apprendimenti e alla loro riduzione a sequenze prestabilite e alla sottomissione a ritmi prefissati.
In pratica, delle possibilità di sperimentare e creare offerte dalle nuove tecnologie è proposta al contrario una standardizzazione dei percorsi e degli obiettivi, magari verificati con i famigerati test a scelta multipla tanto amati dall’INVALSI.
Tutto questo va tenuto presente per quanto riguarda le Linee guida, ricordando che ogni scuola dovrà, secondo tale documento, inserire nel proprio PTOF una parte riguardante la didattica digitale, indicazione che sembra voler rilanciare le non troppo certe fortune del “Piano nazionale scuola digitale” che è una delle colonne portanti della legge 107/2015.
Peraltro l’idea di una digitalizzazione dell’apprendimento si sposa alla chiara tendenza alla riduzione dell’importanza dei saperi già in atto da anni con l’introduzione d’imperio, nella scuola, della didattica per competenze, assai spinta da attori esterni alla scuola, come l’OCSE, la Tavola degli Industriali Europei, il FMI, che nell’ultimo trentennio hanno deciso di impegnarsi nella formazione per indirizzarla verso le esigenze delle imprese e del mercato del lavoro.
Proprio pensando al mercato del lavoro, tali agenzie internazionali, con l’accordo dell’Unione Europea, che ne ha accolto le istanze in molte delle sue conferenze, prima tra tutte Lisbona 2000, immaginano una scuola dove s’impara ciò che serve per il lavoro, non quanto è utile a un cittadino critico e consapevole.
Poiché solo pochi saranno destinati ai più alti livelli nel mondo del lavoro, è inutile fingere che la società sia diversa da come è, fornendo un’istruzione di qualità a tutti. Per la maggioranza, basta infatti sapere poche cose e, secondo la logica delle competenze, saper risolvere qualche problema semplice, come gli “Episodi di apprendimento situato” attraverso alcune tecniche le quali si appoggiano spesso al digitale.
Nulla a che vedere con la complessità dei saperi, la ricerca, l’approfondimento discorsivo e narrativo.
In questo quadro va collocata per esempio, la proposta delle Linee guida di “aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari”, che evidentemente non contribuisce all’approfondimento dei saperi, ma piuttosto a un loro utilizzo per la risoluzione di semplici problemi volti all’acquisizione di competenze.
Evidente poi, l’importanza che in un tale quadro assumono i “Percorsi trasversali per l’orientamento”, cioè l’alternanza scuola lavoro, momento fondamentale per instillare nei giovani la cultura aziendalista e di formazione ideologica alla sottomissione del lavoro dipendente.
Nemmeno di fronte alle evidenti difficoltà in cui si trovano molti studenti a causa di un anno scolastico bruscamente interrotto e malamente concluso con la didattica a distanza, la Ministra ha pensato si potesse rinunciare a un’attività tanto discussa come l’alternanza scuola-lavoro a favore di tempo dedicato al recupero dei saperi.
A proposito delle attività di recupero per i molti studenti che hanno avuto difficoltà durante il periodo della didattica a distanza, non è chiaro cosa accadrà a settembre, ma la Ministra ha parlato di attività che inizieranno già dal primo del mese, ma anche di possibilità di “potenziamento” per gli alunni che vogliono mostrare il loro “talento”.
Iniziativa, quest’ultima, che potrebbe apparire poco adatta al momento, ma che si spiega con l’insistenza con la quale da qualche tempo si batte sul tasto dei “superdotati”. Insomma, la scuola deve avere degli eccellenti e dei mediocri, se vuole adattarsi alla gerarchia sociale e alla giungla del lavoro.
Le linee guida del Ministero, quindi vanno prese molto sul serio, poiché, pur se nate in un momento d’emergenza, sono espressione di una concezione della scuola in continuità con la gestione degli ultimi decenni e guardano al contempo alle tendenze che si delineano per i prossimi.
Anche la loro vaghezza, che emerge in alcuni punti, è semplicemente segno della volontà di frammentare sempre più il sistema scolastico nazionale a vantaggio di una situazione a macchie di leopardo, con l’accrescimento non certo virtuoso delle differenze e soprattutto delle disuguaglianze, a tutto vantaggio delle “comunità educanti” che sguazzeranno nella sussidiarietà pubblico-privato.
Ci resta comunque una speranza: la Ministra ha detto che da settembre si vogliono scuole pulite e che sono stati investiti milioni per prodotti detergenti e igienizzanti. Chissà se finalmente sono finiti i tempi in cui i genitori dovevano fornire le classi di carta igienica, saponette e fazzolettini.
Questo anche se resta una domanda inquietante: chi pulirà le aule, con una dotazione organica così insufficiente di collaboratori scolastici?
Fonte
Così non è stato. Confrontando la bozza e la stesura finale si trovano due sole significative differenze: sparisce il riferimento alle figure educative che conducono attività integrative che non saranno più chiamate a essere responsabili delle classi e il metro di distanza tra i banchi diventa un metro tra le “rime buccali” (!).
Quest’ultima bizzarra correzione è fatta, in sostanza, per guadagnare qualche centimetro dal metro di distanza e far entrare qualche alunno in più in aula. A questo proposito, la ministra ha annunciato pomposamente che sarà predisposta una app che permetterà di incrociare i dati sulle situazioni edilizie di vari istituti. Se funzionerà e servirà a qualcosa, lo vedremo.
Nonostante tutto questo, ciò che sembra avere destato una certa soddisfazione nei presidenti di regione, quale l’emiliano Bonaccini, è l’aumento dello stanziamento di fondi per la scuola promesso ma non ancora esattamente quantificato dal Presidente del Consiglio.
Destinare maggiori fondi alla scuola è senz’altro una buona cosa, ma non può bastare a dare un giudizio positivo su come il governo intende la ripresa settembrina. Ciò anche perché tali fondi non si tradurranno in un’entrata di docenti e personale ATA in più, poiché, come ha detto la Ministra, le assunzioni saranno a tempo determinato e, aggiungiamo noi, riguardano per la maggior parte personale precario già in servizio, quindi aumenteranno solo in minima parte l’organico delle scuole.
Inoltre, una parte del movimento “priorità alla scuola” non ha esitato a richiedere piuttosto acriticamente che all’istruzione fosse destinata una parte dei fondi che si presume arriveranno dalla Commissione Europea, che non sono ancora sicuri e che soprattutto non saranno certo un gentile regalo, ma saranno legati in gran parte a impegni di restituzione e soprattutto a riforme strutturali da apportare al nostro paese, magari anche alla scuola.
E le precedenti esperienze, Grecia compresa, fanno tremare.
Giova anche ricordare che la crisi della scuola italiana non è dovuta solo ai tagli di bilancio, pur gravi, ma in buona parte all’impianto dell’organizzazione del lavoro e della didattica imposto negli ultimi venti anni, con cui le Linee guida si pongono in una continuità che è rimasta completamente intatta, nonostante le tante critiche espresse da pedagogisti e insegnanti.
In particolare, tutto il documento, che utilizza alcune indicazioni del Comitato Colao e della Commissione Bianchi, è impostato sulla commistione tra pubblico e privato, nel nome della sussidiarietà.
L’approdo al concetto di sussidiarietà sembra essere la continuazione del lungo percorso iniziato nel 1997 con il varo dell’autonomia scolastica e giunto a un punto di svolta decisivo con la legge 107/2015, la “Buona scuola“ di Renzi.
Tale commistione, naturalmente, viene presentata come una pulsione al volontariato, alla filantropia, alla beneficenza da parte dei privati, occultando che ciò, in realtà, non può che significare un’indebita ingerenza se non un totale asservimento della scuola alle esigenze del capitale.
Non è un caso che si siano già sperimentate, nel nostro paese, alcune situazioni di sponsorizzazione di scuole e progetti di scuole che hanno sempre avuto come sbocco la torsione verso un modello produttivistico dell’offerta formativa.
L’autonomia scolastica è, ancora una volta, il brodo di coltura all’interno del quale si possono sviluppare tali attività di carattere aziendalista e privatista. In tale contesto, la scuola non appare certamente tutelata dal fatto che sia stato escluso dalle Linee guida che figure che non fanno parte dell’organico docente non possano avere ruoli di responsabilità nella vigilanza degli alunni, poiché sicuramente aziende e associazioni private potranno inviare i loro “esperti” ad affiancare i docenti.
Appare anche pericolosa la formulazione del “Patto educativo di comunità” che tanto piace al Ministero, in cui dovrebbero convergere i contributi delle regioni, del cosiddetto volontariato e dei privati. Una commistione e una compromissione rischiosa, in cui i ruoli e soprattutto il senso delle istituzioni si stemperano.
La scuola è una colonna istituzionale pubblica dello stato italiano, non può essere frammentata e smembrata in “patti educativi di comunità” locali in cui entrano interessi privati, sponsorizzazioni, esperti aziendali, associazioni di “volontariato” magari confessionali.
Una frammentazione istituzionale, magari spacciata per aderenza alle esigenze del territorio (leggasi imprese) accrescerebbe tra l’altro le differenze già provocate dall’autonomia scolastica.
Queste riflessioni sorgono anche perché, come ho scritto, le Linee guida si collegano ad alcune sollecitazioni della Commissione di esperti del Miur presieduta da Patrizio Bianchi, che guarda ben oltre la ripresa di settembre, nell’intenzione di un “miglioramento del sistema di istruzione nazionale”.
Una questione su cui la Ministra non sembra proprio avere le idee chiare è quella di dove mettere quel 15% di alunni e studenti che, secondo le sue dichiarazioni, in classe proprio non troveranno posto. L’indicazione è di usare musei, teatri, spazi di istituzioni varie per attività educative.
La Ministra non sembra rendersi conto che non tutte le scuole si trovano a Roma, Milano o Napoli, dove il patrimonio culturale è molto vasto ed esistono plurime attività, ma sono collocate in piccoli centri o paesi dove musei e teatri nemmeno ci sono.
In ogni caso, anche nei grandi centri non appare edificante che le scolaresche siano costrette a pencolare per la città alla ricerca di luoghi dove svolgere attività che non si riesce a fare a scuola e gli insegnanti a programmare compulsivamente uscite didattiche dettate più da esigenze di spazio che da un progetto pedagogico.
Certamente, in alcuni casi, si potrebbe pensare di riutilizzare edifici dismessi nel periodo della grande decrescita demografica degli anni '90, ma tali sedi sono state spesso lasciate in stato d’abbandono e inoltre, non si deve dimenticare che la scuola d’oggi richiede attrezzature, laboratori e aule multimediali non essendo, a dispetto di quanto scrivono molti giornali, la scuola della cattedra e dei banchi.
Qualche giorno fa, ho letto su un giornale che gli insegnanti, per sicurezza, avrebbero dovuto fare lezione “stando in cattedra”, evitando persino di spostarsi tra i banchi. Mi chiedo quale sia la concezione della scuola di quel giornalista. Ho insegnato per decenni, e nella mia aula la cattedra nemmeno c’era.
Tuttavia, facciamo attenzione agli imbrogli. Se taluni esprimono una concezione della scuola puramente trasmissiva, che peraltro ha trovato una buona realizzazione in molte esperienze improvvisate di didattica a distanza, ben diverso è il linguaggio che si parla al Ministero, un misto di didattichese e aziendalese associato a teorie sull’innovazione didattica in cui quest’ultima coincide con digitalizzazione.
Personalmente ho sempre pensato che il digitale possa avere molte potenzialità nella scuola, ma nella direzione esattamente contraria a quella immaginata al Ministero.
Infatti, l’uso delle nuove tecnologie nella scuola dovrebbe essere destinato allo sviluppo della creatività nelle attività artistiche, come l’arte e la musica, il teatro, il cinema, dove possono dare un notevole contributo, oltre che naturalmente nelle materie tecnico-scientifiche. Ciò significa però, per converso, anche opporsi alla digitalizzazione degli apprendimenti e alla loro riduzione a sequenze prestabilite e alla sottomissione a ritmi prefissati.
In pratica, delle possibilità di sperimentare e creare offerte dalle nuove tecnologie è proposta al contrario una standardizzazione dei percorsi e degli obiettivi, magari verificati con i famigerati test a scelta multipla tanto amati dall’INVALSI.
Tutto questo va tenuto presente per quanto riguarda le Linee guida, ricordando che ogni scuola dovrà, secondo tale documento, inserire nel proprio PTOF una parte riguardante la didattica digitale, indicazione che sembra voler rilanciare le non troppo certe fortune del “Piano nazionale scuola digitale” che è una delle colonne portanti della legge 107/2015.
Peraltro l’idea di una digitalizzazione dell’apprendimento si sposa alla chiara tendenza alla riduzione dell’importanza dei saperi già in atto da anni con l’introduzione d’imperio, nella scuola, della didattica per competenze, assai spinta da attori esterni alla scuola, come l’OCSE, la Tavola degli Industriali Europei, il FMI, che nell’ultimo trentennio hanno deciso di impegnarsi nella formazione per indirizzarla verso le esigenze delle imprese e del mercato del lavoro.
Proprio pensando al mercato del lavoro, tali agenzie internazionali, con l’accordo dell’Unione Europea, che ne ha accolto le istanze in molte delle sue conferenze, prima tra tutte Lisbona 2000, immaginano una scuola dove s’impara ciò che serve per il lavoro, non quanto è utile a un cittadino critico e consapevole.
Poiché solo pochi saranno destinati ai più alti livelli nel mondo del lavoro, è inutile fingere che la società sia diversa da come è, fornendo un’istruzione di qualità a tutti. Per la maggioranza, basta infatti sapere poche cose e, secondo la logica delle competenze, saper risolvere qualche problema semplice, come gli “Episodi di apprendimento situato” attraverso alcune tecniche le quali si appoggiano spesso al digitale.
Nulla a che vedere con la complessità dei saperi, la ricerca, l’approfondimento discorsivo e narrativo.
In questo quadro va collocata per esempio, la proposta delle Linee guida di “aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari”, che evidentemente non contribuisce all’approfondimento dei saperi, ma piuttosto a un loro utilizzo per la risoluzione di semplici problemi volti all’acquisizione di competenze.
Evidente poi, l’importanza che in un tale quadro assumono i “Percorsi trasversali per l’orientamento”, cioè l’alternanza scuola lavoro, momento fondamentale per instillare nei giovani la cultura aziendalista e di formazione ideologica alla sottomissione del lavoro dipendente.
Nemmeno di fronte alle evidenti difficoltà in cui si trovano molti studenti a causa di un anno scolastico bruscamente interrotto e malamente concluso con la didattica a distanza, la Ministra ha pensato si potesse rinunciare a un’attività tanto discussa come l’alternanza scuola-lavoro a favore di tempo dedicato al recupero dei saperi.
A proposito delle attività di recupero per i molti studenti che hanno avuto difficoltà durante il periodo della didattica a distanza, non è chiaro cosa accadrà a settembre, ma la Ministra ha parlato di attività che inizieranno già dal primo del mese, ma anche di possibilità di “potenziamento” per gli alunni che vogliono mostrare il loro “talento”.
Iniziativa, quest’ultima, che potrebbe apparire poco adatta al momento, ma che si spiega con l’insistenza con la quale da qualche tempo si batte sul tasto dei “superdotati”. Insomma, la scuola deve avere degli eccellenti e dei mediocri, se vuole adattarsi alla gerarchia sociale e alla giungla del lavoro.
Le linee guida del Ministero, quindi vanno prese molto sul serio, poiché, pur se nate in un momento d’emergenza, sono espressione di una concezione della scuola in continuità con la gestione degli ultimi decenni e guardano al contempo alle tendenze che si delineano per i prossimi.
Anche la loro vaghezza, che emerge in alcuni punti, è semplicemente segno della volontà di frammentare sempre più il sistema scolastico nazionale a vantaggio di una situazione a macchie di leopardo, con l’accrescimento non certo virtuoso delle differenze e soprattutto delle disuguaglianze, a tutto vantaggio delle “comunità educanti” che sguazzeranno nella sussidiarietà pubblico-privato.
Ci resta comunque una speranza: la Ministra ha detto che da settembre si vogliono scuole pulite e che sono stati investiti milioni per prodotti detergenti e igienizzanti. Chissà se finalmente sono finiti i tempi in cui i genitori dovevano fornire le classi di carta igienica, saponette e fazzolettini.
Questo anche se resta una domanda inquietante: chi pulirà le aule, con una dotazione organica così insufficiente di collaboratori scolastici?
Fonte
28/06/2020
Stercocrazia
di Alessandra Daniele
È particolarmente difficile scrivere di politica italiana in questi giorni.
Perché fa veramente schifo al cazzo.
Persino più del solito.
È tutta una cacarella di correnti contrapposte, con due soli punti fermi.
Matteo Renzi è fermamente deciso a far perdere le elezioni regionali al PD. Uno scossone che farebbe traballare il governo, rendendo più importante il suo sostegno condizionato. Per Renzi la vendetta è un piatto che si serve quando serve.
Matteo Salvini è fermamente deciso a mangiare tutto quello che gli passa davanti. Salumi, mozzarelle, polpette, ciliegie, bulloni, scarafaggi.
L’unica cosa che non ha ancora tentato di inghiottire sono i cellulari che gli porgono per i selfie, perché quelli sono la sua Sindone: ci lascia impressa la sua immagine di sudore e sugna che gli archeologi del futuro considereranno un falso, perché di tratti evidentemente non umani.
Scrivere di politica italiana in questi giorni è come fare l’autopsia d’un cadavere frollato in una fogna. In mezzo ai topi.
La Destra sfrutta il Covid-19 per istigare all’odio razziale.
I candidati alle elezioni regionali sono una secchiata di riciclati.
Gli Stati Confusionali di Conte non sono serviti a un cazzo.
Ma è davvero questa la politica? No.
La politica, quella vera, è per le strade. Nelle piazze. Davanti alle fabbriche.
La politica, quella vera, non sono le ripicche di Renzi, la bulimia di Salvini, l’inesistenza di Conte. Non è questo teatrino degli orrori.
La politica, quella vera, siamo noi.
Fonte
È particolarmente difficile scrivere di politica italiana in questi giorni.
Perché fa veramente schifo al cazzo.
Persino più del solito.
È tutta una cacarella di correnti contrapposte, con due soli punti fermi.
Matteo Renzi è fermamente deciso a far perdere le elezioni regionali al PD. Uno scossone che farebbe traballare il governo, rendendo più importante il suo sostegno condizionato. Per Renzi la vendetta è un piatto che si serve quando serve.
Matteo Salvini è fermamente deciso a mangiare tutto quello che gli passa davanti. Salumi, mozzarelle, polpette, ciliegie, bulloni, scarafaggi.
L’unica cosa che non ha ancora tentato di inghiottire sono i cellulari che gli porgono per i selfie, perché quelli sono la sua Sindone: ci lascia impressa la sua immagine di sudore e sugna che gli archeologi del futuro considereranno un falso, perché di tratti evidentemente non umani.
Scrivere di politica italiana in questi giorni è come fare l’autopsia d’un cadavere frollato in una fogna. In mezzo ai topi.
La Destra sfrutta il Covid-19 per istigare all’odio razziale.
I candidati alle elezioni regionali sono una secchiata di riciclati.
Gli Stati Confusionali di Conte non sono serviti a un cazzo.
Ma è davvero questa la politica? No.
La politica, quella vera, è per le strade. Nelle piazze. Davanti alle fabbriche.
La politica, quella vera, non sono le ripicche di Renzi, la bulimia di Salvini, l’inesistenza di Conte. Non è questo teatrino degli orrori.
La politica, quella vera, siamo noi.
Fonte
Guaidó, pezzo chiave contro il Venezuela, nonostante il fallimento
La figura di Juan Guaidó come presidente incaricato del Venezuela è risultata un fallimento politico. Invece, visto come meccanismo per giustificare furti di beni della Nazione, il saldo è differente. Su questo piano di spoliazione si organizzano governi, multinazionali, giudici e avvocati.
Juan Guaidó è a un punto politico morto. Non riesce a recuperare iniziativa, convincere, disfarsi dei fascicoli sulla malversazione di fondi che lo circondano. Il trascorrere delle settimane e dei mesi lo rimpiccolisce, e già rimane poco o niente del ricordo del suo passaggio per il Congresso statunitense e la Casa Bianca all’inizio di questo 2020.
Vista in questi termini, la performance del “presidente incaricato” è un fallimento. L’istituzione parallela e virtuale non raggiunge la sua finalità politica. La stessa cosa è accaduta con il “Tribunale Supremo di Giustizia in esilio”, del quale ormai non si ha quasi più memoria, o la “PM generale in esilio”, senza rilevanza alcuna.
Risulta quindi plausibile l’affermazione di John Bolton, ex consigliere di Sicurezza, che nel suo libro “The Room Where It Happened” ha scritto che il presidente Donald Trump ha manifestato dubbi circa le capacità e le attitudini di Guaidó.
È perciò logico che lo stesso Trump abbia lasciato intravedere in un’intervista recente, pubblicata sul portale Axios, i suoi dubbi su Guaidó. E perché non dovrebbe averli su uno che non ha ottenuto una sola vittoria interna da quando è stato riconosciuto/nominato dalla sua amministrazione il 23 gennaio 2019?
Visto così risulta chiaro che Guaidó a volte è più un problema che altro. A questo si devono aggiungere le sue apparizioni e fallimenti golpisti, come quello del 30 aprile del 2019, o i suoi legami con i mercenari dell’Operazione Gedeón che sono arrivati in Venezuela nello scorso mese di maggio.
Ma Guaidó può essere analizzato in altra maniera: non per il suo risultato politico immediato e interno, ma come ingranaggio di un meccanismo di spoliazione. Guaidó, con la sua nomina a presidente incaricato del Venezuela da parte degli USA, ha permesso che, in suo nome, fossero messe in moto ruberie sui beni della Nazione. E qui non si tratta più di un fallimento per gli USA.
La spoliazione
“All’interno Guaidó è sminuito, credo che Trump non abbia mai creduto in lui, invece è servito per la strategia di spoliazione, a livello internazionale continuano ad avanzare e continuano ad accerchiarci”, spiega a Sputnik María Alejandra Díaz, avvocata, deputata dell’Assemblea Nazionale Costituente.
Quel furto si è fatto evidente fin dall’inizio del riconoscimento di Guaidó come “presidente incaricato”. Il 25 gennaio, due giorni dopo la sua auto-proclamazione, il segretario di Stato, Mike Pompeo, ha dato autorità a Guaidó “per ricevere e controllare certe proprietà in conti del Governo del Venezuela o della Banca Centrale del Venezuela (BCV) in possesso della Banca della Riserva Federale di New York o qualsiasi altra banca assicurata negli USA”.
Il 28 gennaio 2019 la Casa Bianca ha emesso l’ordine esecutivo 13.850, centrato su Petróleos de Venezuela (PDVSA) e la BCV, che ha bloccato “tutti i beni e gli interessi di proprietà di PDVSA soggetti alla giurisdizione degli USA”. Il 5 agosto del 2019, ha emesso l’ordine esecutivo 13.884 che ha bloccato tutti i fondi venezuelani nel suo territorio.
Questi conti e fondi sono rimasti in gestione statunitense, e questo è stato reso manifesto con lo scandalo suscitato poche settimane fa quando è stata diffusa la notizia che Donald Trump ha utilizzato 601 milioni di dollari di quei fondi per costruire il muro alla frontiera con il Messico.
Il piano di spoliazione si è posto vari obiettivi centrali al fine di rubare e ripartirsi ricchezze dello Stato venezuelano. Uno di quegli obiettivi è l’impresa raffinatrice CITGO, filiale di PDVSA negli USA, l’oro appartenente alla BCV che si trova nella Banca d’Inghilterra, e, approfittando di questo momento d’assedio, di reclamare il territorio della Guayana Esequiba.
CITGO
L’impresa filiale di PDVSA negli USA è sotto embargo del Dipartimento del Tesoro da agosto del 2019, e la possibilità che sia spezzettata e consegnata ad imprese straniere è stata presente fin dall’inizio della sua appropriazione da parte del Governo statunitense.
Si tratta di uno dei maggiori attivi venezuelani all’estero, valutato in circa 8.000 milioni di dollari, con una struttura di tre raffinerie con capacità vicina ai 749.000 barili giornalieri, e circa 6.000 stazioni di servizio distribuite in franchising nel paese.
Due imprese cercano di appropriarsi di CITGO per farsi pagare quello che, secondo loro, gli deve lo Stato venezuelano: l’industria mineraria canadese Crystallex, e la petrolifera statunitense, ConocoPhillips.
Guaidó ha messo alla “Procura Generale” del suo “Governo”, cioè quelli che devono rappresentare e difendere giudizialmente gli interessi della Repubblica nelle questioni internazionali, José Ignacio Hernández, che era stato avvocato della Cristallex.
Così, mentre da un lato Guaidó affermava di difendere la CITGO, dall’altro, è stato parte di una strategia di verdetti a favore delle imprese straniere. María Alejandra Díaz segnala che si tratta della strategia degli “studi legali che sono alleati con Guaidó, USA e le multinazionali, per spogliare il Venezuela“.
Questo è stato denunciato dal Governo del Venezuela, che ha segnalato come Hernández – che ha rinunciato all’incarico giorni dopo – ha lavorato insieme al direttore della Banca Mondiale (BM), David Malpass, perché il Centro Internazionale per il Regolamento delle Controversie relative ad Investimenti (n.d.t.: sigla in inglese International Centre for Settlement of Investment Disputes – ICSID. In spagnolo CIADI) dipendente dalla Banca, riconoscesse il “Governo di Guaidó” per portare avanti gli arbitraggi.
Questo processo di rapina di CITGO e consegna a imprese straniere è in tappa avanzata: il 22 maggio un giudice della Corte Federale degli USA ha proceduto ad autorizzare la liquidazione di CITGO affinché la Crystallex si prenda quello che afferma le sia dovuto.
Invece, esiste una risoluzione del Dipartimento del Tesoro che proibisce la vendita di CITGO. La possibilità che la filiale di PDVSA sia messa all’asta e perduta dipende dunque centralmente dalla decisione del governo statunitense.
L’oro
La BCV ha, come varie banche centrali, oro conservato nella Banca d’Inghilterra. Alla fine del 2018 ha effettuato la richiesta per recuperare 30 tonnellate. Il Governo britannico, in vista del suo riconoscimento al “Governo provvisorio di Guaidó” ha negato la richiesta e, in maniera illegale, si è tenuta l’oro.
La posizione diplomatica del Regno Unito è stata senza dubbio ambigua: hanno riconosciuto Guaidó, ma hanno ricevuto la sua “ambasciatrice”, Vanessa Neumann, senza le credenziali formali. Vale a dire che si è costruita una zona grigia, di riconoscimento incompleto – come in numerosi paesi, a differenza degli USA – che, in caso di un conflitto come quello di chi deve tenere l’oro, non permette di avanzare verso una risoluzione.
Di fronte a questa situazione, e in vista del fatto che la BCV ha fatto reclamo legale davanti a un tribunale di Londra nel maggio di quest’anno, la giustizia britannica ha iniziato, lunedì 22 giugno un dibattito per determinare se si riconoscerà alla BCV del Governo venezuelano o a una commissione nominata ad hoc da Guaidó. Chi terrà l’oro dipenderà da quel risultato.
Il Governo venezuelano ha proposto che l’ammontare dell’oro reclamato – circa 1.000 milioni di dollari – sia direttamente trasferito al Programma di Sviluppo delle Nazioni Unite per occuparsi della situazione della pandemia e dell’emergenza umanitaria nel paese.
La risoluzione della Giustizia britannica ricadrà non solamente sull’oro nella Banca d’Inghilterra, ma sarà un punto di riferimento per ulteriori casi in disputa, come i 120 milioni di dollari appartenenti alla BCV che si tiene la Deutsche Bank, o numerosi conti congelati in differenti banche.
“L’oro in Inghilterra se lo ruberanno apertamente, si terranno i conti, come hanno fatto con la Libia, quello che non hanno potuto rompere internamente lo stanno facendo internazionalmente, ci vogliono prosciugare di tutti i beni di proprietà della Repubblica per ripartirseli tra le multinazionali, che sono il vero potere che sta dietro i governi negli USA e in Inghilterra”, spiega María Alejandra Díaz.
Guayana Esequiba
La Costituente segnala un’altro fronte di tentativo di spoliazione: la Guayana Esequiba, territorio reclamato dal Venezuela. “Il prossimo 30 giugno su richiesta di Guyana e Gran Bretagna, la Corte Internazionale di Giustizia (CIJ) deciderà se procede o no alla richiesta venezuelana di 159.542 km2 sottratti dalla Corona Britannica nel 1899″.
Il cancelliere, Jorge Arreaza, ha informato che il Venezuela “conformemente alla sua posizione storica e in stretta coerenza con l’Accordo di Ginevra del 1966, non assisterà all’insolita e irregolare udienza convocata dalla CIJ su richiesta unilaterale della Guyana”.
“Vogliono spogliarci definitivamente della Guayana Esequiba, questo è il piano: accerchiare il nostro sbocco al mare da quella parte“, spiega María Alejandra Díaz. Dietro il tentativo di prendersi il territorio in disputa, ci sono le multinazionali: “dietro la Guayana ci sono oltre 12 multinazionali visibili, e hanno già consegnato concessioni in maniera illegittima”.Una di quelle multinazionali è l’impresa petrolifera Exxon Mobile, con la quale si è creato un incidente a dicembre del 2018 quando la Marina Bolivariana ha intercettato due delle sue navi, inviate dal governo della Guayana, che si trovavano illegalmente in acque venezuelane.
I tempi
Come si misurano perciò i risultati della strategia statunitense? Il saldo è negativo se si guarda alla figura politica di Guaidó e alla permanenza di Nicolás Maduro al governo. Però Guaidó è un pezzo temporaneo, un accidente politico: la sua designazione come “presidente incaricato” è stata per una serie di coincidenze, non per le sue qualità né per la sua proiezione nel futuro.
Al contrario, i tentativi di spoliazione dell’oro, fondi e territori non sono disegnati per essere temporanei. Ed è lì dove la strategia avanza nel suo pieno per tentare di usurpare beni dello Stato.
Si tratta di un’organizzazione di attori visibili e invisibili: governi, giudici, avvocati, multinazionali, operatori politici, che, congiuntamente, si muovono tra le acque dell’embargo economico e l’assalto al potere, per ripartirsi i beni del paese, ridisegnarlo oggi e nel futuro.
Guaidó ha ancora un suo ruolo in questo schema come ingranaggio per giustificare legalmente, per esempio, il possibile sequestro definitivo dell’oro nella Banca d’Inghilterra. Il Governo fantasma che dice di capeggiare è in realtà una legittimazione del furto che stanno concretizzando.
Trump pensa di cambiare strategia verso il Venezuela, come si è vociferato?
Risulta difficile affermarlo, in particolare perché le sue dichiarazioni sono oggi, più che mai, marcate dalla campagna elettorale. Quello che è sicuro è che il meccanismo di spoliazione sta dando frutti e che, a meno di cinque mesi dalla contesa presidenziale non farà un cambiamento pubblico di politica che gli metta a rischio i voti.
Fonte
Juan Guaidó è a un punto politico morto. Non riesce a recuperare iniziativa, convincere, disfarsi dei fascicoli sulla malversazione di fondi che lo circondano. Il trascorrere delle settimane e dei mesi lo rimpiccolisce, e già rimane poco o niente del ricordo del suo passaggio per il Congresso statunitense e la Casa Bianca all’inizio di questo 2020.
Vista in questi termini, la performance del “presidente incaricato” è un fallimento. L’istituzione parallela e virtuale non raggiunge la sua finalità politica. La stessa cosa è accaduta con il “Tribunale Supremo di Giustizia in esilio”, del quale ormai non si ha quasi più memoria, o la “PM generale in esilio”, senza rilevanza alcuna.
Risulta quindi plausibile l’affermazione di John Bolton, ex consigliere di Sicurezza, che nel suo libro “The Room Where It Happened” ha scritto che il presidente Donald Trump ha manifestato dubbi circa le capacità e le attitudini di Guaidó.
È perciò logico che lo stesso Trump abbia lasciato intravedere in un’intervista recente, pubblicata sul portale Axios, i suoi dubbi su Guaidó. E perché non dovrebbe averli su uno che non ha ottenuto una sola vittoria interna da quando è stato riconosciuto/nominato dalla sua amministrazione il 23 gennaio 2019?
Visto così risulta chiaro che Guaidó a volte è più un problema che altro. A questo si devono aggiungere le sue apparizioni e fallimenti golpisti, come quello del 30 aprile del 2019, o i suoi legami con i mercenari dell’Operazione Gedeón che sono arrivati in Venezuela nello scorso mese di maggio.
Ma Guaidó può essere analizzato in altra maniera: non per il suo risultato politico immediato e interno, ma come ingranaggio di un meccanismo di spoliazione. Guaidó, con la sua nomina a presidente incaricato del Venezuela da parte degli USA, ha permesso che, in suo nome, fossero messe in moto ruberie sui beni della Nazione. E qui non si tratta più di un fallimento per gli USA.
La spoliazione
“All’interno Guaidó è sminuito, credo che Trump non abbia mai creduto in lui, invece è servito per la strategia di spoliazione, a livello internazionale continuano ad avanzare e continuano ad accerchiarci”, spiega a Sputnik María Alejandra Díaz, avvocata, deputata dell’Assemblea Nazionale Costituente.
Quel furto si è fatto evidente fin dall’inizio del riconoscimento di Guaidó come “presidente incaricato”. Il 25 gennaio, due giorni dopo la sua auto-proclamazione, il segretario di Stato, Mike Pompeo, ha dato autorità a Guaidó “per ricevere e controllare certe proprietà in conti del Governo del Venezuela o della Banca Centrale del Venezuela (BCV) in possesso della Banca della Riserva Federale di New York o qualsiasi altra banca assicurata negli USA”.
Il 28 gennaio 2019 la Casa Bianca ha emesso l’ordine esecutivo 13.850, centrato su Petróleos de Venezuela (PDVSA) e la BCV, che ha bloccato “tutti i beni e gli interessi di proprietà di PDVSA soggetti alla giurisdizione degli USA”. Il 5 agosto del 2019, ha emesso l’ordine esecutivo 13.884 che ha bloccato tutti i fondi venezuelani nel suo territorio.
Questi conti e fondi sono rimasti in gestione statunitense, e questo è stato reso manifesto con lo scandalo suscitato poche settimane fa quando è stata diffusa la notizia che Donald Trump ha utilizzato 601 milioni di dollari di quei fondi per costruire il muro alla frontiera con il Messico.
Il piano di spoliazione si è posto vari obiettivi centrali al fine di rubare e ripartirsi ricchezze dello Stato venezuelano. Uno di quegli obiettivi è l’impresa raffinatrice CITGO, filiale di PDVSA negli USA, l’oro appartenente alla BCV che si trova nella Banca d’Inghilterra, e, approfittando di questo momento d’assedio, di reclamare il territorio della Guayana Esequiba.
CITGO
L’impresa filiale di PDVSA negli USA è sotto embargo del Dipartimento del Tesoro da agosto del 2019, e la possibilità che sia spezzettata e consegnata ad imprese straniere è stata presente fin dall’inizio della sua appropriazione da parte del Governo statunitense.
Si tratta di uno dei maggiori attivi venezuelani all’estero, valutato in circa 8.000 milioni di dollari, con una struttura di tre raffinerie con capacità vicina ai 749.000 barili giornalieri, e circa 6.000 stazioni di servizio distribuite in franchising nel paese.
Due imprese cercano di appropriarsi di CITGO per farsi pagare quello che, secondo loro, gli deve lo Stato venezuelano: l’industria mineraria canadese Crystallex, e la petrolifera statunitense, ConocoPhillips.
Guaidó ha messo alla “Procura Generale” del suo “Governo”, cioè quelli che devono rappresentare e difendere giudizialmente gli interessi della Repubblica nelle questioni internazionali, José Ignacio Hernández, che era stato avvocato della Cristallex.
Così, mentre da un lato Guaidó affermava di difendere la CITGO, dall’altro, è stato parte di una strategia di verdetti a favore delle imprese straniere. María Alejandra Díaz segnala che si tratta della strategia degli “studi legali che sono alleati con Guaidó, USA e le multinazionali, per spogliare il Venezuela“.
Questo è stato denunciato dal Governo del Venezuela, che ha segnalato come Hernández – che ha rinunciato all’incarico giorni dopo – ha lavorato insieme al direttore della Banca Mondiale (BM), David Malpass, perché il Centro Internazionale per il Regolamento delle Controversie relative ad Investimenti (n.d.t.: sigla in inglese International Centre for Settlement of Investment Disputes – ICSID. In spagnolo CIADI) dipendente dalla Banca, riconoscesse il “Governo di Guaidó” per portare avanti gli arbitraggi.
Questo processo di rapina di CITGO e consegna a imprese straniere è in tappa avanzata: il 22 maggio un giudice della Corte Federale degli USA ha proceduto ad autorizzare la liquidazione di CITGO affinché la Crystallex si prenda quello che afferma le sia dovuto.
Invece, esiste una risoluzione del Dipartimento del Tesoro che proibisce la vendita di CITGO. La possibilità che la filiale di PDVSA sia messa all’asta e perduta dipende dunque centralmente dalla decisione del governo statunitense.
L’oro
La BCV ha, come varie banche centrali, oro conservato nella Banca d’Inghilterra. Alla fine del 2018 ha effettuato la richiesta per recuperare 30 tonnellate. Il Governo britannico, in vista del suo riconoscimento al “Governo provvisorio di Guaidó” ha negato la richiesta e, in maniera illegale, si è tenuta l’oro.
La posizione diplomatica del Regno Unito è stata senza dubbio ambigua: hanno riconosciuto Guaidó, ma hanno ricevuto la sua “ambasciatrice”, Vanessa Neumann, senza le credenziali formali. Vale a dire che si è costruita una zona grigia, di riconoscimento incompleto – come in numerosi paesi, a differenza degli USA – che, in caso di un conflitto come quello di chi deve tenere l’oro, non permette di avanzare verso una risoluzione.
Di fronte a questa situazione, e in vista del fatto che la BCV ha fatto reclamo legale davanti a un tribunale di Londra nel maggio di quest’anno, la giustizia britannica ha iniziato, lunedì 22 giugno un dibattito per determinare se si riconoscerà alla BCV del Governo venezuelano o a una commissione nominata ad hoc da Guaidó. Chi terrà l’oro dipenderà da quel risultato.
Il Governo venezuelano ha proposto che l’ammontare dell’oro reclamato – circa 1.000 milioni di dollari – sia direttamente trasferito al Programma di Sviluppo delle Nazioni Unite per occuparsi della situazione della pandemia e dell’emergenza umanitaria nel paese.
La risoluzione della Giustizia britannica ricadrà non solamente sull’oro nella Banca d’Inghilterra, ma sarà un punto di riferimento per ulteriori casi in disputa, come i 120 milioni di dollari appartenenti alla BCV che si tiene la Deutsche Bank, o numerosi conti congelati in differenti banche.
“L’oro in Inghilterra se lo ruberanno apertamente, si terranno i conti, come hanno fatto con la Libia, quello che non hanno potuto rompere internamente lo stanno facendo internazionalmente, ci vogliono prosciugare di tutti i beni di proprietà della Repubblica per ripartirseli tra le multinazionali, che sono il vero potere che sta dietro i governi negli USA e in Inghilterra”, spiega María Alejandra Díaz.
Guayana Esequiba
La Costituente segnala un’altro fronte di tentativo di spoliazione: la Guayana Esequiba, territorio reclamato dal Venezuela. “Il prossimo 30 giugno su richiesta di Guyana e Gran Bretagna, la Corte Internazionale di Giustizia (CIJ) deciderà se procede o no alla richiesta venezuelana di 159.542 km2 sottratti dalla Corona Britannica nel 1899″.
Il cancelliere, Jorge Arreaza, ha informato che il Venezuela “conformemente alla sua posizione storica e in stretta coerenza con l’Accordo di Ginevra del 1966, non assisterà all’insolita e irregolare udienza convocata dalla CIJ su richiesta unilaterale della Guyana”.
“Vogliono spogliarci definitivamente della Guayana Esequiba, questo è il piano: accerchiare il nostro sbocco al mare da quella parte“, spiega María Alejandra Díaz. Dietro il tentativo di prendersi il territorio in disputa, ci sono le multinazionali: “dietro la Guayana ci sono oltre 12 multinazionali visibili, e hanno già consegnato concessioni in maniera illegittima”.Una di quelle multinazionali è l’impresa petrolifera Exxon Mobile, con la quale si è creato un incidente a dicembre del 2018 quando la Marina Bolivariana ha intercettato due delle sue navi, inviate dal governo della Guayana, che si trovavano illegalmente in acque venezuelane.
I tempi
Come si misurano perciò i risultati della strategia statunitense? Il saldo è negativo se si guarda alla figura politica di Guaidó e alla permanenza di Nicolás Maduro al governo. Però Guaidó è un pezzo temporaneo, un accidente politico: la sua designazione come “presidente incaricato” è stata per una serie di coincidenze, non per le sue qualità né per la sua proiezione nel futuro.
Al contrario, i tentativi di spoliazione dell’oro, fondi e territori non sono disegnati per essere temporanei. Ed è lì dove la strategia avanza nel suo pieno per tentare di usurpare beni dello Stato.
Si tratta di un’organizzazione di attori visibili e invisibili: governi, giudici, avvocati, multinazionali, operatori politici, che, congiuntamente, si muovono tra le acque dell’embargo economico e l’assalto al potere, per ripartirsi i beni del paese, ridisegnarlo oggi e nel futuro.
Guaidó ha ancora un suo ruolo in questo schema come ingranaggio per giustificare legalmente, per esempio, il possibile sequestro definitivo dell’oro nella Banca d’Inghilterra. Il Governo fantasma che dice di capeggiare è in realtà una legittimazione del furto che stanno concretizzando.
Trump pensa di cambiare strategia verso il Venezuela, come si è vociferato?
Risulta difficile affermarlo, in particolare perché le sue dichiarazioni sono oggi, più che mai, marcate dalla campagna elettorale. Quello che è sicuro è che il meccanismo di spoliazione sta dando frutti e che, a meno di cinque mesi dalla contesa presidenziale non farà un cambiamento pubblico di politica che gli metta a rischio i voti.
Fonte
Iscriviti a:
Commenti (Atom)


